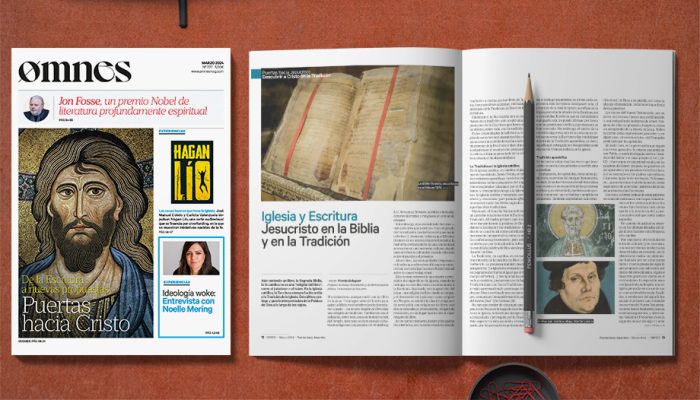Nel nostro tempo, una concezione individualistica della libertàL'idea di libertà, che si è sviluppata soprattutto nei corridoi delle università americane, ha identificato l'idea di libertà con la capacità di scegliere.
Secondo questa visione, una vera e propria caramella avvelenata, l'aumento della libertà umana consiste esclusivamente nella creazione di nuovi spazi di scelta. Sono più libero se posso lavorare in qualsiasi Paese dell'Unione Europea che se posso farlo solo nel mio Paese; se posso cambiare sesso quando lo decido che se non posso, o se posso sposare una o più persone appartenenti a uno dei diversi generi affettivi (bisessuale, pansessuale, polisessuale, asessuale, onnisessuale, ecc.) che se è possibile solo l'opzione eterosessuale. Una donna che può decidere di interrompere una gravidanza in piena libertà per motivi illimitati (economici, psicologici, estetici) è considerata più libera rispetto a chi deve giustificarli o rifiutare del tutto l'aborto, a chi può decidere se assumere o meno droghe rispetto a chi non può farlo o a chi può distribuire pornografia senza alcuna restrizione.
Portata alle sue ultime conseguenze, questa visione individualistica della libertà culmina quando lo spazio della propria libertà è conquistato, cioè quando si può decidere di porre fine alla propria vita e quindi alla propria capacità di decidere. In questo modo, il cerchio si chiude perfettamente.
Libertà e indipendenza
Questa visione miope della libertà si basa su un'etica che il suo grande sostenitore, il filosofo americano Ronald Dworkin, ha definito indipendenza etica.. L'indipendenza etica garantisce l'assoluta sovranità personale nell'ambito di quelle che Dworkin chiama questioni fondamentali (vita, sesso, religione, tra le altre), cosicché, in queste materie, una persona non dovrebbe mai accettare il giudizio di un altro al posto del proprio. È qui che risiede la sua dignità.
Per attuare questo modello sociale, le autorità pubbliche devono astenersi dal dettare ai cittadini convinzioni etiche su cosa sia meglio o peggio per ottenere una vita di successo. Poiché la libertà è una questione fondamentale, nessun governo dovrebbe limitarla se non quando è necessario per proteggere la vita (non embrionale, non terminale), la sicurezza o la libertà degli altri (soprattutto per imporre la non discriminazione). Questa concezione individualista cerca a tutti i costi di sradicare qualsiasi tipo di paternalismo etico che possa favorire una scelta rispetto ad altre.
Alla fine Dworkin è caduto involontariamente nella sua stessa trappola. La sua richiesta che le autorità pubbliche si astengano dall'imporre convinzioni etiche ai loro cittadini costituisce, di per sé, l'imposizione di una convinzione etica. A parte questo errore strutturale, che danneggia i pilastri della sua stessa costruzione intellettuale, mi sembra che questo modo di intendere la libertà e l'etica che la sostiene sia enormemente riduzionista, impoverendo così il significato stesso di libertà e moralità. Inoltre, la presunta neutralità etica ricercata da Dworkin è impossibile da raggiungere, data l'intrinseca connessione tra morale e politica.
È vero che la libertà di scelta è una delle espressioni più importanti della nostra libertà umana e come tale deve essere protetta, anche se non in modo assoluto, ma la libertà è più, molto più, della semplice scelta. La libertà si trova anche, e credo in uno stato più puro e sublime, nella capacità di accettare.
In chiave di accettazione
Chi accetta i propri genitori e fratelli, la propria terra e cultura, la propria lingua e storia, la propria malattia, il proprio licenziamento, anche se non lo ha deciso, agisce con una meravigliosa libertà. Agisce con grande libertà chi accetta il fatto di essere nato senza che gli sia stato chiesto, e di lasciare questo mondo senza conoscerne il momento preciso. L'accettazione della realtà così com'è, e soprattutto l'accettazione della realtà fondante, cioè di Dio, della sua paternità e della sua misericordia, è, a mio avviso, il più grande atto di libertà umana, e quello che spalanca le porte dell'Amore.
La visione individualista scollega la libertà dal bene comune, dalla solidarietà e dall'amore. Esiste una connessione intrinseca tra il bene privato e il bene comune, tra la morale privata e quella pubblica, tra l'amore per sé e l'amore per gli altri, perché l'unità dell'amore, del bene e quindi della morale è indistruttibile. Viene dalla fabbrica. Questa unità di amore e di bene significa che il giusto esercizio della libertà è chiaramente solidale, anche se le decisioni possono essere prese su base individuale. Pertanto, una visione solidale della libertà non riduce in alcun modo la libertà individuale, ma piuttosto la potenzia, perché consente un processo decisionale più ampio, pensando al bene degli altri, della comunità politica, dell'umanità, e non solo ai propri interessi. È una libertà fondata sull'amore, che è la fonte della libertà.
Il XXI secolo è stato definito il secolo della solidarietà, così come il XX secolo è stato il secolo dell'uguaglianza e il XIX secolo il secolo delle libertà. È giunto il momento di sviluppare un quadro di riferimento per un'autentica libertà solidale, che è la massima espressione del corretto esercizio della libertà individuale.