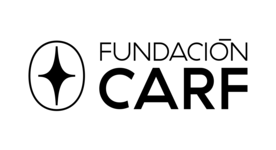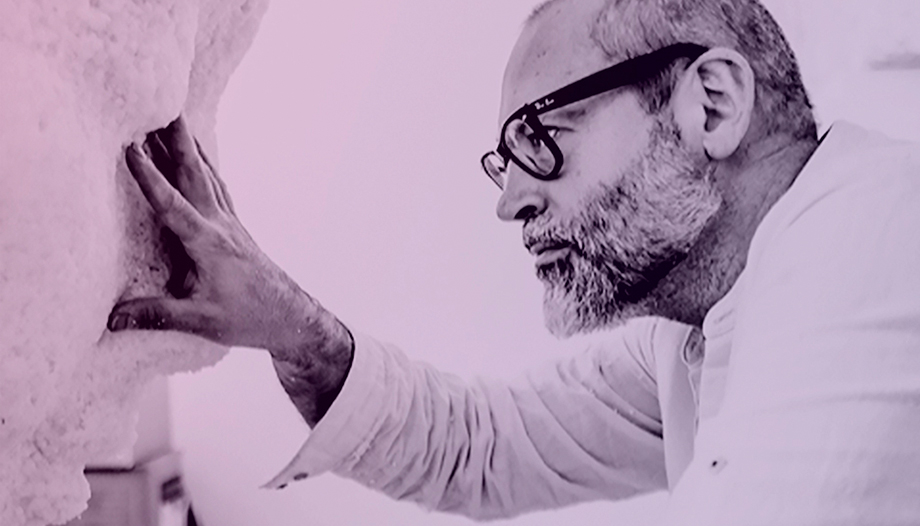Francis è riuscito a fare la sua 37ª trasferta internazionale nonostante i problemi al ginocchio.
Alder, seminarista nicaraguense: "Il Papa ci ha chiesto di essere coraggiosi".
Alder Harol Álvarez Maltez è un seminarista di 23 anni, originario del Nicaragua, che risiede nel Seminario Internazionale di Bidasoa e studia all'Università di Navarra. Proviene da una famiglia cattolica e ha una sorella minore.
Grazie a una sovvenzione del Fondazione Centro Accademico Romano (CARF), ha potuto studiare presso l'Università Cattolica Redemptoris Mater (Unica), la laurea in Relazioni Internazionali e Commercio Internazionale e si è laureato nel 2019 con buoni risultati accademici. Tuttavia, la vocazione al sacerdozio è sempre stata una costante dentro di lui, un seme che cresceva a poco a poco.
La svolta è avvenuta nel 2019 durante l'11° Forum Internazionale dei Giovani, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
"I partecipanti a questo incontro hanno avuto l'opportunità di ascoltare il Santo Padre, e nelle sue parole il Papa ci ha chiesto di essere coraggiosi e, senza paura, di donarci al servizio del Signore. Quelle parole sono state l'impulso finale che mi ha spinto a fare il passo definitivo per entrare in seminario e lasciare la mia carriera professionale", racconta Alder.
Il suo vescovo lo mandò a Bidasoa. "C'è una meravigliosa ricchezza in questo Seminario. Vivere con seminaristi di diversi Paesi è un'esperienza che arricchisce la mia formazione spirituale, intellettuale e culturale. Per questo motivo, vorrei ringraziare i benefattori per il grande sostegno che ci danno. Siate certi che sono sempre nelle nostre preghiere e che tutto ciò che fanno sarà messo a frutto per la missione evangelizzatrice della Chiesa.
Alder, preoccupato per il suo Paese, spiega che il Nicaragua ha bisogno di sacerdoti fermamente impegnati nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Pastori che, con coraggio e amore, annunciano il messaggio di salvezza di Cristo e che, in spirito di verità, si battono per ciò che è giusto di fronte all'ingiustizia.
"Seguendo l'esempio datoci dai vescovi, tutta la Chiesa nicaraguense deve mettersi al servizio delle necessità del popolo, sapendo soffrire con la gente e accompagnandola nei momenti importanti e difficili. La povertà, la disuguaglianza e la mancanza di libertà individuali e collettive sono alcune delle grandi sfide sociali che il Paese deve affrontare", conclude.
Dottrina sociale, Sant'Anna e San Francesco di Laval: seconda tappa del viaggio papale
Francesco ha cercato di infondere speranza agli indigeni, ottimismo ai sacerdoti e dottrina sociale ai politici, nella tappa francofona del suo pellegrinaggio penitente.
 "Camminiamo insieme, arrivederci in Canada". Le storiche scuse del Papa agli indigeni canadesi.
"Camminiamo insieme, arrivederci in Canada". Le storiche scuse del Papa agli indigeni canadesi. Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare".
Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare". I gesti di Papa Francesco in Canada
I gesti di Papa Francesco in CanadaPapa Francesco continua la sua visita in Canada, che lui stesso ha definito un pellegrinaggio penitenziale. In questa seconda tappa nella provincia del Québec, il Papa ha incontrato le autorità canadesi, ha celebrato la Santa Messa per gli indigeni e altri pellegrini in un santuario a Beaupré e ha tenuto i vespri con il clero e gli operatori pastorali. Oggi conclude la sua visita in questa provincia in gran parte francofona e vola a Iqaluit.
Masterclass sulla dottrina sociale
Il Papa ha ascoltato prima il Primo Ministro Justin Trudeau e poi il Governatore Generale Inuit Mary Simon (in rappresentanza della Regina Elisabetta II e seduta alla destra del Pontefice - nel cuore del Quebec autonomista).
Francesco ha tenuto una masterclass sulla dottrina sociale della Chiesa. È successo il 27 luglio alle 17.00, prima che Bergoglio si tuffasse con la sua papamobile in un bagno di folla - le migliaia di appassionati che lo seguivano su un maxischermo nel parco storico della Piana di Abramo (dove nel 1759 gli inglesi sconfissero definitivamente i francesi). Il discorso del capo di Stato vaticano è stato pronunciato in un'atmosfera protocollare. Era chiaro che il Papa aveva fatto i compiti a casa. Voleva ispirarsi al simbolo canadese per eccellenza, la foglia d'acero.
Già "le popolazioni native estraevano dagli aceri la linfa da cui ricavavano sciroppi nutrienti. Nella loro operosità erano attenti alla salvaguardia della terra e dell'ambiente, fedeli a una visione armonica del creato... che insegna all'uomo ad amare il Creatore e a vivere in simbiosi con gli altri esseri viventi. C'è molto da imparare dalla loro capacità di ascoltare Dio, le persone e la natura. Ne abbiamo bisogno ... nell'odierno ... turbine ... caratterizzato da un costante "accelerazione"che ostacola uno sviluppo veramente umano, sostenibile e integrale (cfr. Laudato si'18), generando in definitiva una "società della stanchezza e della disillusione", che ha bisogno della contemplazione, del gusto genuino delle relazioni".
"Le grandi foglie d'acero... assorbono l'aria inquinata e ripristinano l'ossigeno, si meravigliano della bellezza del creato e... i valori sani presenti nelle culture indigene sono un'ispirazione per tutti noi e possono aiutarci a guarire dalle abitudini dannose dello sfruttamento... del creato, delle relazioni, del tempo".
Si è scusato per l'ennesima volta, deplorando le passate politiche di assimilazione, disimpegno e deculturazione (il neologismo è mio). Ha ribadito che "è tragico quando alcuni credenti, come è accaduto in quel periodo storico, non si conformano al Vangelo ma alle convenienze del mondo". Era un sistema deplorevole promosso dalle autorità governative dell'epoca" e non dalle Chiese cattolica, anglicana e presbiteriana (si capisce).
Inoltre, il professore di filosofia politica ha fatto due osservazioni. In primo luogo, i cristiani hanno fatto anche molto bene. La fede ha svolto un ruolo essenziale nella formazione dei più alti ideali canadesi. In secondo luogo, che le autorità di oggi possono peccare allo stesso modo. Naturalmente ha detto tutto in modo molto diplomatico, ma è risaputo che l'indice indica il dito medio, l'anulare e il mignolo.
Citando il suo amato Cara AmazoniaIl professore ha tenuto una lezione ai presenti, accusatori del passato, sull'attuale colonizzazione ideologica. Oggi "non mancano le colonizzazioni ideologiche che... soffocano il naturale attaccamento ai valori dei popoli, cercando di sradicare le loro tradizioni, la loro storia e i loro legami religiosi". È una mentalità che presume di aver superato "le pagine buie della storia"".
Ad esempio, in Québec si parla spesso di la grande noirceur prima del 1960. Questa mentalità dà origine alla cultura della cancellazione, che giudica il passato solo in funzione di alcune categorie attuali. Si afferma così una moda culturale che uniforma tutto e non tollera le differenze, che si concentra solo sul momento presente, sui bisogni e sui diritti dei singoli: trascura i doveri verso i più deboli e fragili: i poveri, i migranti, gli anziani, i malati, i non nati! Il Canada è l'unico Paese al mondo, per quanto ne so, a non regolamentare l'aborto, cioè a consentire la legge della giungla su questo tema. Non solo, ma si vanta di esportare l'aborto e quindi colonizza. Il Papa ha insistito sul fatto che questi deboli sono dimenticati dalle società del benessere e che "nell'indifferenza generale, vengono scartati come foglie secche da bruciare".
Inoltre, come ogni foglia di un albero è essenziale per il ricco e variopinto fogliame della foresta, così anche la società non deve essere uniforme ma aperta e inclusiva. Ogni famiglia è la cellula fondamentale della società e il futuro dell'umanità è forgiato nella famiglia. Tuttavia, è minacciata da tutti i tipi di fattori. "Che il male sofferto dai popoli indigeni, e di cui oggi ci vergogniamo, ci serva da monito oggi, affinché la cura e i diritti della famiglia non vengano messi da parte in nome di eventuali esigenze produttive e interessi individuali".
La foglia d'acero ha comunque dato al Papa la possibilità di tenere una lezione sull'ambientalismo (il Canada ottiene un voto molto alto, dice) e sulla follia della guerra e la necessità del disarmo (voto più basso, forse): "Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e di armarci fino ai denti: non saranno la corsa agli armamenti o le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza". In un tweet, Trudeau ha dichiarato di aver parlato ieri con il Papa e il suo Segretario di Stato Pietro Parolin di questioni come l'Ucraina e l'insicurezza alimentare. Il governo del Partito Liberale di Trudeau dà talvolta l'impressione di seguire i sondaggi. Lo ha detto anche il Papa: "La politica non può rimanere prigioniera di interessi di parte. Dobbiamo saper guardare, come insegna la saggezza indigena, alle sette generazioni a venire, non alle convenienze immediate, alle scadenze elettorali o all'appoggio delle lobby. E anche per valorizzare il desiderio di fraternità, giustizia e pace delle giovani generazioni". Ha ricordato che la Chiesa cattolica si prende cura dei più fragili e opera a favore della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale.
Pellegrinaggio a Sainte-Anne-de-Beaupré
Nel 1658 la nave di alcuni marinai bretoni affondò al largo delle coste della Nuova Francia, l'odierno Quebec. Promisero a Sant'Anna che se si fossero salvati le avrebbero costruito una cappella, che fu all'origine dell'attuale Basilica, costruita nel secolo scorso. Gli indigeni si sono subito innamorati della nonna di Gesù, e questa mattina il Papa l'ha guardata a lungo, come un nipote devoto. Mentre lo faceva dalla sua sedia a rotelle alla fine della messa di riconciliazione, una donna indigena è salita spontaneamente sull'altare e gli ha messo in braccio il figlioletto visibilmente deforme. Momento iconico.
Omnes ha parlato oggi con due pellegrini che hanno visitato la Basilica per la prima volta, entrambi provenienti dalla provincia dell'Ontario con un viaggio in auto di oltre dieci ore. Tiffany Taylor, giovane assistente sociale di origine Ojibway, è andata con una dozzina di indigeni di una riserva della città di Sudbury, nessuno dei quali cattolico. "La mia lingua è conservata, ma non la parlo. Oggi viene insegnato nelle scuole, anche ai non nativi. Vicino a noi c'era un collegio cattolico. Mi fa male quello che hanno sofferto i miei antenati torturati". Settanta % dei presenti all'interno della Basilica erano autoctoni. Migliaia di altre persone, con biglietti gratuiti ma difficili da ottenere, si sono radunate all'esterno.

Padre Scott Giuliani, SOLT, è missionario canadese in Belize dal 2014. Si è recato a Sant'Anna dalla vicina Toronto. "Negli ultimi anni nell'area caraibica c'è stata una crescente influenza da parte dei Paesi ricchi che spingono per introdurre valori estranei alla popolazione. Nuove definizioni dei diritti umani basate su una nuova antropologia, non sul diritto naturale. L'ideologia di genere e le pressioni per modificare la legislazione locale sono esempi di colonizzazione ideologica in atto. Questa intrusione di idee causa molti danni alla cultura. In Belize, il governo canadese ha utilizzato alcuni dei suoi aiuti esteri per esportare valori ideologici".

Il Papa, nel predicare, ha osservato che la sua omelia potrebbe essere intitolata: "Dal fallimento alla speranza". Ha commentato l'episodio alla fine del Vangelo di Luca in cui due discepoli disillusi di Gesù fuggono da Gerusalemme. Ha detto che Cristo risolve le nostre tragedie attraverso il suo mistero pasquale. È l'unico modo per andare avanti in situazioni come la storica colonizzazione dei popoli indigeni. Il risentimento non guarisce. Dobbiamo evitare di accusarci a vicenda, come Adamo ed Eva dopo il peccato, o di avere una discussione sterile, come i due camminatori. L'unica via d'uscita, se si vuole una vera riconciliazione, è quella che Gesù spiega ai suoi due discepoli. Cristo ci dà una via d'uscita dal labirinto della nostra storia. L'Eucaristia guarisce. Emmaus mostra la tentazione di fuggire - che è fuga, non risoluzione. Gesù è venuto a camminare con noi.
"Non c'è niente di peggio, di fronte alle difficoltà della vita, che fuggire da esse. È una tentazione del nemico, che minaccia il nostro cammino spirituale e il cammino della Chiesa; vuole farci credere che la sconfitta è definitiva, vuole paralizzarci con l'amarezza e la tristezza, convincerci che non c'è niente da fare e che quindi non vale la pena di trovare un modo per ricominciare".
"Noi che condividiamo l'Eucaristia in questa Basilica possiamo anche rileggere molti eventi della storia. In questo stesso luogo c'erano già tre chiese, ma c'erano anche persone che non si sono tirate indietro di fronte alle difficoltà, e sono state capaci di sognare ancora nonostante i loro errori e quelli degli altri. Così, quando cento anni fa un incendio devastò il santuario, non si lasciarono sconfiggere, costruendo questa chiesa con coraggio e creatività. E tutti coloro che condividono l'Eucaristia dalla vicina Piana di Abramo (tramite schermo gigante), possono anche percepire lo spirito di coloro che non si sono lasciati rapire dall'odio della guerra, dalla distruzione e dal dolore, ma che hanno saputo progettare una città e un Paese nuovi". Si riferisce alla città di Québec e al Paese del Canada, costruiti pacificamente dal 1759.

Iniezione di ottimismo per vescovi e sacerdoti
Infine oggi, nella Cattedrale di Notre-Dame di Québec, il Papa ha messo il dito sul più grande ostacolo alla rievangelizzazione del Canada - e in particolare del Québec, un tempo bastione del cattolicesimo dalla sua fondazione esplicitamente missionaria nel 1608 fino agli anni Sessanta. Francesco ha tenuto un'omelia durante i vespri a quasi un centinaio di vescovi, molti altri sacerdoti e altre persone, e ha parlato loro del secolarismo. Che non è vero che tutti i tempi passati erano migliori.
Il Papa ha ricordato che questa era la cattedrale della sede primate del Canada, il cui primo vescovo, San Francesco di Laval, aprì il Seminario nel 1663. Ha parlato loro della responsabilità del pastorale e dell'evangelizzazione, che porta sempre gioia. Non c'è bisogno di essere funzionari del sacro. Li ha incoraggiati a predicare un Gesù vivo in modo vivace, a essere testimoni credibili, a evitare a tutti i costi una tentazione diabolica molto attuale: quella del pessimismo negativo. La mondanità è cattiva, ma il mondo è buono. Ha parlato di umiltà e, in modo particolare, di fraternità.
La prima cosa è "far conoscere Gesù". Nei deserti spirituali del nostro tempo, generati dal secolarismo e dall'indifferenza, è necessario tornare al primo annuncio". Ha citato il filosofo di Montreal Charles Taylor: la secolarizzazione è "l'opportunità di ricomporre la vita spirituale in nuove forme e anche per nuovi modi di esistere".
"In questo modo", ha proseguito Bergoglio, "mentre lo sguardo discernente ci fa vedere le difficoltà che abbiamo nel trasmettere la gioia della fede, ci stimola a riscoprire una nuova passione per l'evangelizzazione, a cercare nuovi linguaggi".
Ha concluso come segue. "Per favore, non chiudiamoci nella "regressione", andiamo avanti con gioia! Mettiamo in pratica le parole che abbiamo rivolto a San Francesco di Laval:
Sei stato l'uomo della condivisione, visitare i malati, vestire i poveri, lotta per la dignità dei popoli indigeni, sostenere i missionari affaticati, sempre pronto a tendere la mano a chi stava peggio di te. Quante volte i vostri progetti sono andati in frantumi, ma sempre, li rimettete in piedi. Avevate capito che l'opera di Dio non è fatta di pietra, e questo, in questa terra di sconforto, era necessario un costruttore di speranza.
Vi ringrazio per tutto quello che fate e vi benedico di cuore. Per favore, continuate a pregare per me". È seguita un'ovazione davvero emozionante.
Le finanze vaticane: come funzionano e quali sono i loro organi
Non è facile capire come funzionano le finanze vaticane. Le modifiche apportate negli ultimi anni hanno creato alcuni nuovi organi di controllo. In questo articolo spieghiamo quali sono gli enti che gestiscono il patrimonio vaticano e quali sono le responsabilità di ciascuno.
 Per cosa sono stati spesi i soldi dell'Obbligo di San Pietro?
Per cosa sono stati spesi i soldi dell'Obbligo di San Pietro? Arriva una legge cruciale per la riforma della Curia: la gestione finanziaria
Arriva una legge cruciale per la riforma della Curia: la gestione finanziaria Nuova legge vaticana anticorruzione: vietati i regali superiori a 40 euro
Nuova legge vaticana anticorruzione: vietati i regali superiori a 40 euroNon è facile districarsi tra le pieghe delle finanze vaticane. Certamente, le ultime riforme introdotte da Papa Francesco richiedono un costante aggiornamento. Si cambiano le competenze e la gestione degli uffici, si ridisegnano i dicasteri e si ridefinisce persino chi e come gestisce il denaro. Ma come sono nate le finanze del Papa, come sono state strutturate nel corso della storia e come vengono gestite oggi?
Le origini della moderna finanza vaticana
Appena un giorno dopo la morte di Pio XI, il 10 febbraio 1939, monsignor Angelo Pomata si presentò a un banco delle "Opere di Religione". Il cassiere era Massimo Spada. Pomata si trovava lì per ordine di Eugenio Pacelli, che aveva assunto la carica di Camerlengo alla morte del Papa. Pacelli - che sarebbe stato eletto Papa nel conclave successivo - aveva ordinato a monsignor Pomata di depositare il denaro trovato nel cassetto della scrivania del Papa, in lire e dollari.
Spada aprì un conto, sotto il nome di "Segreteria di Stato - Obolus New Accounts". La storia delle moderne finanze vaticane inizia lì. Attraverso questo conto corrente, e poi attraverso la piena autonomia dell'"Istituto di Opere di Religione" - la cosiddetta "banca vaticana", che in realtà è più simile a un fondo fiduciario - i fondi potrebbero essere messi a disposizione del Papa a sua discrezione. Fondi con cui rimpinguare il bilancio della Santa Sede, come è accaduto di recente. O fondi da destinare in beneficenza. Oppure i fondi - e questo è stato il caso di Pio XII - devono passare attraverso canali sicuri, per aiutare le operazioni di mantenimento della pace.
Lo Stato del Vaticano
Se il cosiddetto "Conto Onbolo"L'Istituto per le Opere di Religione è stato fondato qualche anno prima che la Santa Sede iniziasse a dotarsi di strumenti finanziari. Dal 1870 al 1929, dopo che Roma fu invasa dal Regno d'Italia, la Santa Sede non ebbe alcun territorio. Ma nel 1929, con la Conciliazione e la firma dei Patti Lateranensi, era stato creato lo Stato della Città del Vaticano, "quel grande corpo che serve a sostenere la nostra anima", secondo le parole di Pio XI.
Il governo italiano aveva anche accettato di trasferire una somma alla Santa Sede per compensare il "male" causato dalla perdita dello Stato Pontificio. Pio XI si occupò personalmente delle trattative, fino a concordare un indennizzo da parte dello Stato italiano di 1,75 miliardi di lire, in parte in contanti e in parte in titoli al portatore.
Cosa fare di questo patrimonio? Due mesi dopo la firma dei Patti Lateranensi, e quasi trenta giorni prima della loro ratifica, il Papa contattò l'ingegnere Bernardino Nogara, direttore della Banca Commerciale Italiana, per affidargli la gestione dei fondi della Convenzione finanziaria.
Bernardino Nogara ha portato il concetto di azionariato in Vaticano. Gli fu affidata la Sezione Speciale dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e da quella postazione - analoga a una banca centrale - acquistò azioni, con investimenti cospicui e di successo. Era l'epoca della Grande Depressione del 1929, che permise a Nogara di acquistare azioni di diverse società. Nogara ha così potuto far parte dei consigli di amministrazione di innumerevoli aziende italiane, che hanno accresciuto il suo prestigio internazionale. E proprio durante la Grande Depressione, Nogara creò due società, Grolux e la svizzera Profima, con l'idea di diversificare gli investimenti della Santa Sede, puntando sull'oro e sul mattone.
I poli della finanza vaticana
La Costituzione dello Stato della Città del Vaticano ha così posto le basi per le due principali istituzioni finanziarie della Santa Sede: l'Istituto per le Opere di Religione e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
Il primo è generalmente noto come "Banca Vaticana"Ma non è una vera e propria banca, non ha uffici al di fuori del Vaticano e ha ottenuto un IBAN solo di recente, dopo che la Santa Sede è entrata nell'area di trasferimento SEPA, cioè l'Area unica dei pagamenti europei.
Il percorso dello IOR per essere riconosciuto dalle istituzioni estere come controparte affidabile è stato particolarmente lungo, come per tutte le istituzioni finanziarie del mondo. Giovanni Paolo II ha stabilito il nuovo statuto dello IOR nel 1990, mentre la prima revisione contabile esterna risale alla metà degli anni '90.
Negli anni 2000, lo IOR ha attuato una serie di misure innovative, riconosciute anche dai valutatori internazionali di MONEYVAL, il comitato del Consiglio d'Europa che valuta l'adesione degli Stati agli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L'APSA
L'altro polo della finanza vaticana è l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, l'APSA. Ha una funzione simile a quella di una "banca centrale". Fino all'inizio degli anni 2000, l'APSA forniva anche pensioni e aveva conti registrati, ma questi sono stati chiusi per soddisfare meglio gli standard internazionali.
Come "banca centrale", l'APSA ha anche la gestione del patrimonio immobiliare della Santa Sede. Secondo il primo bilancio dell'APSA, pubblicato nel 2021, il Vaticano possiede 4.051 proprietà in Italia e altre 1.120 nel mondo, principalmente in investimenti immobiliari di lusso a Londra, Parigi, Ginevra e Losanna.
"È anche grazie agli affitti di mercato praticati sui prestigiosi immobili di proprietà a Parigi e a Londra, che è possibile concedere all'Ospizio Apostolico un comodato d'uso gratuito di una struttura come Palazzo Migliori, a due passi dal colonnato di San Pietro, per l'accoglienza dei senzatetto accolti dai volontari della Comunità di Sant'Egidio. Inoltre, con l'acquisto di un immobile vicino all'Arco di Trionfo a Parigi, grazie alla mediazione di Sopridex, il venditore ha destinato parte del ricavato di questa operazione alla costruzione di una chiesa in un sobborgo parigino".
Dallo scorso anno, l'APSA gestisce anche i fondi che prima erano gestiti direttamente dalla Segreteria di Stato, e si presume che l'intero apparato vaticano avrà un unico fondo sovrano gestito dall'APSA.
Entità autonome
Oltre all'amministrazione della Segreteria di Stato, esistono altre entità autonome. Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ad esempio, dispone di un proprio bilancio e di proprie risorse, che però non sono state rese note dal 2015. Da tempo è stato previsto un bilancio consolidato che includa quello della Curia, cioè degli organi della Santa Sede, e quello dello Stato, ma non è ancora stato realizzato. Le entrate più importanti del Governatorato sono quelle dei Musei Vaticani e del complesso museale delle Ville Pontificie.
Resta da vedere, tuttavia, se il Dicastero per l'Evangelizzazione erediterà la libertà finanziaria della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Quando il dicastero missionario fu effettivamente istituito con il nome di Propaganda Fide nel 1622, si pensò di dargli autonomia finanziaria, in modo che il denaro potesse affluire direttamente alle missioni. L'ex Propaganda Fide possedeva anche beni immobili, oggi stimati in 957 proprietà tra terreni e fabbricati a Roma.
Va anche ricordato che, in realtà, tutti i dicasteri godevano di autonomia finanziaria, entro certi limiti, perché ricevevano donazioni personali e per scopi personali. Quando il cardinale George Pell, in qualità di Prefetto delle Finanze, parlava di centinaia di milioni di euro nascosti, cioè occultati, in vari conti, parlava proprio delle risorse personali dei dicasteri che potevano amministrare liberalmente. I dicasteri non potevano nemmeno scegliere lo IOR come banca d'investimento, per cui non sorprende, ad esempio, che la Segreteria di Stato abbia investito nel Credit Suisse.
Organismi di vigilanza
L'APSA sta quindi assumendo sempre più il ruolo di una banca centrale e nel 2013 ha subito una piccola riforma che ha modificato il ruolo dei consiglieri, rendendoli parte di un consiglio di vigilanza. La previdenza, la gestione finanziaria e i fondi sovrani saranno nelle mani dell'amministrazione.
La Segreteria per l'Economia è l'organo di controllo delle finanze della Santa Sede. Supervisiona i bilanci, fornisce linee guida di spesa e razionalizza i costi. Il Prefetto della Segreteria per l'Economia è anche membro della Commissione per le questioni riservate, che stabilisce quali atti di natura economica devono essere riservati. La Segreteria per l'Economia ha anche supervisionato la regolamentazione del codice degli appalti del Vaticano.
Vale la pena ricordare che tutte queste decisioni seguono l'adesione della Santa Sede alla Convenzione di Merida, che è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. In seguito a questa adesione, l'ufficio del Revisore generale è ora definito anche come "ufficio anticorruzione" del Vaticano.
Il revisore generale
Il Revisore Generale, ovviamente, è incaricato del controllo, mentre il Consiglio Economico è una sorta di Ministero delle Finanze, il cui compito è quello di dirigere il lavoro finanziario.
In questo caso, la novità sta soprattutto nel nome e nell'approccio, non nella sostanza. Il Segretariato per l'economia era in passato la Prefettura per gli affari economici, riformata nel 2012 e quasi equiparata a un Ministero delle finanze. Il Consiglio dell'Economia era un tempo il Consiglio dei Quindici, cioè dei cardinali chiamati a supervisionare l'approccio finanziario della Santa Sede.
Infine, c'è l'Autorità di vigilanza e di informazione finanziaria. Si tratta di un'autorità di intelligence che ha solo un'entità sotto diretta osservazione, lo IOR. L'Autorità ha il compito di indagare sulle transazioni finanziarie sospette che le vengono segnalate e di presentare le relazioni al Promotore di Giustizia, che deciderà se proseguire o meno l'indagine. L'Autorità svolge inoltre un ruolo cruciale nella cooperazione internazionale, grazie ai rapporti che intrattiene con le sue controparti, tanto da aver contribuito alla risoluzione di alcuni casi internazionali.
La riforma delle finanze voluta da Benedetto XVI ha portato anche, nel 2013, alla creazione di un Comitato di Sicurezza Finanziaria, un organismo che certifica la sovranità della Santa Sede e permette alla Segreteria di Stato (cioè al governo) e ad altre agenzie di lavorare insieme per prevenire il riciclaggio di denaro.
Un impegno coerente verso la missione
Questa è, a grandi linee, la struttura finanziaria della Santa Sede. Nel primo rapporto di MONEYVAL del 2012 si leggeva che il cammino della Santa Sede verso la trasparenza finanziaria era un percorso "coerente con la sua natura e il suo carattere internazionale", oltre che con "la sua missione religiosa e morale". È un impegno importante per essere credibili nel mondo. Per la Chiesa, in fondo, il denaro non è un fine, ma un mezzo, e serve alla missione, che è una missione innanzitutto per gli ultimi.
Obianuju EkeochaRead more : "È meglio dare libri ai bambini che contraccettivi".
Obianuju Ekeocha è presidente di Cultura della vita AfricaL'organizzazione promuove un'autentica cultura della vita in Africa e nel mondo. Nel suo famoso lettera a Melinda Gates ha sottolineato ciò di cui il continente africano e soprattutto le donne africane hanno davvero bisogno: più istruzione e meno politiche contraccettive che, sottolinea, "non sono mai state chieste".
 Mons. Luis ArgüelloLa salute morale di una società è dimostrata dalla sua difesa della vita".
Mons. Luis ArgüelloLa salute morale di una società è dimostrata dalla sua difesa della vita". Migliaia di persone marciano in difesa della vita umana negli USA
Migliaia di persone marciano in difesa della vita umana negli USAOriginario della Nigeria, Obianuju è stato coinvolto in dibattiti sociali e politici legati alla dignità della vita nella cultura africana. È stata inoltre consulente di legislatori in Africa, Europa e Nord America. La sua difesa della vita l'ha portata a parlare in sedi come la Casa Bianca, il Parlamento europeo e la Georgetown University di Washington.
In questa intervista con Omnes, Obianuju Ekeocha sottolinea che le politiche contraccettive imposte in Africa equivalgono, in pratica, a un nuovo colonialismo in cui "ogni aspetto di questo modello è controllato e determinato dal ricco donatore occidentale".
Lei parla di nuovo colonialismo in relazione alle politiche di contraccezione che vengono attuate in Africa, pagate da aziende o governi occidentali. Perché usa questo termine? Qual è il vero obiettivo di queste politiche che impediscono la nascita di tante persone?
- Il termine "neocolonialismo" indica la realtà attuale dei meccanismi di aiuto umanitario che sono completamente controllati dalle nazioni e dalle organizzazioni donatrici.
È noto che la maggior parte dei Paesi africani, a causa delle privazioni socio-economiche, è stata per decenni destinataria di aiuti umanitari e fondi di assistenza allo sviluppo. Questo ha creato uno spazio per le organizzazioni di donatori occidentali che si sono inserite come attori e partner nel sostegno e nello sviluppo dell'Africa.
Il problema è che, negli ultimi anni, i donatori africani si sono presentati con un'agenda chiara e consolidata sull'ideologia e sui punti di vista e valori culturali.
Una delle prime grandi spinte è stata quella per la contraccezione.
Nonostante le comunità africane chiedessero aiuti soprattutto per le necessità di base, come cibo, acqua potabile e accesso all'istruzione, i donatori occidentali in Africa hanno iniziato a imporre al continente enormi quantità di contraccettivi.
Ciò ha comportato un riorientamento dei fondi e forse il depotenziamento di altri progetti, per garantire che la contraccezione e i programmi demografici siano ben finanziati.
Lo definisco neocolonialismo perché ogni aspetto di questo modello è controllato e determinato dal ricco donatore occidentale.
Per quanto riguarda lo scopo di queste politiche di inondazione di contraccettivi nelle comunità africane, credo che si tratti di una combinazione di un tentativo (da parte delle potenze occidentali) di controllare le popolazioni africane e di un tentativo di introdurre una visione molto più "liberata" della sessualità umana. Una sorta di liberismo sessuale che erode il decoro sessuale in tutti gli strati delle società africane.
Oggi ci troviamo di fronte a leggi terribili che incoraggiano la morte. Gli Stati Uniti hanno appena abrogato la Sentenza Roe v. Wade. Per coloro che non sanno cosa c'è dietro questo cambiamento legislativo, cosa significa il ribaltamento di questa sentenza e cosa significa per la promozione di una cultura della vita negli Stati Uniti e nel mondo?
- Per spiegarlo brevemente, Roe v Wade è la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1973 che ha sostanzialmente legalizzato l'aborto in tutti i 50 Stati americani.
Da quella decisione, più di 60 milioni di bambini prematuri sono stati uccisi dall'aborto negli Stati Uniti, causando un cambiamento significativo nella società a causa dei milioni di donne, uomini e anche famiglie che ne sono stati colpiti.
Per quasi 50 anni, la sentenza Roe v Wade non è mai stata messa in discussione fino al 1° dicembre 2021, quando un nuovo caso è stato portato davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti: Dobbs v Jackson Women's Health Organization, un caso che ha portato con successo al rovesciamento della sentenza Roe v Wade del 1973.
Questo risultato contribuisce senza dubbio alla promozione di una vera Cultura della Vita, in quanto rafforza ulteriormente gli sforzi pro-vita per soddisfare e assistere i bisogni delle donne in crisi. Inoltre, pone le basi per smascherare i molti aspetti sgradevoli dell'industria dell'aborto, come l'agevolazione degli abusi, lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori non denunciati, il prelievo e la vendita non etica di organi fetali a società di ricerca biologica, gli aborti illegali a termine e tutti i tipi di avido profitto all'interno dell'industria dell'aborto.
Il rovesciamento della Roe v Wade segna l'inizio della fine dell'aborto come lo conosciamo negli Stati Uniti e nel mondo.
Nella sua famosa lettera a Melinda Gates del 2012, lei indicava ciò che serviva in Africa: assistenza prenatale e postnatale, programmi di alimentazione, ecc. e non i contraccettivi. Queste esigenze sono cambiate in Africa? Sono maggiori o minori?
- Sono passati 10 anni da quando ho scritto la mia lettera aperta a Melinda Gates e, guardando indietro in tutti questi anni, molto è cambiato nel mondo. Ma ciò che non è cambiato, anzi è diventato molto più disperato, è la necessità di soddisfare i bisogni umani di base in tutta l'Africa.
Le donne hanno ancora bisogno di cure prenatali e postnatali, poiché l'Africa rimane il continente con il più alto tasso di mortalità materna. Restiamo la regione con il minor accesso all'acqua potabile, restiamo la regione con il più basso tasso di iscrizione scolastica.
Quindi, più che mai, più che nel 2012, abbiamo bisogno di veri aiuti allo sviluppo invece che di contraccettivi e di educazione sessuale grafica non richiesta.
Da Cultura della vita AfricaLei denuncia che la cultura della morte sta iniziando a erodere valori tradizionali e molto importanti in Africa, come la famiglia, l'arrivo dei bambini o la cura della vita. Come percepiscono le nuove generazioni questi valori?
- Come nella maggior parte del mondo, le culture, i costumi, le tradizioni, persino la lingua, il patrimonio, le opinioni e i valori vengono trasmessi da una generazione all'altra. Sono le generazioni più anziane che cercano di insegnare e inculcare le lezioni più importanti alle generazioni più giovani. Le nazioni africane dipendono da questo da secoli.
Il problema del nostro mondo moderno è che il mondo è diventato molto più piccolo, soprattutto per i giovani, sotto la potente influenza dei media.
In primo luogo, i mezzi di intrattenimento fortemente influenzati dall'Occidente: film, musica, notiziari via cavo delle più ricche reti televisive occidentali. La gioventù africana ha iniziato a consumare molto di più i punti di vista occidentali che le preziose lezioni dei loro anziani. Questo fenomeno si è accentuato in modo esponenziale con l'introduzione dei social media.
Centinaia di milioni di giovani africani sono attaccati ai social media, come i giovani di tutto il mondo, e la realtà è che i social media sono diventati un meccanismo di distribuzione di contenuti ideologici mirati e curati direttamente nelle mani, nei cuori e nelle menti di giovani impressionabili. I giovani africani non sono stati risparmiati.
La sporcizia si sta impossessando di loro e ha il sopravvento sulla loro capacità (in molti casi) di apprendere le lezioni, i punti di vista e i valori che sono stati tramandati dalle generazioni più anziane.

Lei è nigeriano, scienziato biomedico che vive nel Regno Unito, conosce "entrambe le parti" del pianeta. Come risponde a chi parla di "mancanza di risorse" o di "progressi nel diritto di decidere" e spinge per politiche anti-vita in Africa?
- Il problema più evidente dell'Africa non è la "mancanza di risorse", ma la corruzione radicata e la mancanza di trasparenza della classe dirigente. Infatti, le nazioni africane possono vantare ricche riserve di materie prime, metalli preziosi, petrolio e, soprattutto, risorse umane, dato che la nostra popolazione è prevalentemente giovane.
Ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento critico non è il diritto di uccidere i nostri bambini non ancora nati, ma una seria revisione dei nostri sistemi socio-economici e l'educazione delle nostre popolazioni per trasformarle in cittadini che comprendano il proprio valore e la propria dignità al punto da esigere un governo migliore dai loro leader. Abbiamo bisogno di popolazioni che capiscano come salire al livello più alto per far sentire la propria voce a livello locale e nazionale. Abbiamo bisogno di una popolazione molto più robusta, sana ed emancipata, orgogliosa dei Paesi, delle culture, del patrimonio e dei valori africani.
Come possiamo sostenere, da ciascuno dei nostri luoghi, la cultura della vita, nei nostri luoghi e in Africa?
- Il primo passo per costruire un cultura della vita in qualsiasi parte del mondo è avere la conoscenza e la comprensione delle lotte culturali e ideologiche che si stanno svolgendo in tutto il mondo, a partire dall'Occidente. Molti non riconoscono nemmeno che esiste un conflitto reale su verità fondamentali come la santità della vita umana, il diritto alla vita di ogni essere umano, compresi quelli nel grembo materno, una feroce battaglia sulla comprensione della sessualità umana, la realtà biologica del sesso, i diritti dei genitori, i ruoli dei genitori, l'importanza del matrimonio e della famiglia e la necessità di salvaguardare i bambini in ogni società.
Ognuno di essi rappresenta un punto di vigilanza per chi vuole costruire una vera cultura della vita.
Per sostenere l'Africa e la società stessa, dobbiamo fare uno sforzo consapevole per cercare le buone organizzazioni che stanno facendo il lavoro. Aiutate queste organizzazioni, perché in realtà le organizzazioni pro-vita e pro-famiglia (per esempio) sono le organizzazioni più represse e meno presenti, i cui avversari in molti casi sono organizzazioni gigantesche finanziate dal governo. È necessario che più persone sostengano le organizzazioni che osano sfidare i nuovi movimenti culturali e ideologici "progressisti".
Anche i cittadini dei Paesi occidentali dovrebbero opporsi ai progetti internazionali dei loro governi che sono palesemente ideologici. Insistere affinché il loro governo ascolti maggiormente le esigenze delle persone che stanno cercando di aiutare. È meglio dare acqua pulita a una comunità svantaggiata piuttosto che un sacco di contraccettivi che potrebbero anche non essere usati (perché non sono mai stati richiesti). È meglio dare libri ai bambini che preservativi.
È giunto il momento di ascoltare davvero e scoprire cosa conta di più per le comunità ospitanti.
Introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger
Concepito come un corso per studenti universitari, l'allora teologo e poi Papa, recependo le difficoltà e le debolezze della mente moderna, volle mostrare nella Introduzione al cristianesimo La fede cristiana come unica via per la realizzazione umana.
"Il trasferimento di Ratzinger da Münster (nel 1969) alla città universitaria protestante di Tubinga è una delle decisioni più enigmatiche nella biografia dell'ultimo Papa", Seewald scrive nella sua biografia. Anche se nel suo libro La mia vita Lo stesso Ratzinger fornisce alcune ragioni.
Da un lato, non si sentiva a suo agio con la deriva del suo collega di Münster, Johan Baptista Metz, verso una teologia molto politica. D'altra parte, fu attratto dall'invito di Hans Küng a unirsi a un gruppo di rinnovamento teologico a Tubinga. Era anche attratto, e sua sorella ancora di più, dalla Baviera, la sua patria.
Ratzinger era allora una figura emergente, essendosi distinto al Concilio come esperto di fiducia e ispiratore di molti interventi del cardinale Frings di Colonia. Sebbene inizialmente fosse interessato a Küng, si accorse ben presto che i loro orizzonti non coincidevano. Küng arrivò all'università in un'Alfa Romeo rossa, Ratzinger in bicicletta con un berretto.
Si incontreranno di nuovo nel 1981, quando Ratzinger, in qualità di prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, dovrà occuparsi del "caso Küng".
Tübingen difficile
Rimase a Tubinga solo per tre difficili anni (1966-1969). "La facoltà aveva un corpo docente di altissimo livello, anche se incline alla polemica".. Inoltre, l'atmosfera intellettuale della facoltà è cambiata completamente: "Lo schema esistenzialista è crollato ed è stato sostituito dallo schema marxista"..
Era una speranza senza Dio, rappresentata anche da Ernst Bloch, il famoso professore marxista della Facoltà di Filosofia e autore di un celebre saggio su Il principio della speranza. In quell'ambiente, ricorda Ratzinger: "Ho visto senza veli il volto crudele di quella devozione atea".. Era il famoso '68, che già ribolliva, e lo toccò da vicino: "All'epoca del più grande scontro, ero decano della mia facoltà".membro di diversi consigli e "della Commissione incaricata di redigere un nuovo statuto dell'università"..
Ma non c'erano solo complicazioni. Nel 1967 toccò a Küng tenere il corso di Dogmatica e Ratzinger trovò che "Ero libero di realizzare un progetto che stavo perseguendo in silenzio da dieci anni. Ho avuto l'idea di sperimentare un corso rivolto agli studenti di tutte le facoltà dal titolo Introduzione al cristianesimo".
Perché un Introduzione al cristianesimo
"Nel 1967" - racconta nella prefazione all'edizione del 2000. "Gli impulsi del recente periodo post-conciliare erano ancora in piena effervescenza: il Concilio Vaticano II ha voluto fare proprio questo: ridare al cristianesimo una forza capace di plasmare la storia [...], è stato nuovamente confermato che la fede dei cristiani abbraccia tutta la vita"..
In un certo senso le fusioni di marxismo e cristianesimo e la loro proiezione nella teologia della liberazione volevano fare la stessa cosa, ma "La fede ha ceduto alla politica il ruolo di forza salvifica".. E parallelamente, c'era l'agnosticismo occidentale: "La questione di Dio [...] non è forse arrivata a essere considerata praticamente inutile?"..
La struttura del libro
Il Iniziazione al cristianesimo ha una chiara struttura in tre parti, corrispondenti alle tre grandi domande: Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la Chiesa. Corrisponde anche alle tre parti del Credo.
Asimiosmo li precede anche con un'ampia introduzione che spiega cosa significa credere, accettare la fede. Nella prefazione, scritta nel 1967, descriveva così l'intento del libro: "Vuole aiutare una nuova comprensione della fede come realtà che rende possibile essere autentici esseri umani nel mondo di oggi".. Ignorare "Una verbosità che riesce solo a malapena a nascondere un grande vuoto spirituale"..
Questi studenti dovevano ricevere un'espressione di fede viva e stimolante. Non una cosa qualsiasi, ma che vedano in essa la via per la pienezza della loro vita. Per questo è stato necessario avere ben chiaro sia il punto di partenza, la situazione mentale in cui si trovavano gli studenti, sia l'itinerario. Questa sfida del 1967 è il merito del libro.
La situazione della fede
Il punto di partenza è che la fede è irrilevante per gli occidentali che vivono ai margini. In passato, la fede si basava molto sull'attaccamento alla tradizione, ma questo la rende obsoleta per coloro che oggi si affidano al progresso.
Un teologo oggi ricorda il clown del racconto di Kierkegaard che si recò al villaggio per avvertire del pericolo del fuoco. Lo hanno deriso e non si aspettavano che dicesse qualcosa di valido. Dovrebbe cambiare il suo costume, come la teologia. Ma a parte il fatto che non è facile, mettersi a proprio agio non significherebbe perdersi? Cioè "Il potere inquietante dell'incredulità".perché le obiezioni riguardano anche il cristiano, figlio del suo tempo: e se non ci fosse nulla? La cosa interessante è che il non credente si trova in una situazione parallela: cosa succede se la fede è vera? Dio è essenzialmente invisibile. Ecco perché la fede è "una scelta per cui l'invisibile [è] considerato l'autenticamente reale".. È una decisione e una "svolta" o conversione. Ma è molto impegnativo, perché non si tratta di una vaga convinzione che "qualcosa" esista, ma che sia intervenuto nella nostra storia: "quell'uomo della Palestina"....
Ripercorre gli itinerari del pensiero moderno e le successive difficoltà della fede, dal positivismo della scienza moderna al marxismo. Conclude che credere oggi significa accettare la rivelazione cristiana come fondamento della propria esistenza.
Ecco perché, "Le prime e le ultime parole del credo - 'credo' e 'amen' - sono intrecciate tra loro".. Ed è anche un "credo in Te", proprio per il significato dell'incarnazione e della storia. Credo nel Logos - la ragione di tutto - incarnato. E questo significa che in Lui (e non in me) sono sostenuto. Questa fede ha anche una dimensione ecclesiale, perché è creduta con la Chiesa e le sue espressioni, i credo.
Dio
Fin dall'inizio, egli si addentra nella parola, per non lavorare solo con un nome logoro, ma per notare tutto ciò che essa implica, anche in relazione al mondo e alla materia. Egli ripercorre la storia della rivelazione a Israele, dove Dio si mostra così diverso dagli altri dei, personale e unico, e vieta qualsiasi divinizzazione del pane (dei beni), dell'eros o del potere politico. Partendo dalla scena del roveto ardente nel libro dell'Esodo, con la vocazione di Mosè, passa in rassegna i nomi biblici di Dio (IlElohim, Yahweh) al Dio dei Padri di Israele e al Dio di Gesù Cristo. Con l'enorme forza del Nome che suggerisce che solo Dio "è" veramente. E l'eco della "Io sono nel Nuovo Testamento e in Gesù Cristo stesso. Con quel doppio aspetto paradossale della solennità assoluta dell'"Io sono" e, al tempo stesso, della vicinanza di un Dio per Israele, per tutti gli uomini. E alla fine, padre.
Da qui salta al classico confronto tra il Dio della fede e il Dio dei filosofi. L'antichità cristiana ha saputo sintetizzare la conoscenza del Dio biblico con la riflessione della filosofia classica sulla fondazione dell'universo. E sempre, allo stesso tempo, Padre. Questo felice incontro ha illustrato il ruolo importante che il pensiero razionale - la teologia - svolge nella fede cristiana. Nella riflessione moderna, le due dimensioni rimangono importanti: Dio come fondamento e Logos del cosmo, e il Padre come orizzonte di tutti gli uomini. Ed è da questa esigenza di relazione che nasce un bellissimo ed esteso sviluppo della Trinità, che non è possibile riassumere qui senza entrare troppo nel dettaglio. Ma proprio qui sta la chiave del significato e della realizzazione dell'essere umano.
Gesù Cristo
Questa seconda parte è a sua volta divisa in due parti: la prima parte, il Credo in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, nostro SignoreIl secondo, sulle affermazioni del Credo su Gesù Cristo: è nato da Maria Vergine, ha sofferto..., è risorto.... Il punto di partenza è "Il problema di confessare Gesù oggi".Quest'ultima è sempre più scandalosa: come può l'intera realtà del cosmo e dell'umanità ruotare intorno a qualcosa che è accaduto in un momento della storia? Questo non può essere pienamente raggiunto né dalla fisica né dalla storia. Inoltre, l'epoca moderna cerca di separare Gesù da Cristo, smantellando ciò che si suppone sia stato istituito nella storia. Il disconoscimento del Figlio permette di rimanere solo con un generico Padre, più accettabile in ambito interreligioso. E anche per rimanere con un modello di Gesù Cristo apparentemente più vicino.
Ma Gesù è il Cristo e questo titolo di Messia (confuso nel suo tempo) si realizza soprattutto sulla croce. "Gesù è il Cristo, è il Re nella misura in cui è crocifisso".con la regalità del dono di sé, dell'amore. Y "trasformando così l'amore in Logos, nella verità dell'essere umano".. Questo tema è rafforzato dalla scena del giudizio finale, dove il Signore chiede ai suoi di vederlo nei fratelli (cfr. Mt 25). L'identità di Gesù con il Cristo della Croce è anche l'identità del Logos con l'amore. Poi si sofferma a lungo sul mistero del Dio-uomo.
Lo Spirito e la Chiesa
Anche l'ultima parte, molto più breve, è suddivisa in due parti. In primo luogo, tratta brevemente dell'unità degli ultimi articoli del Credo, intorno alla confessione nello Spirito Santo e nella Chiesa che Egli anima.
Poi si sofferma un po' di più su due punti "difficili" per chi lo ascoltava allora e per chi lo legge oggi: la santità della Chiesa e la resurrezione della carne. Come si può affermare contro l'evidenza storica che la Chiesa è santa? Lo risolve in modo originale. Proprio perché la Chiesa è salvifica, è unita a ciò che è peccaminoso, come Gesù Cristo stesso. Non è un'entità luminosa e trascendente. Si incarna per salvare. "Nella Chiesa, la santità inizia con la sopportazione e finisce con la sopportazione".. Chi guarda solo all'organizzazione e non ai sacramenti non lo capisce. I veri credenti vivono sempre secondo i sacramenti, mentre l'organizzazione cambia in meglio o in peggio nella storia.
Quanto alla resurrezione finale dei morti, è un'esigenza della totalità che è l'essere umano con la sua dimensione corporea. E alcuni aspetti dell'antica dualità greca corpo/anima devono essere messi da parte, perché la concezione della fede cristiana dell'essere umano è unitaria. E la sua pienezza non consiste in una semplice sopravvivenza dell'anima, liberata dal corpo, ma in una "immortalità dialogica", una vita e una resurrezione basate sull'amore di Dio per ogni persona. L'amore di Dio è ciò che sostiene la personalità umana e la risurrezione è un atto salvifico dell'amore di Dio che la porta alla sua pienezza. Questo aspetto verrà sviluppato più avanti nel suo Escatologia.
Cosa è cambiato da allora
Torniamo alle osservazioni della prefazione, che l'allora cardinale Ratzinger aggiunse nel 2000. Soprattutto dopo il 1989, con la caduta del comunismo, "Tutti questi progetti [...] hanno dovuto essere ritirati nel momento in cui la fede nella politica come forza di salvezza è venuta meno.. Allora "Nella plumbea solitudine di un mondo orfano di Dio, nella sua noia interiore, è sorta la ricerca del misticismo".. Nelle esperienze, nei surrogati orientali, ecc. E anche apparizioni. Finché le persone "L'istituzione è fastidiosa e anche il dogma. L'istituzione dà fastidio e il dogma dà fastidio"..
Questa è la novità rispetto agli anni Sessanta. In parte opportunità, in parte confusione. E chiede ancora, ma in modo diverso, che le caratteristiche del Dio cristiano, che opera nella storia, con un Figlio che si fa uomo, siano mostrate di fronte alla tendenza sincretistica. E all'offuscamento dell'idea di Dio, sempre più impersonale, per renderla accettabile non solo alle altre religioni, ma anche a chi non vuole credere.
Ma il centro non è cambiato: si tratta sempre di mostrare Cristo, il Figlio, come oggetto della nostra fede (Credo in Te), con quella doppia dimensione di Logos, ragione di tutto, e di amore per noi, manifestato e donato sulla croce. Abbiamo bisogno di questa doppia dimensione per trovare il senso della vita e della nostra salvezza. E da allora è una chiave della teologia di Joseph Ratzinger.
"Cristo è indigeno": memoria e riconciliazione nel viaggio del Papa in Canada
Una richiesta di perdono radicale e incondizionata. Bellissima predicazione sulla riconciliazione e sulla memoria. Un indigenismo cristiano nello stile di Cara Amazzonia. L'amore per la nonna di Gesù, nella festa di Sant'Anna. Un caloroso benvenuto dai canadesi dell'Alberta. I momenti salienti di questa prima tappa del pellegrinaggio penitenziale di Papa Francesco in Canada.
 Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare".
Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare". Canada: andare verso le periferie. Al Polo Nord e nel deserto laicista
Canada: andare verso le periferie. Al Polo Nord e nel deserto laicista Perché la visita del Papa in Canada è importante
Perché la visita del Papa in Canada è importanteOmnes ha già riferito sul primi gesti, emotivi e fotogeniciL'intrepido pellegrino 85enne, che viaggia in sedia, Fiat 500, papamobile e naturalmente vola in aereo, ha percorso in totale circa 19.000 km durante il suo 37° viaggio apostolico.
Il Papa sta più che mantenendo la promessa di chiedere personalmente perdono qui, come aveva anticipato a Roma il 17 luglio: "Andrò... soprattutto nel nome di Gesù per incontrare e abbracciare le popolazioni indigene". Purtroppo, in Canada, molti cristiani... hanno contribuito alle politiche di assimilazione culturale che, in passato, hanno gravemente danneggiato, in modi diversi, le comunità native. Per questo motivo ho recentemente ricevuto in Vaticano alcuni gruppi di rappresentanti dei popoli indigeni (e) mi accingo a compiere un pellegrinaggio penitenziale".
Lunedì 25, Francesco non avrebbe potuto essere meno ambiguo o più genuino, e questo è stato notato dagli osservatori e dai nativi sensibili, che sono molti in Canada. Con un gesto concreto ha restituito a una donna indigena della provincia del Saskatchewan i mocassini che lei gli aveva "prestato" a Roma - le scarpette in Canada ricordano quei bambini indigeni che non sono mai tornati dai collegi: "Mi è stato chiesto di restituire i mocassini quando sono arrivato in Canada; li ho portati..., e vorrei ispirarmi proprio a questo simbolo che, negli ultimi mesi, ha riacceso in me dolore, indignazione e vergogna. Il ricordo di quei bambini provoca dolore... Ma quei mocassini ci parlano anche di un percorso, di un viaggio che vogliamo fare insieme. Camminare insieme, pregare insiemeDobbiamo lavorare insieme, affinché la sofferenza del passato lasci il posto a un futuro di giustizia, guarigione e riconciliazione".
È che Francesco parla ai canadesi di speranza e non solo di tragedie passate. "Dobbiamo ricordare come le politiche di assimilazione e disimpegno, che comprendevano anche il sistema delle scuole residenziali, siano state disastrose... Quando i coloni europei sono arrivati qui per la prima volta, c'era una grande opportunità di sviluppare un incontro fruttuoso tra culture, tradizioni e spiritualità. Ma in larga misura ciò non è avvenuto. E mi viene in mente quello che mi avete raccontato, di come le politiche di assimilazione abbiano finito per emarginare sistematicamente le popolazioni indigene; di come, anche attraverso il sistema delle scuole residenziali, le loro lingue, le loro culture siano state denigrate e soppresse; di come i bambini siano stati maltrattati fisicamente e verbalmente, psicologicamente e spiritualmente; di come siano stati portati via dalle loro case quando erano molto piccoli e di come questo abbia segnato in modo indelebile il rapporto tra genitori e figli, tra nonni e nipoti".
"Sebbene la carità cristiana sia stata presente e ci siano molti esempi di dedizione ai bambini, le conseguenze complessive delle politiche legate alle scuole residenziali sono state catastrofiche. La fede cristiana ci dice che è stato un errore devastante, incompatibile con il Vangelo di Gesù Cristo. Fa male sapere che questo terreno compatto di valori, lingua e cultura... è stato eroso, e che voi continuate a pagarne il prezzo. Di fronte a questo male oltraggioso, la Chiesa si inginocchia davanti a Dio e implora il suo perdono per i peccati dei suoi figli (cfr. Giovanni Paolo II, Incarnationis mysterium). Vorrei ripetere con vergogna e chiarezza: chiedo umilmente perdono per il male che tanti cristiani hanno commesso contro le popolazioni indigene".
"In questa prima fase ho voluto dare spazio alla memoria. Oggi sono qui per ricordare il passato, per piangere con voi, per guardare la terra in silenzio, per pregare sulle tombe. Che il silenzio ci aiuti a interiorizzare il dolore. Silenzio e preghiera. Di fronte al male preghiamo il Signore del bene; di fronte alla morte preghiamo il Dio della vita... Gesù Cristo ha fatto di una tomba... il luogo della rinascita, della resurrezione, dove è iniziata una storia di nuova vita e di riconciliazione universale. I nostri sforzi non bastano..., abbiamo bisogno della sua grazia, della sapienza dolce e forte dello Spirito, della tenerezza del Consolatore".
Cristo è autoctono
Nel pomeriggio del 25 luglio, Francesco ha citato Giovanni Paolo II (Provincia dell'Ontario, 15 settembre 1984): "Cristo anima il cuore stesso di ogni cultura, così che il cristianesimo non solo abbraccia tutti i popoli indigeni, ma Cristo stesso, nelle membra del suo corpo, è indigeno".
Quel pomeriggio, nella parrocchia del Sacro Cuore dedicata agli indigeni di Edmonton, capitale dell'Alberta, Francesco ha parlato del concetto di riconciliazione. "Gesù riconcilia mettendo insieme due realtà distanti, facendo di due realtà distanti un'unica realtà, una cosa, un popolo. E come lo fa? Per mezzo della croce... Gesù, per mezzo delle estremità della sua croce, abbraccia i punti cardinali e riunisce i popoli più lontani, Gesù guarisce e pacifica tutti (cfr. Efesini 2:14)".
E ha continuato: "Gesù non ci propone parole e buoni propositi, ma ci propone la croce, quell'amore scandaloso che si lascia trafiggere i piedi e i polsi dai chiodi e la testa dalle spine. Questa è la direzione da prendere, guardare insieme a Cristo, l'amore tradito e crocifisso per noi; vedere Gesù, crocifisso in tanti alunni delle scuole residenziali. Se vogliamo essere riconciliati... dobbiamo davvero alzare gli occhi a Gesù crocifisso, dobbiamo ottenere la pace sul suo altare... La riconciliazione non è tanto opera nostra, è un dono, è un dono che sgorga dal Crocifisso, è la pace che viene dal Cuore di Gesù, è una grazia da chiedere".
Ha parlato a una chiesa piena di un altro aspetto della riconciliazione. "Gesù, attraverso la croce, ci ha riconciliati in un solo corpo... La Chiesa è questo corpo vivo di riconciliazione. Ma, se pensiamo al dolore indelebile provato... si prova solo rabbia... vergogna. Questo è accaduto quando i credenti si sono lasciati andare alla mondanità e, invece di promuovere la riconciliazione, hanno imposto il proprio modello culturale. Questa mentalità... è lenta a morire, anche dal punto di vista religioso. In effetti, sembrerebbe più conveniente inculcare Dio nelle persone, piuttosto che permettere loro di avvicinarsi a Dio. Una contraddizione. Ma non funziona mai, perché il Signore non lavora così, non costringe, non soffoca, non opprime; ama, libera, libera. Non sostiene con il suo Spirito coloro che sottomettono gli altri".
Con una frase lapidaria Francesco ha detto: "Dio non può essere annunciato in modo contrario a Dio. Eppure, quante volte è successo nella storia! Mentre Dio si presenta con semplicità e umiltà, noi siamo tentati di imporlo e di imporci in suo nome. È la tentazione mondana di farlo scendere dalla croce per manifestarlo in potenza e in apparenza. Ma Gesù riconcilia sulla croce, non scendendo dalla croce".
Ha poi parlato della riconciliazione come "sinonimo di Chiesa... La Chiesa è la casa dove ci riconciliamo di nuovo, dove ci riuniamo per ricominciare e crescere insieme". È il luogo in cui smettiamo di pensare come individui per riconoscerci come fratelli e sorelle, guardandoci negli occhi, accogliendo le storie e la cultura dell'altro, lasciando che la mistica dello stare insieme, così gradita allo Spirito Santo, favorisca la guarigione delle memorie ferite. Questa è la strada, non decidere per gli altri, non incasellare tutti in schemi precostituiti, ma mettersi davanti al Crocifisso e al fratello per imparare a camminare insieme. Questa è la Chiesa..., non un insieme di idee e precetti da inculcare nelle persone,... (ma) una casa accogliente per tutti. Pregare insieme, aiutare insieme, condividere le storie di vita, le gioie e le lotte comuni apre la porta all'opera di riconciliazione di Dio".
26 luglio, Sant'Anna
Il 26 luglio è una festa molto amata in Canada, soprattutto dai cattolici indigeni. Alle 10 il Papa ha concelebrato (senza poter presiedere la celebrazione eucaristica a causa del ginocchio malandato) al Commonwealth Stadium di Edmonton. La preghiera eucaristica era in latino. Prima della benedizione finale, il celebrante principale, l'arcivescovo di Edmonton Richard Smith, lo ha ringraziato "profondamente" per il suo grande sacrificio personale in questo viaggio, e gli oltre 50.000 presenti hanno applaudito per tre minuti.
Nel pomeriggio, ha benedetto l'acqua e le persone nel Santuario di Sant'Anna, sull'omonimo lago a un centinaio di chilometri a nord-ovest di Edmonton. Lì, come la mattina allo stadio, ha pronunciato parole accorate legate alla nonna di Gesù.

Le porte sono spalancate per l'evangelizzazione di questo Papa mediatico, poiché le cerimonie sono trasmesse a milioni di persone, ad esempio attraverso la Canadian Broadcasting Corporation. Un sacerdote che lo accompagna traduce a intermittenza e con grande efficacia in inglese, in modo da poterlo seguire molto bene.
Omelia della Messa
Siamo figli di una storia che va preservata, non siamo isole, ha detto il Pontefice durante la Messa. Ha spiegato che di solito la fede viene trasmessa a casa nella lingua madre. Da qui la grande tragedia dei collegi che hanno distorto questa dinamica. È proprio dai nostri nonni che abbiamo imparato che l'amore non è un'imposizione. La fede non deve mai essere imposta. Non opprimiamo le coscienze - e non smettiamo mai di amare e rispettare le persone che ci hanno preceduto e che ci sono state affidate. Perché sono "tesori preziosi che custodiscono una storia più grande di loro".
Ma "oltre a essere figli di una storia che va preservata, siamo artigiani di una storia che va costruita". Il Papa ha chiesto ai presenti di non essere sterili critici del sistema, ma costruttori del futuro, in dialogo con le generazioni passate e future.
Egli distingueva tra una tradizione sana, quella dell'albero la cui radice si protende verso l'alto e porta frutto; e un tradizionalismo orizzontale, che fa le cose perché sono sempre state fatte così. La tradizione è la fede viva dei nostri morti, mentre il tradizionalismo è la fede morta dei vivi.
"Che Gioacchino e Anna intercedano per noi. Che ci aiutino a custodire la storia che ci ha generato e a costruire una storia generativa. Che ci ricordino l'importanza spirituale di onorare i nostri nonni e anziani, di approfittare della loro presenza per costruire un futuro migliore. Un futuro in cui gli anziani non vengano scartati perché funzionalmente "non necessari"; un futuro che non giudichi il valore delle persone solo in base a ciò che producono; un futuro che non sia indifferente nei confronti di chi, già avanti con l'età, ha bisogno di più tempo, ascolto e attenzione; un futuro in cui non si ripeta la storia di violenza ed emarginazione subita dai nostri fratelli e sorelle indigeni. È un futuro possibile se, con l'aiuto di Dio, non spezziamo il legame con chi ci ha preceduto e alimentiamo il dialogo con chi verrà dopo di noi: giovani e anziani, nonni e nipoti, insieme. Andiamo avanti insieme, sogniamo insieme. E non dimentichiamo il consiglio di Paolo al suo discepolo Timoteo: "Ricordati di tua madre e di tua nonna".
Nonni e bambini. Francesco ha potuto fare il giro dello stadio con la papamobile e salutare e baciare una ventina di bambini. Questo prima della messa.
Una storia di due laghi
Più tardi, al Lac Sainte Anne, dopo la liturgia della Parola (Ezechiele sull'acqua che esce dal tempio e guarisce e Gesù che dice "Se qualcuno ha sete, venga a me e beva"), il Papa ha paragonato il lago al lago di Galilea. Immaginava Gesù che esercitava il suo ministero sulla riva di un lago simile.
Il mare di Galilea era "come un concentrato di differenze, sulle sue rive c'erano pescatori e pubblicani, centurioni e schiavi, farisei e poveri, uomini e donne... Lì Gesù predicava il Regno di Dio. Non a persone religiose selezionate, ma a popoli diversi che, come oggi, venivano da vari luoghi, accogliendo tutti e in un teatro naturale come questo". Lì Dio ha annunciato al mondo "qualcosa di rivoluzionario: 'porgete l'altra guancia, amate i vostri nemici, vivete come fratelli e sorelle per essere figli di Dio, il Padre che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti'". Così, proprio quel lago, "mescolato con la diversità", è stato il luogo di un annuncio senza precedenti di... una rivoluzione senza morti né feriti, la rivoluzione dell'amore".
Ha paragonato il suono dei tamburi indigeni che lo hanno costantemente accompagnato al battito del cuore. E ha aggiunto: "Qui, sulle rive di questo lago, il suono dei tamburi che attraversa i secoli e unisce popoli diversi, ci riporta a quel tempo. Ci ricorda che la fraternità è vera se unisce coloro che sono lontani".
Si è riferito al suicidio assistito, eufemisticamente definito come Assistenza medica in fin di vitaDa allora il numero di persone eutanasizzate legalmente si aggira intorno alle 40.000 unità. Il numero di persone eutanizzate legalmente da allora è oggi di circa 40.000. "Dobbiamo guardare di più alle periferie e ascoltare il grido degli ultimi, dobbiamo saper accogliere il dolore di chi, spesso in silenzio, nelle nostre città sovraffollate e spersonalizzate, grida: 'Non lasciateci soli'. È anche il grido degli anziani che rischiano di morire soli in casa o abbandonati in una struttura, o dei malati scomodi che, invece di affetto, ricevono morte".
Ha fatto riferimento anche ai giovani, al "grido soffocato di ragazzi e ragazze più interrogati che ascoltati, che delegano la loro libertà a un cellulare, mentre nelle stesse strade altri coetanei vagano smarriti, anestetizzati da qualche diversivo, prigionieri di dipendenze che li rendono tristi e insoddisfatti, incapaci di credere in se stessi, di amare ciò che sono e la bellezza della vita che hanno". Non lasciateci soli è il grido di chi vorrebbe un mondo migliore, ma non sa da dove cominciare".
Il più grande evangelizzatore non ha esitato ad affermare, naturalmente, che l'evangelizzazione inculturata è una grande benedizione, anche umana. "Durante i drammi della conquista, fu Nostra Signora di Guadalupe a trasmettere la giusta fede agli indios, parlando la loro lingua, indossando i loro costumi, senza violenza e senza imposizioni. E poco dopo, con l'avvento della stampa, furono pubblicate le prime grammatiche e i primi catechismi nelle lingue indigene. Quanto bene hanno fatto i missionari autenticamente evangelizzatori nel preservare le lingue e le culture indigene in molte parti del mondo! In Canada, questa "inculturazione materna", avvenuta attraverso l'opera di Sant'Anna, ha unito la bellezza delle tradizioni indigene e della fede, dando loro forma con la saggezza di una nonna che è due volte madre".
Da 133 anni i cristiani indigeni si recano in pellegrinaggio in questo santuario. Prima dell'arrivo del cristianesimo, c'era già l'usanza di pregare in questo luogo, perché secondo la tradizione orale indigena, un capo tribù fece un sogno in cui vide che in questo lago avrebbero trovato la guarigione. Così il Papa pellegrino ha detto nella sua omelia: "Quanti cuori sono venuti qui desiderosi e stanchi, appesantiti dai pesi della vita, e da queste acque hanno trovato la consolazione e la forza di andare avanti".
Il 27 luglio il Papa vola per quattro ore, arrivando a Quebec City alle tre del pomeriggio. Lo stiamo aspettando qui.
"Condividere i beni con chi ne ha bisogno". 18a domenica del Tempo Ordinario
Andrea Mardegan commenta le letture della XVIII domenica del Tempo Ordinario e Luis Herrera tiene una breve omelia video.
I Vangeli delle ultime domeniche ci guidano in un viaggio spirituale. La parabola del Buon Samaritano ci ha aiutato a capire come vivere il rapporto con il prossimo secondo misericordia e compassione. Al maestro della legge che menzionava l'amore per il prossimo, Gesù disse: fate questo e avrete la vita. La compassione verso il prossimo è la via per la vita eterna.
Il dialogo di Gesù con Marta e Maria, e poi la rivelazione della preghiera al Padre e la parabola dell'amico importuno, ci incoraggiano a vivere il nostro rapporto con Dio nella fiducia filiale e come amici. Oggi, la parabola del ricco stolto ci indirizza a vivere il nostro rapporto con i beni terreni, accanto a un rapporto di fiducia con Dio e con il suo pensiero su quei beni, e in un rapporto di misericordia con le altre persone: non solo "condividere" i beni, come l'uomo voleva dire a Gesù a proposito dell'eredità del fratello, ma "condividere".
La domanda sull'eredità rivolta a Gesù si spiega con il fatto che la legge di Mosè conteneva indicazioni su questo aspetto, e in caso di controversia ci si rivolgeva a un maestro esperto di legge. Ma Gesù non è un semplice rabbino o interprete della legge, è il Messia e il Figlio di Dio; è venuto a compierla e a superarla. Egli scruta i cuori e dà regole di vita che vanno al di là di ciò che dice la legge: "Guardatevi da ogni cupidigia".. Paolo fa eco a questo insegnamento esortando i Colossesi a mettere a morte la "avidità, che è idolatria"..
In effetti, ciò che colpisce della figura del ricco "sciocco"La parola che nella Bibbia designa l'uomo che non crede in Dio o che vive come se Dio non esistesse, è la sua solitudine. Il testo greco dice che "conversa con se stesso", e in questo soliloquio ha in mente solo le sue cose: il mio raccolto, i miei granai, i miei beni. Immagina, sempre in dialogo con se stesso, cosa si dirà quando avrà costruito nuovi magazzini: E poi dirò a me stesso: "Anima mia, hai beni accumulati per molti anni; riposati, mangia, bevi, banchetta allegramente"..
Non c'è Dio al suo orizzonte e non c'è nessuno. Ecco perché Dio, parlandogli, lo apre a un "altro" che non esiste nel suo pensiero: "Di chi sarà quello che hai preparato?".. Nel greco di Luca c'è un gioco di parole ancora più evidente. L'uomo ricco ed egoista usa "psyché (anima) due volte: "Dirò alla mia anima: anima hai molte cose buone".e Dio gli dice: "Stanotte reclameranno la tua anima"..
La saggezza di Qoheleth trova eco nella parabola: "Tutto è vanità! C'è chi lavora con saggezza, conoscenza e abilità e deve lasciare la sua parte a chi non ha lavorato".. Dio vuole la vita autentica della nostra anima: condividere i nostri beni con chi ha bisogno.
L'omelia sulle letture della domenica 18
Il sacerdote Luis Herrera Campo offre il suo nanomiliauna breve riflessione di un minuto per queste letture.
I gesti di Papa Francesco in Canada
Il pellegrinaggio di Papa Francesco in Canada si sta rivelando un viaggio ricco di gesti e dal grande valore simbolico.
 Canada: andare verso le periferie. Al Polo Nord e nel deserto laicista
Canada: andare verso le periferie. Al Polo Nord e nel deserto laicista Le persone "scomparse" del Canada
Le persone "scomparse" del Canada Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare".
Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare".Da domenica scorsa, Papa Francesco è in viaggio verso la viaggio apostolico e penitenziale in Canada. I suoi incontri con le popolazioni indigene sono carichi di un grande valore simbolico. Anche se questo pellegrinaggio non è privo di difficoltàLe prime impressioni sono positive.
Nel suo incontro di lunedì 25 luglio con le popolazioni indigene Prime Nazioni, Métis e InuitPapa Francesco ha detto: "Ho aspettato questo momento per essere in mezzo a voi. Da qui, da questo luogo tristemente suggestivo, vorrei iniziare ciò che desidero dentro di me: un pellegrinaggio penitenziale. Vengo nelle vostre terre d'origine per dirvi personalmente che sono addolorato, per implorare Dio per il perdono, la guarigione e la riconciliazione, per esprimere la mia vicinanza a voi, per pregare con voi e per voi.
Le parole del Papa esprimono chiaramente il suo dolore per la situazione subita dalle popolazioni indigene, "in particolare per il modo in cui molti membri della Chiesa e delle comunità religiose hanno collaborato, anche con l'indifferenza, a quei progetti di distruzione culturale e di assimilazione forzata da parte dei governi dell'epoca, che si sono conclusi con il sistema delle scuole residenziali". Nel suo discorso si è scusato sette volte.
Gesti di impronta
Una delle prime persone che Papa Francesco ha potuto salutare è stata una donna che è passata da uno dei collegi. Il bacio sulla mano con cui si è congedato è diventato una delle immagini iconiche di questi giorni. Questo dimostra l'umiltà con cui il Papa è venuto in Canada, e la risposta dei leader indigeni ha corrisposto a questo stato d'animo. Non sorprende, quindi, che dopo la richiesta di perdono il Papa abbia ricevuto un tradizionale cappello indiano in segno di affetto e riconoscimento.
Un'altra immagine del viaggio è stata la preghiera di Papa Francesco in un cimitero di Maskwacis, a circa 70 chilometri a sud di Edmonton. L'accorata preghiera del Papa sulle tombe di alcuni bambini delle scuole residenziali è un altro gesto significativo.

Il Papa benedice il lago di Sant'Anna
Papa Francesco ha benedetto le acque del lago di Sant'Anna in Alberta (Canada) seguendo l'usanza indigena e benedicendo verso i quattro punti cardinali.
Questo lago è meta di un pellegrinaggio annuale in occasione della festa di Sant'Anna, madre della Vergine e nonno di Gesù. Ha un'importanza per i cattolici e le popolazioni indigene.
AhOra potete usufruire di uno sconto di 20% sull'abbonamento a Rapporti di Roma Premiuml'agenzia di stampa internazionale specializzata nelle attività del Papa e del Vaticano.
Considerazioni sul motu proprio "Ad charisma tuendum" sull'Opus Dei
Abbiamo chiesto al professor Giuseppe Comotti, esperto giurista, di commentare il documento della Santa Sede (il motu proprio "Ad carisma tuendum") che, il 14 luglio, ha modificato alcuni aspetti della normativa canonica dell'Opus Dei. Le sue considerazioni si basano su due interpretazioni chiave.
 "Ad charisma tuendum" concretizza la figura della Prelatura dell'Opus Dei
"Ad charisma tuendum" concretizza la figura della Prelatura dell'Opus Dei Carisma e gerarchia nell'Opus Dei, due dimensioni della stessa realtà. Il rapporto tra i doni dello Spirito Santo nella Chiesa
Carisma e gerarchia nell'Opus Dei, due dimensioni della stessa realtà. Il rapporto tra i doni dello Spirito Santo nella ChiesaTraduzione dell'articolo in italiano
Traduzione dell'articolo in inglese
Una corretta interpretazione dell'effettiva portata del recente motu proprio sull'Opus Dei "Ad charisma tuendum richiede l'uso di due chiavi ermeneutiche fornite dallo stesso Papa Francesco nel documento.
Il primo punto chiave è l'esplicito riferimento nel motu proprio alla costituzione apostolica "Ut sitcon la quale San Giovanni Paolo II ha eretto il Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei il 28 novembre 1982.
Mi sembra importante sottolineare che il nuovo motu proprio non abroga la Costituzione Apostolica, ma si limita ad adattarla alla nuova organizzazione della Curia Romana, che prevede in modo generale la competenza, d'ora in poi, del Dicastero per il Clero, e non più del Dicastero per i Vescovi, per tutto ciò che riguarda la Sede Apostolica in materia di prelature personali.
Per il resto, la struttura e il contenuto della Costituzione Apostolica "Ut sit", incisivamente sintetizzata dallo stesso San Giovanni Paolo II nella Discorso pronunciato il 17 marzo 2001 davanti ai partecipanti a un incontro promosso dalla Prelatura dell'Opus Dei. In quel discorso, il Santo Pontefice, con espressioni inequivocabili, non solo descrisse la Prelatura come "organicamente strutturata", cioè composta da "sacerdoti e fedeli laici - uomini e donne - avendo a capo il proprio Prelato", ma ribadì anche la "natura gerarchica dell'Opus Dei, stabilita nella Costituzione Apostolica con cui ho eretto la Prelatura".
Natura gerarchica
Da questo carattere gerarchico, San Giovanni Paolo II ha tratto "considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche", sottolineando "che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla loro Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa convergere la particolare missione della Prelatura nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come previsto dal Concilio Vaticano II quando ha istituito la figura delle Prelature personali".
Questo riferimento al Concilio Vaticano II è molto significativo e costituisce la seconda chiave ermeneutica del motu proprio. "Ad charisma tuendum", che sottolinea espressamente la necessità di fare riferimento agli "insegnamenti dell'ecclesiologia conciliare sulle prelature personali".
Come è noto, l'ultimo Concilio, nel prevedere la possibilità di istituire "diocesi speciali o prelature personali e altre disposizioni del genere" per facilitare "non solo la conveniente distribuzione dei sacerdoti, ma anche le opere pastorali proprie dei vari gruppi sociali da svolgersi in qualsiasi regione o nazione, o in qualsiasi parte della terra" (Decreto "Presbyterorum Ordinis".n. 10), ha omesso di delinearne i contorni precisi, preferendo lasciare spazio a un futuro dinamismo ecclesiale e a una disciplina articolata, "secondo moduli da determinare per ogni caso, sempre salvaguardando i diritti degli ordinari locali".
L'attuazione del Consiglio
I successivi interventi dei Romani Pontefici, nel mettere in pratica la prospettiva indicata dal Concilio, hanno lasciato aperti questi spazi: è il caso del motu proprio "Ecclesiae Sanctae Il Codice di Diritto Canonico di San Paolo VI (6 agosto 1966) e, soprattutto, il Codice di Diritto Canonico di San Giovanni Paolo II del 1983, in cui alcune disposizioni sono dedicate alle prelature personali (canoni 294-297), che possono concretizzarsi in modi diversi, secondo le esigenze individuate dalla Santa Sede, cui spetta l'erezione delle prelature personali.
Si noti, tuttavia, che il Codice di Diritto Canonico del 1983 (a differenza del Codice precedente, che ammetteva l'esistenza del semplice titolo onorifico di prelato), utilizza il termine "prelato" esclusivamente per indicare soggetti diversi dai vescovi diocesani, ma che hanno, come loro, la potestà di veri e propri ordinari rispetto ad ambiti di esercizio della potestà di governo denominati "prelature", ulteriormente specificati con il qualificatore di territoriali o personali, secondo il criterio adottato di volta in volta per individuare i fedeli destinatari dell'esercizio della potestà. Detto questo, il Codice di Diritto Canonico lascia spazio a un'ampia varietà di configurazioni che, concretamente, le singole prelature potrebbero ricevere negli statuti dati a ciascuna di esse dalla Suprema Autorità della Chiesa.
L'episcopato del prelato
In questo ampio spazio di libertà, il Codice di Diritto Canonico non prevede la necessità, ma nemmeno esclude la possibilità, che il prelato sia investito della dignità episcopale, scelta che dipende esclusivamente da una valutazione del Romano Pontefice, che solo nella Chiesa latina è responsabile della nomina dei vescovi.
L'astratta compatibilità della natura di prelatura personale con la dignità episcopale del soggetto che ne è a capo è infatti confermata dalla decisione di San Giovanni Paolo II di nominare vescovi i due precedenti Prelati dell'Opus Dei, ai quali, tra l'altro, egli stesso ha personalmente conferito l'ordinazione episcopale.
D'altra parte, esistono circoscrizioni ecclesiastiche di natura territoriale a capo delle quali si trovano prelati che sono certamente titolari di poteri di governo di natura gerarchica, ma che tuttavia non sono solitamente investiti della dignità episcopale (si pensi alle prefetture apostoliche nei territori di missione).
A ciò va aggiunto che, come è noto, nella prospettiva di un esercizio delle funzioni di governo non limitato ai soli vescovi, le insegne pontificie non sono riservate dal diritto canonico esclusivamente a questi ultimi, ma il loro uso è previsto per una categoria molto più ampia di soggetti, anche se non elevati all'episcopato, Si tratta, ad esempio, di Cardinali e Legati del Romano Pontefice, di Abati e Prelati che hanno giurisdizione su un territorio separato da una diocesi, di Amministratori Apostolici, Vicari Apostolici e Prefetti Apostolici costituiti permanentemente e di Abati di congregazioni monastiche.
Il motu proprio Ad charisma tuendum
Pertanto, se si accetta senza difficoltà che le funzioni di un prelato possano essere affidate a un sacerdote, ciò non impedisce che le prelature personali comportino sempre l'esercizio della potestà di governo ecclesiastico, se non altro perché, come previsto dal canone 295, paragrafo 1, il prelato personale "ha il diritto di istituire un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare studenti e promuoverli agli ordini con il titolo di servizio alla prelatura".
Il fatto che Papa Francesco intenda opportunamente tutelare l'origine "carismatica" dell'Opus Dei, "secondo il dono dello Spirito ricevuto da San Josemaría Escrivá de Balaguer", non impedisce in alcun modo che la Prelatura in quanto tale sia stata eretta mediante una Costituzione Apostolica, che è lo strumento solitamente utilizzato dal Romano Pontefice per istituire le circoscrizioni ecclesiastiche, attraverso le quali viene distribuito e regolato l'esercizio del potere di governo che corrisponde alla gerarchia.
Di conseguenza, il motu proprio "Ad charisma tuendum", In linea con il Magistero del Concilio, lungi dall'imporre una netta separazione tra la dimensione carismatica e quella istituzionale-gerarchica della Chiesa, il Concilio è stato un'istituzione di grande importanza. Opus Deideve essere letto come un invito a vivere con "un nuovo dinamismo" (cfr. San Giovanni Paolo II, Lettera apostolica "Il nuovo dinamismo della Chiesa").Novo millennio ineunte"15) la fedeltà al carisma di San Josemaría, che la Suprema Autorità della Chiesa, attraverso la costituzione apostolica "Ut sit", ha tradotto nell'istituzione di una Prelatura personale, cioè di uno strumento di natura gerarchica.
Ad essa è affidato quello che Papa Francesco definisce nel motu proprio un "compito pastorale", da svolgere "sotto la guida del presule" e che consiste nel "diffondere la chiamata alla santità nel mondo, attraverso la santificazione del lavoro e degli impegni familiari e sociali, per mezzo del clero incardinato in essa e con la cooperazione organica dei laici che si dedicano alle opere apostoliche".
Un compito che, proprio perché pastorale, non può che essere condiviso con i Pastori della Chiesa e che, in termini di contenuto, non si riferisce a specifiche categorie di soggetti, ma coinvolge tutti i fedeli, chiamati alla santità in virtù del Battesimo e non in ragione di una particolare scelta di vita.
Professore di diritto canonico e diritto ecclesiastico
Università di Verona
L'ultimo sorriso
Una storia vera per un giorno come questo, in cui si celebra la festa di San Gioacchino e Sant'Anna.
Il mio ricordo degli ultimi mesi di vita di Marguerite è un misto di dolore e dolcezza. Era una donna tenera e forte che, nonostante le circostanze inclementi della sua vita, aveva la virtù di mantenere il sorriso a galla.
Rodrigo l'ha incontrata nel 2016. All'epoca lui era uno studente di economia, io di legge, e insieme a un gruppo di amici stavamo cercando di far decollare un'iniziativa sociale. Volevamo mettere in contatto giovani studenti universitari con nonni abbandonati nelle loro case. Sarebbe un'ottima cosa.accordo in-winNoi impareremmo dall'esperienza degli anziani e loro sarebbero sollevati dalla loro solitudine.
Abbiamo scelto di partire da un'area vulnerabile: la popolazione di La Pincoya, un mare di case di 60 metri quadrati incastonate tra strade asfaltate ma strette, i cui tetti di zinco arrivano fino ai piedi delle colline che racchiudono Santiago del Cile a nord. È lì che siamo andati a esplorare. Alla stazione di polizia locale ci è stato consigliato di organizzare le visite il sabato mattina, perché è il momento in cui il commercio di droga riposa.
Il parroco, da parte sua, ci ha suggerito di indossare magliette bianche, in modo che la gente associasse la nostra presenza a quella dei volontari della parrocchia impegnati in altre iniziative, perché questo ci avrebbe dato maggiore sicurezza. Siamo poi andati di porta in porta a chiedere dove abitassero i nonni interessati a ricevere visite per una chiacchierata.
Nonostante il nostro timore iniziale, la gente ci ha accolto calorosamente, abbiamo familiarizzato con il quartiere e abbiamo scoperto che il problema della solitudine è frequente e straziante. Sabato dopo sabato, abbiamo visitato i nonni per ascoltarli, per congratularci con qualcuno per il suo compleanno o per regalargli un momento di conversazione. Non eravamo medici, psicologi o assistenti sociali, ma solo giovani inesperti che lasciavano ogni visita con il cuore pieno e l'anima commossa.
Molto presto Rodrigo incontra la signora Margarita. Gli fu presentato Mel, un giovane missionario francese che lavorava nella zona da qualche mese. In quell'incontro, Marguerite fu felice di parlare e Rodrigo le disse che sarebbe tornato. Quando lei disse di essere nata nel 1942 e di avere 74 anni, lui rimase sorpreso, sia per la sicurezza con cui lei dava loro questa delicata informazione, sia perché sembrava più vecchia di 15 o 20 anni.
Era bassa e un po' grassottella, portava una pettinatura alta che le spuntava come un campo di grano bianco sulla testa, era vestita con un'ampia giacca di pile blu e una sciarpa (nelle visite successive l'ha cambiata con un maglione nero molto più elegante con bottoni dorati), aveva sopracciglia grandi ed espressive ed era cieca dall'occhio sinistro. Camminava con difficoltà e lamentava dolori ai muscoli del lato destro del corpo. Il suo problema più grande, tuttavia, non era il dolore fisico, ma la solitudine. Era vedova e viveva nella sua casetta con due cagnolini e uno dei suoi sei figli, che purtroppo vedeva molto poco e che la faceva piangere con una frequenza allarmante, poiché era un grave alcolista. Vedeva gli altri figli "tardi, male e mai", poiché tutti, tranne la figlia, erano alcolisti.
Due sabati dopo, Rodrigo tornò accompagnato da José Miguel. Margarita rimase colpita dal fatto che i giovani avessero mantenuto la loro promessa, ringraziò Dio e li accolse con entusiasmo nella sua casa. Si sedettero sulle poltrone basse del salotto e fecero rapidamente conoscenza. Prima parlò loro della sua infanzia nella città di Talca e poi passò ad argomenti che lo riguardavano di più, fino ad arrivare ai suoi figli. Lì finalmente aprì completamente il suo cuore e raccontò, con labbra tremanti e parole timide, di una tristezza nera: la settimana prima, il figlio che viveva con lei era morto per avvelenamento da alcol.
Questo pover'uomo soffriva da tempo di questa dipendenza, ma quando gli è stato detto che il suo unico figlio si era impiccato per problemi di traffico di droga, ha perso il controllo: è diventato disperato e si è aggrappato alla bottiglia come un naufrago a una tavola. Trascorse un anno così, immerso nell'angoscia più terribile, finché il suo corpo non ne poté più e si arrese alla vita.
Margarita raccontò queste disgrazie a Rodrigo e José Miguel come se fossero amici di vecchia data, a lungo e nei dettagli: riuscì a parlare, a lamentarsi e a piangere. Dopo un'ora e mezza di catarsi, sentì di aver finito: si asciugò le lacrime con un fazzoletto e guardò i miei amici negli occhi, o quello che ne rimaneva, perché ormai erano come pietrificati dallo shock. Marguerite sorrise infantilmente e li ringraziò: "Se non fosse stato per voi, non avrei avuto nessuno con cui sfogarmi... ora mi sento più sollevata". Grazie.
Hanno risposto brevemente e si sono resi conto di essere in ritardo, quindi si sono salutati. Aprendo la porta, strizzò loro l'occhio con l'occhio sano e, pregandoli con gli occhi di tornare, aggiunse: "Non mi stancherò mai di voi, ve lo prometto! Si separarono e lei andò in cucina a preparare il pranzo, sorridendo, mentre l'orologio a muro riprendeva il suo solito ritmo lento.
Rodrigo tornò quindici giorni dopo. Questa volta con la sorpresa di essere accompagnato da José Tomás, uno studente paffuto e simpatico nato a Talca, proprio come Margarita! La conversazione è stata accattivante ed è stata intervallata da risate e allegria, hanno persino preso una selfie. La cerimonia di addio ha avuto un finale più festoso: "Le mie porte sono aperte per voi, e ancora di più se viene un talquino", ha detto loro, raggiante di gioia.
Nei mesi successivi ci furono altre tre visite, in cui Rodrigo riuscì a farsi accompagnare da altri studenti universitari: furono scattate altre foto, un giorno José Tomás regalò a Margarita due di queste foto incorniciate, lei scherzò con il Talquino e si accomiatò con frasi tenere e varie come: "Grazie di essere venuti, ragazzi, vi ho come famiglia" o "Devo ringraziare Dio per aver mandato questi ragazzi all'università". lolos così bello vedermi".
In ottobre ho aderito al progetto di visitare Margarita per la prima volta. A quel punto eravamo in sei nell'entourage. Ricordo che parcheggiammo alla stazione di polizia locale, come eravamo soliti fare, e iniziammo a camminare per la città con le nostre magliette bianche.
Era un sabato mattina molto azzurro e caldo, senza nuvole, le bande di spacciatori dormivano nonostante il reggaeton ad alto volume che sgorgava da alcune case come getti musicali, le signore uscivano dalle loro case spingendo piccole valigie di tela su ruote per comprare verdure al mercato del quartiere, i bambini giocavano a calcio per strada e fermavano la palla per guardarci con un certo scetticismo.
Quando arrivammo all'angolo che si affacciava sul vicolo della nonna, ci rendemmo conto che era successo qualcosa. I vicini hanno appeso palloncini bianchi su molte porte d'ingresso. Sullo sfondo, presso la casa con il cancello bianco dove viveva Margarita, abbiamo visto una folla di persone.
Rodrigo sorrise, anche se con disagio: "Mi ha detto che sua figlia si sposava, ma non sapevo che sarebbe stato oggi. Andiamo!", e riprese il passo. Lo seguimmo e non appena raggiungemmo i gradini d'ingresso, vedemmo la porta aprirsi e una quindicina di persone molto serie, vestite in modo casual ma dignitoso, che ci guardavano.
In mezzo al gruppo, spiccava un uomo di mezza età che, appoggiandosi alle spalle degli altri, ci osservava con particolare intensità. Era calvo, indossava una giacca e pantaloni sportivi e scarpe da ginnastica sporche. Con un rapido movimento si tolse gli occhiali da sole e si sporse per guardarci meglio con i suoi occhi arrossati. Sembrava averci riconosciuto, si è fatto strada tra la folla e ha sceso i tre gradini che ci separavano per salutarci con una smorfia di amarezza, rimorso e gratitudine: "Siete venuti, siete venuti, non posso credere che siate venuti anche alla veglia di mia madre, grazie, grazie", ha esclamato, stringendo calorosamente la mano a ciascuno di noi mentre elaboravamo ciò che stava accadendo.
Siamo entrati in casa e ci ha presentato i suoi fratelli, tre uomini grassi e mal rasati il cui volto piatto mostrava una tristezza densa e criptica, e una donna larga che sembrava più empatica. Ci hanno salutato con uno sguardo di profondo rispetto e ci siamo ritrovati improvvisamente in prima fila, attorno alla bara dove riposava in pace la Señora Margarita. La sorpresa che abbiamo ricevuto è stata enorme, non ce l'aspettavamo affatto!
Attraverso il vetro che mostrava il volto della defunta, vidi che stava sorridendo, per l'ultima volta. Esprimeva gioia pura, come se volesse lasciarci la sua forza, la sua fiducia in Dio, la sua gratitudine per la vita. I parenti ci guardavano dalle pareti, ma noi eravamo rimasti assorti, con lo sguardo fisso su quegli occhi chiusi, quelle sopracciglia calme e quel sorriso sincero. Il figlio che ci aveva accolto, lottando con le lacrime che continuavano a fuoriuscire come un rubinetto chiuso male, ha rotto il ghiaccio. In tono confidenziale, ma con l'evidente intenzione di farsi ascoltare da tutti, ci disse:
-Non andavo a trovare mia madre da due o tre anni. Ci siamo sentiti al telefono, ma molto saltuariamente. Negli ultimi mesi mi parlava solo di te e mi chiedeva se sapevo quando i ragazzi dell'università sarebbero tornati a trovarla..." Si asciugò le lacrime con la manica della tuta, sospirò come per riprendere fiato e continuò, pur guardando il pavimento, con un gemito: "L'avevamo abbandonata.
Anche i fratelli hanno abbassato lo sguardo, abbiamo aspettato qualche secondo e lui ha continuato con difficoltà.
-E mentre eravamo impegnati a fare le nostre cose, siete venuti a sostituirci. Avete dato a nostra madre una famiglia nei suoi ultimi mesi di vita. Per questo volevamo..." Guardò i suoi fratelli, che annuirono, e indicò un tavolino nell'angolo della stanza che non avevo notato prima. Volevamo mettere qui, ai piedi della Vergine, le due foto che avete fatto con la mia mamma.
Era lì, infatti, davanti a una statuetta di gesso della Madonna di Lourdes e a una foto del marito e a un'altra del figlio defunto, in prima fila, loro due al centro della stanza. selfie foto incorniciate che José Tomás aveva regalato a Margarita qualche tempo prima, di fronte alla bara. Non sapevamo cosa dire, ci si stringeva la gola e non riuscivamo a rispondere: Rodrigo fu il primo a piangere, poi anche José Tomás scoppiò a piangere, e alla fine piangemmo tutti, noi e i figli di Margarita, uniti al resto dei familiari che avevano assistito alla conversazione, tenendoci tutti per mano intorno alla bara. Abbiamo pregato un Padre Nostro, un'Ave Maria e un Gloria, tutti insieme in un indimenticabile momento di comunione, mentre contemplavamo il volto della compianta Margarita, tanto tormentato quanto sorridente, quel sorriso che attirava tutti gli sguardi e ci consolava con il pensiero che fosse in un luogo migliore, finalmente liberata dalle sofferenze della terra, abbracciata forse dal marito, dal figlio e dal nipote nell'aldilà; tanto dolore si è improvvisamente trasformato in felicità, come una rosa si schiude dopo essere stata innaffiata di lacrime e sangue. Il suo sorriso ci ha confortato: "Siete venuti! -Sembrava che volesse esclamare con una gioia incombustibile, "siete venuti persino alla mia veglia, bambini, grazie! A proposito, ho un aspetto sensazionale. Quando sono venuta qui per la prima volta vedevo Dio solo con gli occhi dell'anima, ma poi un serafino molto bello mi ha prestato alcuni degli occhi che porta nelle sue ali, e non potete immaginare come vedo bene qui! Venite presto, bambini, e non preoccupatevi troppo dei dolori che soffrite nella vita, perché tutto ciò trova qui la sua consolazione. Venite a trovarmi anche qui, non tardate!".
Siamo usciti in strada in silenzio, accompagnati dai fratelli con la serietà di una processione della Settimana Santa. Ci siamo guardati e non sapevamo come dirci addio. Prima un abbraccio, poi un altro. Promesse di preghiere, nuovi ringraziamenti, una foto. Alla fine riuscimmo a separarci e tornammo alla macchina, in silenzio, consapevoli che avremmo sempre portato Margarita e il suo sorriso nel cuore. Non eravamo medici, né psicologi, né assistenti sociali, è vero, nel senso che non potevamo darle un aiuto professionale, ma avevamo avuto la fortuna di essere stati adottati da Margarita come suoi nipoti, e così rimarremo per l'eternità.
Carisma e gerarchia nell'Opus Dei, due dimensioni della stessa realtà. Il rapporto tra i doni dello Spirito Santo nella Chiesa
Nella Chiesa, la dimensione gerarchica e quella carismatica sono inseparabili e si completano a vicenda. Questo è evidente anche nel caso dell'Opus Dei. Il recente motu proprio "Ad charisma tuendumcon cui Papa Francesco vuole promuovere la missione che l'Opus Dei svolge nella Chiesa. L'autore, noto canonista, commenta questo aspetto.
Traduzione dell'articolo in inglese
La dimensione istituzionale e quella carismatica sono due dimensioni che possono essere distinte, senza confonderle. Allo stesso tempo, essi sono necessari per la vita della Chiesa e complementari l'uno all'altro.
Non esiste una Chiesa che non sia gerarchica, fondata sugli Apostoli e governata dai loro successori, e allo stesso tempo non sia carismatica. Non esiste una Chiesa gerarchica e una Chiesa "del popolo".
Non esiste nemmeno una Chiesa che sia solo gerarchica senza essere allo stesso tempo carismatica.
In effetti, i carismi donati dallo Spirito Santo sono una realtà nella Chiesa fin dalla sua fondazione. Basta leggere le lettere di San Paolo per capire che esiste una grande varietà di doni dello Spirito, per l'utilità e il bene della Chiesa; alcuni sono dell'autorità, altri dei fedeli (come si può vedere, ad esempio, in 1 Cor 12, 28 e 1 Cor 14, 27-28).
I doni ricevuti dai battezzati nella comunità cristiana erano in ogni caso doni di diversa sostanza e contenuto. Ma non erano per un beneficio individuale, bensì per il bene della comunità. Pertanto, il loro esercizio deve essere ordinato, poiché è per l'edificazione, non per la distruzione.
Prendendo atto di questa realtà, il Concilio Vaticano II ha sottolineato che lo Spirito Santo fornisce e governa la Chiesa con doni gerarchici e carismatici. Come sottolinea la Costituzione Lumen gentium, n. 4, "lo Spirito Santo (...) guida la Chiesa in tutta la verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella comunione e nel ministero, la fornisce e la governa con vari doni gerarchici e carismatici e la abbellisce con i suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22)".
La dimensione gerarchica e carismatica negli ultimi Pontefici romani
Questa presenza dello Spirito Santo è stata particolarmente apprezzata dagli ultimi Pontefici romani. Un chiaro contributo di Giovanni Paolo II, riferendosi alla presenza di nuovi gruppi dotati di una notevole spinta carismatica ed evangelizzatrice, è stato quello di sottolineare che i doni dello Spirito sono essenziali per la Chiesa.
Così, ha detto: "In diverse occasioni ho sottolineato che non c'è alcun contrasto o contrapposizione nella Chiesa tra il dimensione istituzionale e il dimensione carismaticadi cui i movimenti sono un'espressione significativa. Entrambi sono ugualmente essenziali alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù, perché contribuiscono a rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera di salvezza nel mondo" (Messaggio ai partecipanti al Congresso Mondiale dei Movimenti Ecclesiali, 27 maggio 1998, n. 5). Se sono coessenziali, significa che appartengono alla natura e all'essere della Chiesa.
Papa Benedetto XVI, da parte sua, ha chiarito come le due dimensioni si combinino e si relazionino tra loro: "Anche nella Chiesa le istituzioni essenziali sono carismatiche e, d'altra parte, i carismi devono essere istituzionalizzati in un modo o nell'altro per avere coerenza e continuità. Così entrambe le dimensioni, suscitate dallo stesso Spirito Santo per lo stesso Corpo di Cristo, concorrono insieme a rendere presente il mistero e l'opera salvifica di Cristo nel mondo" (Discorso alla Fraternità di Comunione e Liberazione nel 25° anniversario del suo riconoscimento pontificio, 24 marzo 2007).
Sono due dimensioni che si intrecciano, che si completano, che sono sempre presenti, con maggiore o minore intensità. Come non ricordare che, unito alla figura del Romano Pontefice, c'è il carisma dell'infallibilità; che colui che è il successore degli Apostoli riceve i doni dello Spirito per governare e guidare la Chiesa, e che tra questi doni c'è il discernimento dell'autenticità dei carismi (come ha sottolineato la Congregazione per la Dottrina della Fede al n. 8 della Lettera "Il Romano Pontefice e i Romani Pontefici"). Iuvenescit EcclesiaLo stesso Spirito dona alla gerarchia della Chiesa la capacità di discernere i carismi autentici, di accoglierli con gioia e gratitudine, di promuoverli con generosità e di accompagnarli con paterna vigilanza"; è un dono ricevuto per il bene di tutto il popolo di Dio).
Anche Papa Francesco ha evidenziato l'armonia tra le due dimensioni: "Camminare insieme nella Chiesa, guidati dai Pastori, che hanno un carisma e un ministero speciale, è un segno dell'azione dello Spirito Santo; l'ecclesialità è una caratteristica fondamentale per i cristiani, per ogni comunità, per ogni movimento" (omelia della Veglia di Pentecoste con i movimenti ecclesiali, 19 maggio 2013), e ha sottolineato come i carismi nascano e fioriscano nelle comunità cristiane: "È nel cuore della comunità che germogliano e fioriscono i doni di cui il Padre ci ricolma; ed è all'interno della comunità dove si impara a riconoscerli come segno del suo amore per tutti i suoi figli". Sono sempre ecclesiali e sono al servizio della Chiesa e dei suoi membri.
Nella lettera Iuvenescit EcclesiaNella sua lettera del 2016, la Congregazione per la Dottrina della Fede afferma: "In definitiva, è possibile riconoscere una convergenza del Magistero ecclesiale recente sulla coessenzialità tra i doni gerarchici e carismatici. La loro opposizione, così come la loro giustapposizione, sarebbe segno di una comprensione errata o insufficiente dell'azione dello Spirito Santo nella vita e nella missione della Chiesa".
La complementarietà tra gerarchia e carisma, nel caso dell'Opus Dei
Nel recente motu proprio Ad charisma tuendumIl 22 luglio 2022, Papa Francesco ha sottolineato ancora una volta la complementarietà dei doni gerarchici e carismatici. Infatti, la Prelatura della Opus Dei è stato costituito da Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica Ut sitper realizzare una finalità propria di questi organi gerarchici: la realizzazione di opere pastorali specifiche (l'altra finalità è quella di contribuire alla distribuzione del clero: decreto Presbyterorum Ordinisn. 10; Codice di Diritto Canonico, canone 294).
Come ricorda Papa Francesco nel Proemio del motu proprio, l'Opus Dei ha un compito speciale nella missione evangelizzatrice della Chiesa: vivere e diffondere il dono dello Spirito ricevuto da San Josemaría, che non è altro che diffondere la chiamata alla santità nel mondo, attraverso la santificazione del lavoro e dei compiti familiari e sociali del cristiano.
Per raggiungere questo obiettivo di diffondere la vocazione universale alla santità, che non è un compito esclusivo dell'Opus Dei, ma di tutta la Chiesa (cfr. Lumen gentium, n. 11, e Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exultate, 19 marzo 2018), la gerarchia ha creato una Prelatura, presentando un modello reale e pratico di vivere tale santità in mezzo al mondo.
Infatti, il cammino aperto dallo Spirito Santo il 2 ottobre 1928, data di fondazione dell'Opus Dei, ha portato frutti di santità tra una grande varietà di fedeli: uomini e donne, sposati e celibi, laici e chierici. Infatti, tra i fedeli dell'Opera alcuni hanno raggiunto la gloria degli altari: San Josemaría, il Beato Álvaro del Portillo e la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. L'Opus Dei è, infatti, un esempio possibile e reale di santità nel mondo.
A sua volta, la Santa Sede ha effettuato un discernimento del carisma dell'Opus Dei, dando la sua approvazione in vari momenti della sua storia (cfr. A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes, "El itinerario jurídico del Opus Dei: historia y defensa de un carisma", Pamplona 1989). Illanes, "El itinerario jurídico del Opus Dei: historia y defensa de un carisma", Pamplona 1989), e nel 1982 concluse che doveva configurarsi come Prelatura personale, configurazione che è stata confermata da Papa Francesco nel motu proprio (che allo stesso tempo modifica alcuni articoli della Costituzione apostolica Ut sit, nei punti in cui si specifica il rapporto con la Santa Sede: articoli 5 e 6).
Due dimensioni in una sola realtà
È normale che, di fronte ai doni carismatici e gerarchici, si tenda a pensare che i destinatari di entrambi siano persone diverse.
In questo caso, troviamo un'entità che è gerarchica (la sua guida è un Prelato, che agisce con la necessaria collaborazione di un presbiterio e di fedeli laici come membri: cfr. canoni 294 e 296, e Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica Ut sit, articoli 3 e 4), e allo stesso tempo carismatica: deve vivere e diffondere questo carisma. Tutti i suoi membri hanno ricevuto la chiamata di Dio a essere santi incarnando lo spirito che Dio ha dato al fondatore dell'Opera.
È quindi un esempio di entità in cui la complementarità tra doni gerarchici e carismatici diventa palpabile in una stessa realtà. Ogni realtà carismatica ha un rapporto con la funzione della gerarchia. In questo caso, oltre al normale rapporto con l'autorità, che ha decretato l'autenticità del carisma e che accompagna sempre questo carisma vivo che ha i suoi sviluppi nella storia, ci sono alcuni aspetti peculiari, come quello che ho appena indicato: una Prelatura con un Pastore, con un presbiterio e con dei laici destinati a diffondere un carisma a servizio del Popolo di Dio.
Rettore della Pontificia Università della Santa Croce, professore di diritto della persona, consulente del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Javier ViverSe l'arte non genera comunione, sarà qualsiasi altra cosa, ma non arte".
Il fotografo e scultore Javier Viver, autore dell'opera Madre di Hakuna, o il Bella Pastoraè una delle figure di spicco dell'arte sacra contemporanea in Spagna. Dal 25 luglio al 30 luglio, dirigerà il Osservatorio dell'invisibilein cui un centinaio di studenti e professionisti di diverse discipline artistiche condividono esperienze creative e riflessioni nell'ambito del Monastero di Guadalupe.
 María Tarruella OriolI miei dipinti sono preghiere".
María Tarruella OriolI miei dipinti sono preghiere". Arte e spiritualità si incontrano nell'"Osservatorio dell'invisibile".
Arte e spiritualità si incontrano nell'"Osservatorio dell'invisibile". Diana García Roy: "Cerco una scultura che rifletta lo spirito, che venga dal cuore in modo sincero".
Diana García Roy: "Cerco una scultura che rifletta lo spirito, che venga dal cuore in modo sincero".Dalle sue mani sono nate immagini mariane come la Madre di Hakuna, la Bella Pastora di Iesu Communio, la moglie di Lot o l'Angelo Custode che, da qualche giorno, si può ammirare nella Puerta del Ángel di Madrid. Javier Viver è uno dei punti di riferimento del arte sacra contemporanea in Spagna, ma è anche un prolifico autore di opere non religiose, sia scultoree che fotografiche.

Dallo scorso anno promuove, attraverso la Fundación Vía, la Osservatorio dell'invisibile. Una scuola estiva per studenti di diverse discipline artistiche che, per una settimana, si immergono in un'esperienza di arte e spiritualità nella cornice del Monastero di Guadalupe a Cáceres.
In questo contesto, Viver sottolinea in questa intervista con Omnes quello che per lui è il ruolo dell'artista nella società di oggi: "offrire un frammento di speranza, un pezzo di paradiso, alla società".
La prima esperienza dell'Osservatorio dell'Invisibile è stata un successo e questo ha portato all'ampliamento e alla continuazione del bando. Cosa definisce questa scuola estiva?
- La possibilità di condividere la creazione artistica con una grande diversità di artisti di tutte le discipline e di tutte le età. Oltre 100 partecipanti, tra cui artisti e studenti.
Perché ha scelto l'ambientazione del Monastero di Guadalupe?
- Il monastero è un centro storico di spiritualità e creazione artistica di primo ordine. Con capolavori di Zurbarán, El Greco e Goya.
Parlare dell'invisibile, che l'arte è la via per la materializzazione dello spirito
Può esistere l'arte inanimata?
- No, l'arte aspetta un'anima che la interpreti, che la riattivi.
L'artista crea per se stesso o per lo spettatore?
- Dal mio punto di vista crea per uno spettatore, per un lettore. L'arte come fenomeno culturale ha senso solo per una società. Se non genera comunicazione, comunione, sarà qualsiasi altra cosa, ma non arte.
Le opere più importanti sono quelle che collegano e risvegliano la contemplazione di altre anime, della loro generazione e di quelle a venire. In questo senso la loro proiezione è senza tempo, il loro pubblico universale e illimitato. L'arte a lungo termine è il miglior investimento.
Tra le sue opere a tema religioso più conosciute ci sono le immagini mariane della Bella Pastora o della Madre di Hakuna. Come immagina la Vergine?
- La Vergine Maria è la Chiesa nascente, la fanciulla di Nazareth che ha iniziato questa emozionante avventura che chiamiamo Chiesa. Prima la Chiesa domestica di Nazareth, poi la Chiesa gerarchica. Lei è la tradizione vivente della Chiesa, trasformata in storie domestiche che avrebbe poi raccontato ai discepoli di Gesù e che questi avrebbero trascritto nei vangeli e in altri scritti. Inoltre, Maria è l'iniziatrice della Via dell'Arte, via pulchritudinis.
Come le grandi donne della storia, è stata la grande narratrice domestica della storia della salvezza e la grande tessitrice. Fu la madre di Gesù e divenne la madre dei discepoli di Gesù.
L'arte è stata identificata, forse romanticamente, con gli outsider, i pazzi o i visionari... C'è del vero in questa identificazione?
- L'arte è sempre al limite, in quella regione dove appare il mistero, ciò che non si vede, ciò che non si capisce, ciò che rompe con il politicamente corretto.
In una società divisa tra continue rotture e nuovi schemi, qual è il ruolo dell'artista?
- Quella di rendere tutto nuovo e tutto vecchio. Quello di offrire un barlume di speranza alla sua società, un pezzo di paradiso, quello di rendere visibile l'invisibile.
Vittorio ScelzoRead more : "Gli anziani chiedono di non essere lasciati soli".
"È la prima volta nella storia che invecchiare è diventato un fenomeno di massa". Così dice Vittorio Scelzo, responsabile della pastorale degli anziani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in questa intervista per Omnes.
 "La Chiesa ha negli anziani un esercito di testimoni della Fede".
"La Chiesa ha negli anziani un esercito di testimoni della Fede". "Se abbiamo davvero a cuore gli anziani, dobbiamo ascoltarli".
"Se abbiamo davvero a cuore gli anziani, dobbiamo ascoltarli". Il Papa istituisce la prima Giornata mondiale degli anziani
Il Papa istituisce la prima Giornata mondiale degli anzianiOggi, per il secondo anno, la Chiesa celebra la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 2022 con il motto "Nella vecchiaia porterai ancora frutto". È stato preceduto da diversi mesi di catechesi sulla vecchiaiaPapa Francesco ha sviluppato nelle sue udienze del mercoledì, gli anziani e il ruolo della famiglia.
Scelzo sottolinea anche in questa intervista che gli anziani chiedono alla Chiesa, fondamentalmente "di non lasciarli soli, e la Chiesa, soprattutto con il magistero di Papa Francesco, è molto chiara: abbandonare gli anziani è un peccato grave".
Il messaggio del Papa per questa Giornata mette in luce una realtà tipica del primo mondo: la paura della vecchiaia. Come si ripercuote nella famiglia, nella Chiesa?
- Il Papa parla della paura di invecchiare. È una cosa di cui siamo tutti chiaramente consapevoli: associamo la vecchiaia alla perdita di autonomia, di salute. Spesso si pensa che invecchiare significhi in qualche modo perdere la dignità a causa della fragilità che sperimentiamo.
Eppure invecchiare - così recita il messaggio - è un dono. Dopo tutto, per secoli uno dei grandi obiettivi dell'umanità è stato quello di vivere a lungo. Ora che l'allungamento della vita è diventato una realtà per molti, le nostre società sembrano impreparate.
La vecchiaia è qualcosa di nuovo. È la prima volta nella storia che invecchiare è diventato un fenomeno di massa. Non siamo preparati ed è per questo che il Papa dedica tanta attenzione agli anziani: è necessario sviluppare una riflessione su questa età della vita. Sarà una delle sfide più importanti dei prossimi anni.
La popolazione, e quindi i membri della Chiesa, in Occidente sono per lo più anziani. Questo è anche un sfida pastoraleCome possiamo coinvolgere gli anziani nel lavoro della Chiesa quando potrebbero non essere del tutto in forma?
- Spesso sono coinvolti gli anziani, sono loro a gestire le nostre parrocchie, sono loro i protagonisti del nostro impegno nella carità. Basta guardarsi intorno nella Chiesa per vedere che sono quelli che frequentano più assiduamente la Messa. Ma c'è una sfida che ci viene posta da coloro che non sono in piena forma.
Tornando al brano del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, direi che siamo interpellati da Maria: capire che essere cristiani non significa solo correre dietro alle tante cose da fare, ma riscoprire la centralità dell'ascolto e della preghiera.
Il Papa, nel suo Messaggio per la Giornata mondiale dei nonni e degli anzianiIl Signore affida il compito della preghiera agli anziani. Non è un impegno residuale, ne va del futuro della Chiesa e del mondo: la tradizione ebraica dice che è la preghiera dei giusti a sostenere il mondo.
In questo momento, mi sembra che forse la prima urgenza pastorale sia quella di elevare la preghiera per la pace in Ucraina, e gli anziani, che conoscono l'orrore della guerra, in questa prospettiva, non sono in retroguardia, ma tra i pionieri.
In un mondo in cui la solitudine è sempre più presente, soprattutto nella popolazione anziana, cosa chiedono gli anziani alla Chiesa?
- L'isolamento è la grande malattia degli anziani e la nostra società rischia di prenderla. Ci stiamo abituando a pensare che la solitudine sia normale e la pandemia l'ha fatta sembrare inevitabile.
Ma Dio - non a caso questa è una delle prime parole della Bibbia - non vuole che l'uomo sia solo.
Gli anziani chiedono di non essere lasciati soli e la Chiesa, soprattutto con il magistero di Papa Francesco, è molto chiara: abbandonare gli anziani è un peccato grave.
Tuttavia, vediamo molteplici manifestazioni della cultura dell'usa e getta, che purtroppo si manifesta anche all'interno delle famiglie cristiane.
Il Papa incoraggia anche gli anziani a essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza di cui il mondo ha bisogno. In questo senso, come si possono coniugare in famiglia la tenerezza e l'insegnamento della responsabilità?
- Il Papa nel suo messaggio associa la parola tenerezza con la parola non più di moda rivoluzione. Credo che intenda dire che un comportamento improntato a questo atteggiamento dovrebbe essere il seme del cambiamento nelle nostre città.
Ci chiede di avere per i più poveri - cita in particolare i rifugiati della guerra in Ucraina e gli altri che macchiano di sangue il nostro mondo - un pensiero e un atteggiamento tenero.
Gli anziani possono fare molto (stiamo assistendo a un grande movimento di solidarietà) non solo dal punto di vista pratico e dell'accoglienza, ma possono aiutarci a stemperare il clima, a capire - come molti di loro hanno dovuto fare - che non possiamo salvarci da soli.
È il magistero della fragilità di cui ha parlato il Papa in una delle ultime udienze del mercoledì: la saggezza di chi capisce di non bastare a se stesso e l'inutilità dell'opposizione a tutti i costi.
Allo stesso tempo, consapevoli di tutto questo, come possiamo incoraggiare le giovani generazioni a partecipare attivamente alla Chiesa e alla società?
- Il Papa parla spesso di alleanza tra le generazioni. Mi ha sempre colpito il fatto che la prima volta che ha parlato degli anziani è stato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro.
La domanda che lei pone è davvero molto complessa, ma - sicuramente - parte della risposta sta nella riscoperta (o nella costruzione) di un legame tra giovani e anziani. Non è solo una bella idea: conosciamo molte esperienze che ci dicono che l'incontro tra giovani e anziani è sempre un'esperienza molto ricca per tutti.
Negli ultimi mesi abbiamo sentito il Papa non solo parlare degli anziani, ma anche rivolgersi a loro, alludendo agli atteggiamenti che ostacolano la convivenza intergenerazionale. Come può la Chiesa promuovere questa comprensione reciproca al di là di una visita di un giorno?
- Prima di tutto, facciamo questa visita! Il Papa scrive nel suo messaggio che spesso un'amicizia nasce da una prima visita. Fare un passo verso gli altri, soprattutto verso i più deboli, ha sempre un valore, ed è quello che chiediamo a tutti nella Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani: andiamo a trovare un anziano che si sente solo! Soprattutto in questo periodo di caldo torrido, che nessuno viva questo giorno da solo!
Poi il Papa, con la sua caratteristica concretezza, parla agli anziani e non degli anziani perché sono una gran parte dei laici. Gli anziani sono tanti e saranno sempre più numerosi, come possiamo continuare a ignorarli?
24 luglio: Papa Francesco dedica una giornata ai nonni e agli anziani
Domenica prossima, 24 luglio, si celebrerà in tutto il mondo la Giornata mondiale degli anziani e dei nonni 2022. Anche le parrocchie, le diocesi e le comunità ecclesiali sono chiamate a celebrare con creatività e in modo decentrato questa festa, che quest'anno ha come motto "Nella vecchiaia continueranno a portare frutto".
La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è diventata uno degli eventi che portano la firma inconfondibile del Papa argentino. L'anno scorso è stato lo stesso Papa Francesco a voler istituire una giornata dedicata esclusivamente ai nonni e agli anziani. La Giornata si terrà ogni anno la quarta domenica di luglio, in occasione della festa dei santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù.
Quest'anno si terrà domenica 24 luglio con la celebrazione di un'Eucaristia in San Pietro da parte del Cardinale De Donatis, Vicario Generale per la Diocesi di Roma. De Donatis, Vicario Generale per la Diocesi di Roma. Lo stesso giorno, il Papa inizia un viaggio apostolico in Canada, durante il quale intende visitare il Santuario di Sant'Anna e incontrare i giovani e gli anziani di una scuola elementare di Iqaluit.
"Per favore, non lasciateli soli" è una delle frasi che il Pontefice ha ripetuto più spesso in riferimento alla cura e all'attenzione degli anziani, e l'istituzione della Giornata è un segno della sua attenzione a questo tema. Non invano ha voluto dedicare una buona parte delle udienze del mercoledì per parlare della fase della vecchiaia e della ricchezza che gli anziani rappresentano per le famiglie e per la società.
"È importante che i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti incontrino i nonni, perché - come dice il profeta Gioele - i nonni sogneranno davanti ai nipoti, avranno delle illusioni (grandi desideri), e i giovani, prendendo forza dai nonni, andranno avanti, profetizzeranno".
Oltre all'evento di domenica prossima, in questo mese di luglio i cristiani stanno pregando soprattutto per gli anziani; l'intenzione di preghiera che Francesco affida a tutta la Chiesa in questo mese, attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa, è proprio quella di pregare per gli anziani.
Nel videomessaggio, il Papa riflette su questa fase della vita: "La vecchiaia, infatti, non è una tappa facile da comprendere, anche per noi che già la viviamo. Anche se arriva dopo un lungo percorso, nessuno ci ha preparato ad affrontarlo, e sembra quasi che ci colga di sorpresa". Il Papa invita gli anziani a continuare a dare tutto quello che possono dare perché gli anziani hanno "una sensibilità speciale per la cura, per la riflessione e per l'affetto" e li invita ad essere Siamo, o possiamo diventare, protagonisti di una "rivoluzione della tenerezza".
"Molte persone hanno paura della vecchiaia", esordisce il Papa nel messaggio preparato per l'evento, "la considerano una specie di malattia con cui è meglio non entrare in contatto. Gli anziani non ci interessano - pensano - ed è meglio che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra di loro, in strutture dove sono assistiti e che ci risparmiano di doverci occupare delle loro preoccupazioni". Papa Francesco vuole essere vicino a tutti gli anziani e lo fa parlando loro a tu per tu, mostrando che anche lui è anziano: "E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande responsabilità: insegnare alle donne e agli uomini del nostro tempo a vedere gli altri con la stessa comprensione e lo stesso sguardo tenero che rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la nostra umanità prendendoci cura degli altri e oggi possiamo essere maestri di uno stile di vita pacifico, attento ai più deboli.
"Gli anziani - prosegue il Papa - aiutano a percepire "la continuità delle generazioni", con "il carisma di servire da ponte". Spesso sono i nonni a garantire la trasmissione di grandi valori ai nipoti e "molte persone possono riconoscere che è proprio ai nonni che devono la loro iniziazione alla vita cristiana".
Con queste parole, il Papa vuole farci capire che la costruzione di un mondo migliore passa anche attraverso la rivalutazione della figura dei nostri anziani, andando "controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita", incoraggiando gli anziani a non mantenere un atteggiamento rassegnato", "con poca speranza e senza aspettarsi più nulla dal futuro".
Una Chiesa vicina agli anziani
Il Papa ha affrontato questo tema in modo più approfondito anche in altri messaggi e documenti papali, come l'Esortazione apostolica Amoris Laetitia: "La Chiesa non può e non vuole conformarsi a una mentalità di intolleranza, tanto meno di indifferenza e disprezzo, nei confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare un senso collettivo di gratitudine, apprezzamento e ospitalità, che faccia sentire gli anziani parte viva della loro comunità". In questo senso, la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è un appello a tutte le famiglie, e alla società nel suo complesso, a restituire agli anziani tutto il valore che hanno e a trattarli come meritano, invitandoli a "continuare a portare frutto".
In una società in cui si apprezza solo ciò che è di immediato beneficio, i nonni e gli anziani si trovano sempre più soli e trascurati, a volte anche dalle loro stesse famiglie. La più volte citata "cultura dell'usa e getta" del Papa si riferisce anche a questo; l'assistenza agli anziani non ha alcun beneficio a breve termine e la cura dei loro bisogni quotidiani è faticosa e ripetitiva, e spesso diventa un ulteriore peso nella vita quotidiana delle famiglie. Tuttavia, come dice il Papa nell'Esortazione apostolica Amoris Laetitia: "Una famiglia che non rispetta e non si prende cura dei nonni, che sono la sua memoria vivente, è una famiglia disintegrata, ma una famiglia che ricorda è una famiglia con un futuro".
La Jornada
In questo secondo anno della Giornata dedicata ai nonni e agli anziani, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita suggerisce due modi per partecipare: celebrare l'Eucaristia o visitare gli anziani da soli.
Lo stesso Dicastero ha messo a disposizione delle varie diocesi una serie di materiali e suggerimenti pastorali e liturgici, disponibili sul sito web del Dicastero. Tra le raccomandazioni formulate, una delle più importanti è quella di visitare o accompagnare gli anziani soli.
Infatti, la Chiesa concede la facoltà di ottenere l'indulgenza plenaria alle solite condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera per le intenzioni del Sommo Pontefice. Sarà concesso ai nonni, agli anziani e ai fedeli che parteciperanno alla Messa del 24 luglio nella Basilica di San Pietro o alle varie celebrazioni che si terranno in tutto il mondo. L'indulgenza può essere utilizzata anche come suffragio per le anime del purgatorio.
Inoltre, la stessa Indulgenza Plenaria sarà concessa agli anziani malati e a tutti coloro che, "impossibilitati a lasciare la propria casa per un grave motivo, si uniscono spiritualmente alle sacre celebrazioni della Giornata Mondiale, offrendo a Dio Misericordioso le loro preghiere, i dolori e le sofferenze della propria vita, specialmente mentre le parole del Pontefice e le varie celebrazioni vengono trasmesse dai media".
La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è anche il punto di partenza per sviluppare un approccio pastorale specifico che raggiunga efficacemente questa parte della società che, come dice il Papa, attraversa la fase più solitaria della vita e spesso non sa come viverla perché "ci sono molti progetti di assistenza" per gli anziani ma "pochi progetti di esistenza".
Il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, parlando dell'organizzazione dell'evento di domenica, ha osservato che con la Giornata il Santo Padre "ci invita a prendere coscienza della rilevanza degli anziani nella vita delle società e delle nostre comunità, e a farlo in modo non episodico ma strutturale, e la Giornata aiuta a porre le basi per una pastorale ordinaria di questo tempo della vita".
Giorgio MarengoLa cosa più importante è la fedeltà al Signore".
Il futuro cardinale Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, guida una comunità che rappresenta 1% dei suoi concittadini. La chiave per la crescita della Chiesa in questo Paese di missione è, come egli sottolinea, l'accompagnamento dei convertiti e la coerenza di vita.
 Mons. Fernando Vérgez, L.C.: "Abbiamo bisogno di testimoni del Vangelo che sappiano scuotere le coscienze".
Mons. Fernando Vérgez, L.C.: "Abbiamo bisogno di testimoni del Vangelo che sappiano scuotere le coscienze". Come sono i nuovi cardinali scelti da Francesco?
Come sono i nuovi cardinali scelti da Francesco? Il Papa annuncia la creazione di nuovi cardinali
Il Papa annuncia la creazione di nuovi cardinali"Pensare di nominare cardinale un vescovo che guida una Chiesa piccola e minoritaria è un grande gesto missionario". Padre Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, si trovava a Roma quando apprese, con sorpresa, della sua nomina a cardinale: "In quei giorni - racconta il missionario della Consolata - avevo accompagnato una delegazione di buddisti mongoli dal Santo Padre: era la prima volta che accadeva. Avevamo appena concluso questa bella e storica iniziativa di dialogo interreligioso quando, durante il Regina Colei di domenica 29 maggio, ho sentito il Pontefice chiamare il mio nome. In quel momento sono stato sopraffatto da una gioia fortissima e da un sentimento di profonda gratitudine e umiltà.
La Chiesa guidata da monsignor Marengo nel Paese dell'Asia orientale è molto piccola: 1.400 fedeli su poco più di tre milioni di abitanti, otto parrocchie e una chiesa pubblica non ancora riconosciuta come parrocchia.
"Qui la maggioranza della popolazione è di fede buddista, mentre i cattolici sono meno dell'1%. Diverso è il discorso per i cristiani protestanti - evangelici e pentecostali - che sono più numerosi dei cattolici", aggiunge Mons. Marengo.
Qual è l'opera di evangelizzazione della Chiesa cattolica in Mongolia?
- Rispondo con un'immagine poetica presa in prestito da un grande pastore salesiano, l'arcivescovo emerito indiano Thomas Menamparampil: cerchiamo di sussurrare il Vangelo al cuore della Mongolia. È un'espressione che parla del nostro impegno per una testimonianza costante del Vangelo: un annuncio discreto, non rumoroso.
Le 70% nostre attività sono opere di promozione umana: istruzione, salute, assistenza alle persone in difficoltà, ma anche conservazione della cultura mongola.
Poi, naturalmente, c'è la celebrazione dei sacramenti. La Chiesa è impegnata su molti fronti e cerca di avere come atteggiamento di base il desiderio di condividere la gioia del Vangelo in modo umile ma profondo.

Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della rinascita della Chiesa in Mongolia e del stabilimento del delle relazioni diplomatiche tra il Paese e la Santa Sede. In breve, cosa si può dire di questo trentesimo anniversario?
- Trent'anni non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti. Tuttavia, è stato un periodo cospicuo in cui la Chiesa ha potuto presentarsi e mettere radici. Se oggi abbiamo nove comunità cattoliche nella zona, è segno che il Vangelo è stato accolto e viene vissuto nella pratica.
All'inizio, è stato un periodo segnato dal pionierismo in una nazione che ha visto improvvisamente crollare un regime caratterizzato dal comunismo e dall'ateismo di Stato e cadere in una fase di disorientamento e povertà. È in questo preciso momento storico che arrivarono i primi tre missionari, tra cui monsignor Wenceslao Selga Padilla, primo prefetto apostolico di Ulaanbaatar. Hanno iniziato a realizzare progetti concreti di amicizia e solidarietà, con l'obiettivo di creare relazioni di fiducia che durassero nel tempo.
Ma cosa riserva il futuro alla Chiesa in Mongolia?
- C'è ancora molto da fare. Questo primo nucleo emergente di vita cristiana ha ancora bisogno di molte cure per continuare a crescere e per poter ottenere una dimensione missionaria all'interno del nostro Paese che sia il segno della sua evangelizzazione.
In questo senso, una delle sfide principali sarà quella della profondità: accompagnare chi è diventato cristiano permettendo alla fede di raggiungere le profondità della persona e, di conseguenza, della società stessa. Tuttavia, come dice il Papa, i piani e le strategie pastorali vanno bene, ma ciò che conta di più è la fedeltà al Signore praticata in una vita cristiana coerente.
La Prefettura apostolica di Ulaanbaatar, unica chiesa in tutta la Mongolia, è stata recentemente inclusa come membro della neonata Conferenza episcopale dell'Asia centrale. Come vede questa decisione?
- Prima di questa decisione, la nostra Chiesa locale non faceva parte di alcuna Conferenza episcopale. Il mio predecessore, il vescovo Wenceslao Selga Padilla, ha fatto riferimento, a titolo personale, alla Conferenza episcopale della Corea del Sud, con la quale continuiamo a mantenere ottimi rapporti anche oggi. Con il passare del tempo, e nella prospettiva sinodale tanto cara a Papa Francesco, è sembrato opportuno individuare un'assemblea più vicina a cui aderire per esercitare la collegialità in modo più concreto.
Come la Provvidenza ha voluto, nell'autunno dell'anno scorso il Conferenza episcopale dell'Asia centralel, a cui aderiamo con pieno accordo. Questa elezione è per noi un vero arricchimento perché, come per tutti i pastori delle Chiese locali, è bene avere un punto di riferimento collegiale.
"Ad charisma tuendum" concretizza la figura della Prelatura dell'Opus Dei
La Santa Sede ha reso pubblica la Lettera apostolica sotto forma di Motu Proprio Ad charisma tuendum di Papa Francesco che modifica alcuni articoli del Codice Civile. Costituzione Apostolica Ut sitcon cui Giovanni Paolo II ha eretto l'Opus Dei a Prelatura personale.
Traduzione dell'articolo in inglese
La Santa Sede ha pubblicato la Lettera apostolica di Papa Francesco sotto forma di Motu Proprio. Ad charisma tuendum. Questo Motu proprio modifica alcuni articoli della Costituzione apostolica Ut sit del 28 novembre 1982, con la quale San Giovanni Paolo II ha eretto l'Opus Dei a Prelatura personale.
Fondato nel 1928 dal sacerdote San Josemaría Escrivá, l'Opus Dei è attualmente l'unica prelatura personale della Chiesa cattolica e recentemente, con la pubblicazione della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia romana, è passato sotto il Dicastero per il Clero e non sotto quello per i Vescovi, come era stato finora.
Il prelato dell'Opus Dei, monsignor Fernando Ocáriz, ha pubblicato una breve nota su questo Motu Proprio in cui sottolinea che l'Opus Dei "accetta filialmente" la nuova ordinanza.
Approfondire il carisma dell'Opera
In essa, il Prelato dell'Opus Dei sottolinea l'interesse del Papa a curare "il carisma dell'Opus Dei", poiché desidera, come già espresso da Giovanni Paolo II nella Costituzione Ut sit, "che esso sia sempre uno strumento adeguato ed efficace della missione salvifica che la Chiesa svolge per la vita del mondo".
Per questo motivo, Mons. Ocáriz incoraggia i fedeli della Prelatura ad "approfondire lo spirito che il Signore ha infuso nel nostro fondatore e a condividerlo con molte persone nell'ambiente familiare, lavorativo e sociale", che consiste nel "diffondere la chiamata alla santità nel mondo, attraverso la santificazione del lavoro e delle occupazioni familiari e sociali".
I media della Santa Sede, nel presentare il documento, hanno anche sottolineato l'obiettivo di proteggere il carisma dell'Opus Dei e di promuovere l'opera di evangelizzazione svolta dai suoi membri in tutto il mondo. L'Opus Dei, da parte sua, ha pubblicato nel suou sito web una spiegazione del nuovo documento sotto forma di dieci domande e risposte..
Modifiche alla Costituzione Apostolica Ut sit
In particolare, il nuovo Motu Proprio stabilisce, ad esempio, la modifica del testo dell'articolo 5 della Costituzione Apostolica Ut sit, che viene ora sostituito dal seguente: "In conformità all'art. 117 della Costituzione Apostolica Ut sit, il nuovo Motu Proprio prevede un nuovo testo per la Costituzione Apostolica Ut sit. Costituzione Apostolica Praedicate EvangeliumLa Prelatura dipende dal Dicastero per il Clero che, a seconda della questione, valuterà le relative questioni con gli altri Dicasteri della Curia romana. Il Dicastero per il Clero, nel trattare le varie questioni, si avvarrà delle competenze degli altri Dicasteri attraverso opportune consultazioni o trasferimenti di pratiche". In questo senso, "tutte le questioni pendenti presso la Congregazione per i Vescovi riguardanti la Prelatura dell'Opus Dei continueranno ad essere trattate e decise dal Dicastero per il Clero".
Cambia anche la frequenza con cui l'Opus Dei deve, d'ora in poi, presentare una relazione sulla situazione della Prelatura e sullo sviluppo del suo lavoro apostolico, che diventa annuale e non più quinquennale, come stabilito dalla Costituzione Ut sit.
Il Motu Proprio afferma inoltre che, a seguito di queste modifiche, "gli Statuti propri della Prelatura dell'Opus Dei saranno opportunamente adattati su proposta della Prelatura stessa, per essere approvati dagli organi competenti della Sede Apostolica".
Il prelato non diventerà vescovo
Per quanto riguarda la figura del Prelato dell'Opus Dei, Ad charisma tuendum stabilisce che il prelato non riceverà ordini episcopali.
Una decisione "per rafforzare la convinzione che una forma di governo basata più sul carisma che sull'autorità gerarchica è necessaria per la protezione del particolare dono dello Spirito".
Al Prelato dell'Opus Dei è invece concesso, in ragione del suo ufficio, l'uso del titolo di Protonotario Apostolico Soprannumerario con il titolo di Reverendo Monsignore e, pertanto, può usare le insegne corrispondenti a questo titolo.
A questo proposito, il vescovo Fernando Ocáriz ha voluto ricordare che "l'ordinazione episcopale del prelato non era e non è necessaria per la guida dell'Opus Dei". In realtà, san Josemaría Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, non era vescovo; e il suo primo successore, il beato Álvaro del Portillo, fu ordinato vescovo nel 1991, tre anni prima della sua morte. Successivamente, il vescovo prelato Javier Echevarría è stato ordinato nel 1995, poco dopo aver assunto il governo dell'Opera.
Su questa linea, monsignor Ocáriz ha incoraggiato il rilancio dello spirito di famiglia dell'Opus Dei, sottolineando che "il desiderio del Papa di enfatizzare la dimensione carismatica dell'Opera ci invita ora a rafforzare il clima familiare di affetto e fiducia: il prelato deve essere una guida, ma soprattutto un padre".
Garantire la libertà di religione in tutte le sue manifestazioni e in ogni luogo.
La Pontificia Università Gregoriana ha ospitato la tre giorni del Religious Liberty Summit, promosso annualmente dall'Università americana di Notre Dame sul tema del futuro della libertà religiosa nel mondo.
Il tema centrale del vertice è la Dignitatis HumanaeLa dichiarazione del Concilio Vaticano II che esprime il sostegno della Chiesa cattolica alla tutela della libertà religiosa e stabilisce le norme fondamentali per il rapporto della Chiesa con gli Stati.
Il vertice di quest'anno a Roma sottolinea la portata globale dell'iniziativa, che nel 2021 si è tenuta presso la stessa Università di Notre Dame.
"La libertà religiosa è un diritto umano fondamentale e la sua tutela è una questione globale", ha dichiarato G. Marcus Cole, preside e professore di diritto alla Notre Dame Law School, presentando l'iniziativa. "Ogni persona al mondo ha il diritto, riconosciuto da Dio, di vivere la propria vita secondo le proprie convinzioni, con orgoglio e senza paura", ha aggiunto Cole.
Sulla base di questi principi, Notre Dame promuove e difende la libertà religiosa per le persone di tutte le fedi attraverso studi, eventi e il lavoro della sua scuola di legge. Al centro vi è la tutela del diritto di culto, la difesa dei beni sacri dalle minacce di distruzione, la promozione della libertà di scelta dei ministri della fede e la prevenzione della discriminazione delle scuole e degli insegnamenti religiosi.
L'obiettivo del summit è stimolare il dibattito tra studiosi e leader religiosi sul futuro della libertà religiosa negli Stati Uniti e nel mondo. Il vertice è previsto per oggi tra due dei più importanti filosofi e intellettuali contemporanei: Cornel West dell'Union Theological Seminary e Robert P. George dell'Università di Princeton.
In particolare, il premio Notre Dame 2022 Religious Liberty Award è stato consegnato a Mary Ann Glendon, professoressa emerita di diritto alla Harvard Law School ed ex ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Santa Sede. Glendon è stata premiata per la sua profonda e innovativa ricerca legale e per il suo servizio agli Stati Uniti e alla Chiesa cattolica, con un impatto globale sulla premessa della libertà religiosa come diritto umano fondamentale.
Steven Smith, professore di diritto e co-direttore esecutivo dell'Institute for Law and Religion presso la University of San Diego School of Law, ha ricevuto il premio 2022 Religious Freedom Initiative.
Attacchi alla libertà religiosa
La libertà religiosa è sotto attacco in tutto il mondo. "La violenza è salita a livelli storici nell'ultimo decennio, colpendo quasi tutti i gruppi religiosi", ha dichiarato Samah Norquist, studiosa del Wilson Center di Washington. "I credenti di quasi tutte le fedi - cristiani, musulmani ed ebrei, buddisti, yazidi, bahaisti - hanno affrontato discriminazioni, molestie, repressioni e, naturalmente, persecuzioni da parte di attori statali e non statali e di movimenti ideologici", ha dichiarato Norquist. Dello stesso avviso è stata Nury Turkel, presidente della Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale, un organo consultivo bipartisan e indipendente che monitora la libertà religiosa all'estero.
Turkel ha lanciato l'allarme sul deterioramento della libertà religiosa in Cina, dove il governo ha continuato a "perseguire vigorosamente la sua politica di 'sinizzazione della religione'" e ha richiesto che i gruppi religiosi e i loro aderenti sostengano il governo e l'ideologia del Partito Comunista Cinese (PCC).
Sebbene la Cina riconosca il buddismo, il cattolicesimo, l'islam, il protestantesimo e il taoismo, gli aderenti a religioni con presunta influenza straniera - come il cristianesimo, l'islam e il buddismo tibetano - e quelli di altri movimenti religiosi sono particolarmente vulnerabili alle persecuzioni, ha dichiarato Turkel, un avvocato americano di etnia uigura.
Per tutto il 2021, le autorità dello Xinjiang hanno continuato a detenere arbitrariamente uiguri e altri musulmani turchi in campi di internamento e strutture carcerarie per vari motivi religiosi.
Più di un milione di uiguri sono stati imprigionati in campi di concentramento per aver semplicemente venerato Allah e non Xi Xinping. Sono stati sottoposti a numerosi abusi, tra cui torture, stupri, lavori forzati e omicidi. Il "peggior incubo" per il PCC, ha osservato Turkel, sono le comunità che hanno a cuore i diritti umani e la dignità umana. Una popolazione religiosa compromessa, sostiene Turkel, è anche una minaccia per il governo cinese, perché il suo regime autoritario è incompatibile con la libertà religiosa.
Il punto è non permettere che gli abusi della libertà religiosa passino inosservati, sia per azione del governo - come nel caso della Cina - sia per inazione, come in Paesi come la Nigeria, dove la persecuzione religiosa continua ad aumentare.
Le ricerche hanno dimostrato", ha concluso il presidente della Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale, "che i Paesi che sostengono la libertà religiosa hanno istituzioni politiche più vivaci e democratiche, maggiore benessere economico e sociale, riduzione delle tensioni e della violenza e maggiore stabilità. Le nazioni che calpestano o non proteggono i diritti umani fondamentali, compresa la libertà religiosa, forniscono un terreno fertile per la povertà e l'insicurezza, la guerra e il terrore, nonché per movimenti e attività violente e radicali".
"Quali sono le libertà religiose di cui ci preoccupiamo?
All'apertura del vertice, Dallin H. Oaks, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, ha chiesto che
uno sforzo globale e multireligioso per difendere e promuovere la libertà religiosa in tutte le nazioni del mondo.
Ecco le sue parole: "Quali sono le libertà religiose di cui ci preoccupiamo? Per le comunità religiose, la Costituzione degli Stati Uniti garantisce la libertà di associazione e il diritto di riunione; il diritto di determinare nuovi membri; il diritto di eleggere i leader e i dipendenti chiave, anche nelle organizzazioni collegate; il diritto di funzionare come organizzazione. Per i singoli credenti, i diritti essenziali includono l'espressione e l'esercizio della religione e la libertà dalla discriminazione religiosa. In difesa di questi diritti, dobbiamo essere uniti. Cattolici, evangelici, ebrei, musulmani, Santi degli Ultimi Giorni e altre fedi devono far parte di una coalizione di religioni che salvi, protegga e promuova la libertà religiosa nel mondo. Sapendo che la libertà può essere raggiunta sostenendo la libertà di coloro che consideriamo nostri avversari. Quando vediamo che i nostri interessi sono legati a quelli di tutti gli altri, allora inizia il vero lavoro della libertà religiosa. Da qui la necessità per i credenti di ascoltare gli altri, di entrare in empatia e di risolvere i conflitti in modo pacifico. Non compromettendo i principi religiosi fondamentali, ma cogliendo ciò che è veramente essenziale per il nostro libero esercizio della religione.
"In questo modo", secondo Oaks, "impariamo a vivere in pace con alcune leggi che non ci piacciono e con alcune persone i cui valori differiscono dai nostri. Tutto ciò che è necessario per l'unità è la convinzione condivisa che Dio ci ha comandato di amarci l'un l'altro e ci ha concesso la libertà in materia di fede": la dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà religiosa è stata citata come punto centrale del secondo vertice internazionale promosso dall'Università di Notre Dame. Vale la pena di ricordarne alcuni passaggi.
"Il contenuto di tale libertà", si legge nel documento, "è che gli esseri umani devono essere immuni da coercizione da parte di individui, gruppi sociali e qualsiasi potere umano, in modo che in materia di religione nessuno debba essere costretto ad agire contro la propria coscienza o impedito, entro i dovuti limiti, di agire in conformità con essa - in privato o in pubblico, individualmente o in associazione".
Dichiara inoltre che il diritto alla libertà religiosa si basa sulla dignità stessa della persona umana, come rivelato dalla parola di Dio e dalla ragione stessa. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società".
Un contributo decisivo alla formulazione del documento e alla definizione della libertà religiosa come immunità era stato dato da Paolo VI che, nel corso di un'udienza pubblica del 28 giugno 1965, descrivendo la libertà religiosa, aveva detto: "Vedrete che gran parte di questa dottrina capitale si può riassumere in due famose proposizioni: in materia di fede nessuno sia disturbato! Che nessuno sia costretto" (nemo cogatur, nemo impediatur).
Intervenendo alla conferenza internazionale "Religious Freedom in International Law and the Global Conflict of Values" (20 giugno 2014), Papa Francesco ha osservato: "La libertà religiosa non è solo libertà di pensiero o di culto privato. È la libertà di vivere secondo i principi etici derivanti dalla verità incontrata, sia in privato che in pubblico. È una grande sfida nel mondo globalizzato, dove il pensiero debole - che è come una malattia - abbassa anche il livello etico generale, e in nome di un falso concetto di tolleranza si finisce per perseguitare chi difende la verità dell'uomo e le sue conseguenze etiche".
Oggi, alla luce prima della pandemia e poi della guerra in Ucraina, si discute di de-globalizzazione o di nuova globalizzazione. La sfida, tuttavia, rimane la stessa: garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali, compresa la libertà religiosa in tutte le sue manifestazioni e ovunque.
La Santa Sede avverte il percorso sinodale tedesco
La Santa Sede ha avvertito il cammino sinodale tedesco che non ha il potere di costringere i vescovi o i fedeli ad assumere nuove forme di governo o dottrine morali.
In una nota pubblicata il 21 luglio, ricorda che i cambiamenti devono essere concordati a livello di Chiesa universale e che le diocesi non possono prendere decisioni dottrinali unilateralmente.
AhOra potete usufruire di uno sconto di 20% sull'abbonamento a Rapporti di Roma Premiuml'agenzia di stampa internazionale specializzata nelle attività del Papa e del Vaticano.
Suor Roberta TremarelliLe missioni ci fanno uscire dall'individualismo per vivere pienamente la nostra condizione di battezzati".
Suor Roberta Tremarelli, SSMC, Segretaria Generale dell'Infanzia Missionaria di Roma, afferma che "il mondo missionario di oggi mostra l'universalità della Chiesa, l'apertura e l'accoglienza, la circolarità della solidarietà nella preghiera e nella carità".
 Il fervore missionario della giovane Paolina Jaricot, che presto sarà beata, si è fatto sentire.
Il fervore missionario della giovane Paolina Jaricot, che presto sarà beata, si è fatto sentire. Infanzia missionaria: "Jenet, Michelle e Íscar rappresentano tutti i bambini del mondo".
Infanzia missionaria: "Jenet, Michelle e Íscar rappresentano tutti i bambini del mondo".In questa intervista a Omnes, suor Roberta Tremarelli, SSMC, segretaria generale dell'Opera della Santa Infanzia di Roma, racconta il passato e il presente di un'organizzazione la cui missione è incentrata sui bambini, un monito per tutti i battezzati.
Suor Roberta, nel vasto panorama delle opere missionarie della Chiesa ce n'è una forse poco conosciuta ma che ha radici molto interessanti che risalgono all'evangelizzazione della Cina già a metà dell'Ottocento, l'Opera della Santa Infanzia. Come è nato questo grande progetto di evangelizzazione?
- Il momento propizio per la fondazione dell'Opera della Santa Infanzia fu quello di Papa Gregorio XVI, già Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, durante il cui pontificato nacquero molte congregazioni sacerdotali e missionarie femminili ad gentes, oltre a numerose associazioni laicali, tra cui l'Opera per la Propagazione della Fede della Santa Infanzia. Pauline Jaricot.
L'Opera della Santa Infanzia nasce in Francia il 19 maggio 1843, dopo un lungo periodo di riflessione durante il quale il fondatore, Charles de Forbin-Janson, si preoccupa e si interessa della salvezza dei bambini cinesi destinati, a causa della povertà e dell'ignoranza, a morire senza essere battezzati.
Il desiderio del fondatore era di andare come missionario in Cina, ma non ne ha mai avuto l'opportunità. E così continuò ad alimentare la sua passione missionaria attraverso le testimonianze e le lettere che riceveva dai missionari francesi che erano andati in Cina.
Quali sono le notizie in arrivo?
- Grazie a loro, ha imparato a conoscere le condizioni dei bambini provenienti da famiglie povere o svantaggiate. I bambini, appena nati, venivano eliminati, soprattutto se erano femmine e se avevano qualche difetto. I missionari chiedevano aiuto per salvarli, per accoglierli nelle missioni dove venivano battezzati ed educati come cristiani. Il vescovo prese sul serio il problema e iniziò a sensibilizzare la popolazione.
Possiamo immaginare che non sia stata una cosa facile da fare....
- Fin dall'inizio, Forbin-Janson ebbe molte difficoltà a far accettare l'idea di creare una nuova Opera missionaria, perché in Francia erano in corso numerose fondazioni di Istituti missionari e quella di Forbin-Janson poteva sembrare in concorrenza.
Gli stessi membri dell'Opera per la Propagazione della Fede si opposero seriamente alla proposta del vescovo. Ma la novità dell'istituzione che va direttamente ai bambini per i bambini ha superato ogni perplessità. Poiché la Cina sembrava troppo lontana per gli adulti, il vescovo ha richiamato l'attenzione dei ragazzi sulla situazione dei bambini cinesi e ha chiesto loro la disponibilità ad aiutare la Chiesa a salvare i piccoli che muoiono senza essere battezzati con due semplici impegni: un'Ave Maria al giorno e un centesimo al mese. I bambini accettarono e, attraverso la preghiera, il sacrificio e i gesti di solidarietà, iniziarono una gara di fratellanza universale che continua ancora oggi a salvare i bambini di tutti i continenti.
Quali erano gli obiettivi di questo lavoro?
- Gli obiettivi dell'Opera furono subito chiari sia al Fondatore che ai suoi collaboratori: salvare una moltitudine di bambini dalla morte e aprire il cielo al maggior numero possibile di bambini attraverso il Battesimo; fare di questi bambini uno strumento di salvezza come insegnanti, catechisti, medici, sacerdoti, missionari. L'opera missionaria dei bambini non è stata a senso unico; alle preghiere, ai sacrifici e alla volontà dei bambini europei hanno corrisposto le preghiere, i sacrifici, la gioia e talvolta la testimonianza di martirio dei bambini cinesi.
E qual è l'elemento caratteristico?
- L'elemento caratteristico è la partecipazione attiva dei bambini e dei giovani all'opera di evangelizzazione della Chiesa. Il Fondatore assegna ai bambini il ruolo di protagonisti missionari nella storia della salvezza.
Per la prima volta, i piccoli sono stati attivi nella Chiesa come attori pastorali e sono presto entrati a far parte della corrente universale di solidarietà: si è avviata una vera e propria cooperazione spirituale e materiale tra le Chiese, portata avanti dai bambini, per la santificazione e la salvezza.
Come si diffonde nel mondo di oggi?
- Oggi l'Opera della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria è diffusa in più di 120 Paesi del mondo e il motto iniziale "bambini che aiutano i bambini" si è arricchito di "bambini che evangelizzano i bambini, bambini che pregano per i bambini, bambini che aiutano i bambini di tutto il mondo".
Fedele al carisma iniziale e al desiderio del fondatore, continua a puntare ad aiutare i bambini a sviluppare uno spirito missionario e una leadership missionaria, a incoraggiarli a condividere la loro fede e i loro mezzi materiali e a promuovere, incoraggiare e sostenere le vocazioni missionarie ad gentes. È uno strumento di crescita nella fede, anche in una prospettiva vocazionale. L'organizzazione è diversa a seconda del contesto locale. Preghiera, offerta e sacrificio sono le tre parole chiave di ogni Pontificia Opera Missionaria e anche della Santa Infanzia, a cui si aggiunge la testimonianza, essenziale per la fede cristiana.
Il 3 maggio 1922, Papa Pio XI, consapevole del grande contributo che l'Opera aveva dato alle missioni in circa ottant'anni, la fece sua, riconoscendola come Pontificia. Il 4 dicembre 1950, Papa Pio XII istituì la Giornata Mondiale del Bambino, dichiarando come data di celebrazione il giorno dell'Epifania, ma lasciando a ogni nazione la libertà di adattare la data alle esigenze locali.
Lei è il suo Segretario generale nel 2017. Come è cambiato il mondo delle missioni in generale e dell'assistenza all'infanzia in particolare negli ultimi anni, caratterizzati da non poche "emergenze"?
- Credo che oggi si cerchi sempre più di promuovere la consapevolezza e la responsabilità missionaria fin dalla più tenera età.
C'è ancora chi, parlando di missione e di missionari, pensa al prete dalla barba lunga che lascia il suo Paese e va lontano per annunciare il Vangelo e aiutare altri popoli e non torna più.
Ci sono ancora molti missionari ad gentes, come ho riferito, ma ci sono anche molte realtà missionarie impegnate nell'annuncio e nella cooperazione missionaria nel loro contesto locale, per incoraggiare i cristiani a vivere secondo la natura missionaria che scaturisce dal Battesimo.
Tra l'altro, non ci sono più Paesi che ricevono e altri che danno, non solo aiuti finanziari ma anche una presenza umana prioritaria. Il mondo missionario di oggi, se lo guardiamo bene, ci mostra l'universalità della Chiesa, l'apertura e l'accoglienza, la circolarità della solidarietà nella preghiera e nella carità. Elementi che non abbiamo ancora interiorizzato per poterli vivere in pienezza e profondità.
Inoltre, vi sono molti sacerdoti e laici fidei donum in missione, non solo dai Paesi europei, ma da tutti i continenti; diocesi che organizzano esperienze missionarie all'estero per i giovani.
Ogni proposta dovrebbe contribuire ad aprire i nostri cuori, le nostre menti e i nostri occhi, aiutandoci a uscire dal nostro recinto limitato. Speriamo che sia così.
Il 22 maggio è stata beatificata a Lione Paolina Jaricot, fondatrice dell'Opera per la Propagazione della Fede. Fedele laica che ha messo tutta la sua vita al servizio delle missioni, quali insegnamenti trasmette la nuova Beata ai laici di oggi?
- Pauline Jaricot era una donna appassionata di Gesù e delle missioni, attenta ai bisogni degli altri, alla realtà sociale del mondo che la circondava e disponibile allo Spirito Santo attraverso una preghiera fedele e perseverante. Viveva con i piedi per terra e il cuore rivolto a Dio. Molti la descrivono come una mistica in azione. Desiderava amare Dio e farlo amare da tutti gli uomini e le donne. Ha alimentato la sua passione e il suo impegno missionario nell'Eucaristia e con sacrificio.
La sua vita è un invito a tutti i laici, uomini e donne, a coltivare un rapporto con il Signore per servire la Chiesa e nella Chiesa. La sua creatività nel sostenere le missioni ci spinge a sfruttare gli strumenti che abbiamo, ma anche ad andare oltre nel proporre gli alti valori del Vangelo senza paura di essere lasciati soli. Paolina è morta povera e sola, ma nel suo cuore aveva la gioia che solo Dio può dare.
Quest'anno ricorre anche il 400° anniversario della Congregazione De Propaganda Fide, oggi Dicastero per l'Evangelizzazione. Come rendere accattivante la "passione" e l'impegno per l'evangelizzazione nel nostro mondo individualizzato e un po' "noioso"?
- Direi che la risposta è già nella domanda: la passione e l'impegno missionario aiutano a uscire dall'individualismo e dall'egoismo, a scoprire che apparteniamo a un unico mondo.
Invito quindi tutti gli appassionati di missioni a reintrodurre, con fervore, l'animazione missionaria e l'informazione missionaria, ben fatta e nel rispetto della dignità. La passione è animata da questi due elementi, sostenuti dalla testimonianza di vita di chi li porta avanti, utilizzando un linguaggio inclusivo e accogliente.
Spetta a ciascuno di noi, donne consacrate, sacerdoti, laici, uscire, come dice Papa Francesco, non tanto per farsi conoscere e per promuovere le proprie iniziative limitate, ma per annunciare la salvezza di Cristo.
Quali sono i progetti in cui siete attualmente coinvolti come Opera dell'Infanzia Missionaria?
- I progetti sostenuti dal Fondo di Solidarietà Universale (il grande salvadanaio alimentato dai bambini e dai giovani missionari di tutto il mondo) dell'Opera della Santa Infanzia sono vari e a favore di chiese particolari in Africa, Asia, Oceania e alcune in America Latina, i cosiddetti "territori di missione". L'anno scorso sono stati approvati oltre 15 milioni di dollari di sovvenzioni per bambini e ragazzi fino a 14 anni, suddivisi tra le seguenti categorie di progetti:
- Pastorale ordinaria, 16%.
- Formazione e animazione missionaria, 16%.
- Istruzione scolastica, 45%.
- Protezione della vita, 23%.
Vuole fare un appello ai nostri lettori?
-Sì, certo! Più che un appello, un invito a visitare il sito delle Pontificie Opere Missionarie, Segretariati Internazionali, www.ppoomm.va scoprire e approfondire la realtà della PMS, che ogni cristiano dovrebbe conoscere e promuovere, per alimentare la propria spiritualità missionaria.
Inoltre, per coloro che lavorano con i bambini e i giovani, per condividere il carisma dell'Opera della Santa Infanzia e le varie proposte, a livello nazionale e internazionale, per coinvolgerli in questa rete mondiale di preghiera e carità al servizio del Papa.
Collegamenti di tipo "Nurturing
Oggi più che mai è importante prendersi cura dei nostri legami personali, soprattutto quelli familiari e di amicizia. Coltivarli come la pianta che più ci sta a cuore. L'estate ci offre un momento privilegiato per farlo.
Oggi molti pensano che si è più liberi - e più felici - nella misura in cui si rimane liberi da legami. Che i legami con gli altri sono legami che limitano e, alla lunga, imprigionano. Non è un caso che pensiamo in questo modo.
Il liberalismo imperante in Occidente ci ha introdotto a stili di vita sempre più individualisti e autoreferenziali.
Le relazioni personali, da questo punto di vista, diventano uno strumento per raggiungere i nostri fini o un peso che ci impedisce di fare ciò che vogliamo. Questo genera quella che Bauman ha definito la "condizione liquida" delle nuove generazioni: individui "sciolti", senza radici nel passato, con un'identità volatile e poco proiettata verso il futuro.
Questa povertà di legami porta alla solitudine. Per questo motivo, i "ministeri della solitudine" creati di recente non sono frutto dell'idea di governi originali, ma un tentativo di rispondere a un problema crescente.
Le relazioni servono a unire, non a legare. Le relazioni umane sono di per sé una ricchezza, perché ci permettono di uscire da noi stessi e di ricevere dagli altri. Se questo avviene in un contesto di amore incondizionato, come la famiglia, il bene è incalcolabile. Ecco perché il tesoro più grande per ogni persona dovrebbe essere il "proprio".
La neuropsichiatra italiana Mariolina Ceriotti, che ho citato in precedenza, afferma che il problema non sono le relazioni, ma la mancanza di un giusto equilibrio tra di esse. Perché una relazione funzioni, è molto importante avere la giusta posizione in famiglia, rispettare i limiti dell'altro e mantenere la giusta distanza nel rapporto con le altre persone. Spesso molte crisi personali e familiari hanno a che fare con il fallimento di uno di questi aspetti.
Oggi più che mai è importante prendersi cura dei nostri legami personali, soprattutto quelli familiari e di amicizia. Coltivarli come la pianta che più ci sta a cuore. L'estate ci offre un momento privilegiato per farlo.
La condivisione del tempo mette alla prova il necessario equilibrio dei legami: può essere un momento di separazione o un momento di maggiore legame.
La mia proposta non può essere diversa: dovrebbe essere un momento per rendere prioritarie le relazioni familiari; un momento per approfittare dello spazio condiviso per conoscersi meglio; per far sentire speciali coloro che ci circondano; per condividere compiti e responsabilità; per incoraggiare l'intrattenimento creativo e limitare la mera passività.
In breve, godere della vita familiare per quello che è: un vero e proprio dono per tutti.
La Santa Sede lancia un chiaro monito al cammino sinodale tedesco
In un comunicato, ricorda che il Cammino sinodale non ha la prerogativa "di costringere i vescovi e i fedeli ad adottare nuove forme di governo e nuovi orientamenti dottrinali e morali".
 Germania, verso un'altra Chiesa?
Germania, verso un'altra Chiesa? "Siamo di fronte a una nuova etica della sessualità nel cammino sinodale tedesco?".
"Siamo di fronte a una nuova etica della sessualità nel cammino sinodale tedesco?". Il percorso sinodale della Germania rimproverato di "abusare degli abusi".
Il percorso sinodale della Germania rimproverato di "abusare degli abusi".La Santa Sede ha reso pubblico un breve dichiarazionein italiano e in tedesco, con chiari avvertimenti al cosiddetto Cammino sinodale tedesco, al quale ricorda di non avere "prerogative per costringere vescovi e fedeli ad adottare nuove forme di governo e nuovi orientamenti dottrinali e morali". Il comunicato sottolinea che appare necessario chiarire questi punti per "salvaguardare la libertà del Popolo di Dio e l'esercizio del ministero episcopale". L'intenzione del Cammino Sinodale è quella di prendere decisioni sulla direzione della Chiesa, ministeri o insegnamento moraleLe proposte del Cammino sinodale, al di fuori di Roma e della Chiesa universale e del processo sinodale mondiale, non hanno alcun fondamento nella realtà. Al contrario, le proposte del Cammino Sinodale devono essere indirizzate al processo sinodale universale.
Il mittente della lettera è "la Santa Sede" e non uno specifico dicastero vaticano; essa proviene quindi dalla suprema autorità della Chiesa, con l'avallo del Papa, di cui viene citata una frase chiave della "Lettera al popolo di Dio in pellegrinaggio in Germania", che Papa Francesco ha inviato nel 2019. La dichiarazione è stata rilasciata in vista della quarta Assemblea del Cammino sinodale che si terrà a Francoforte dall'8 al 10 settembre. Il testo recita come segue:
"Per salvaguardare la libertà del Popolo di Dio e l'esercizio del ministero episcopale, sembra necessario chiarire quanto segue: il "Cammino sinodale" in Germania non ha il potere di costringere i vescovi e i fedeli ad adottare nuove forme di governo e nuovi orientamenti dottrinali e morali.
La lettera del Papa al cammino sinodale
Non sarebbe ammissibile introdurre nuove strutture o dottrine ufficiali nelle diocesi prima che sia stato raggiunto un accordo a livello di Chiesa universale, poiché ciò costituirebbe una violazione della comunione ecclesiale e una minaccia all'unità della Chiesa. A questo proposito, il Santo Padre ha ricordato nel suo lettera al popolo di Dio in pellegrinaggio in GermaniaLa Chiesa universale vive nelle e dalle Chiese particolari, così come le Chiese particolari vivono e fioriscono nella e dalla Chiesa universale; se fossero separate dalla Chiesa universale, si indebolirebbero, perirebbero e morirebbero. Da qui la necessità di mantenere sempre viva ed efficace la comunione con l'intero corpo della Chiesa".
È quindi auspicabile che le proposte del cammino delle Chiese particolari in Germania sfocino nel processo sinodale che sta attraversando la Chiesa universale, per contribuire al reciproco arricchimento e testimoniare l'unità con cui il Corpo della Chiesa manifesta la sua fedeltà a Cristo nostro Signore".
Questa dichiarazione della Santa Sede arriva dopo che vescovi di tutto il mondo hanno scritto alla Conferenza episcopale tedesca esprimendo preoccupazione per la deriva del Cammino sinodale: sia il presidente della Conferenza episcopale polacca che i vescovi dei Paesi nordici, prima, e - ad aprile - una lettera di oltre 100 cardinali e vescovi di tutto il mondo, soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Africa, hanno messo in guardia sul fatto che i cambiamenti radicali nella dottrina della Chiesa auspicati dal processo potrebbero portare allo scisma. A giugno, il cardinale Walter Kasper - considerato vicino a Papa Francesco - ha avvertito che il processo tedesco era davvero a rischio se non avesse ascoltato queste obiezioni.
Un nuovo avvertimento
La dichiarazione della Santa Sede arriva anche una settimana dopo che la presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) - e del Cammino sinodale - Irme Stetter-Karp, ha scritto un articolo di opinione su un importante settimanale in cui afferma che "l'aborto deve essere reso possibile in tutto il Paese", e che occorre "riflettere su come garantire l'offerta in tutta la Germania, anche nelle regioni rurali, il che includerebbe anche la formazione degli studenti di medicina".
L'addetto stampa della Conferenza episcopale tedesca, Matthias Kopp, ha immediatamente respinto questa richiesta: "La posizione della presidente della ZdK Irme Stetter-Karp sulla necessità di offrire l'aborto a livello nazionale contraddice la posizione della Conferenza episcopale tedesca. Invece di rendere possibile l'aborto a livello nazionale, abbiamo bisogno di un'offerta di consulenza qualificata per le donne". Il giorno successivo, Stetter-Karp ha respinto a sua volta la dichiarazione di Matthias Kopp: "Se, dopo la consulenza, la donna decide di interrompere la gravidanza", ciò dovrebbe essere possibile: "il diritto all'autodeterminazione non serve a nulla se ci sono ostacoli insormontabili". Queste dichiarazioni hanno portato a una raccolta di firme per chiedere le dimissioni di Stetter-Karp da presidente della ZdK.
Ancora più recentemente, il 18 luglio, il segretario del Cammino Sinodale Marc Frings ha dichiarato che il Cammino Sinodale vuole cambiare la dottrina della Chiesa sull'omosessualità: il Cammino Sinodale, con i suoi testi, è "una dichiarazione consapevole" contro il Catechismo della Chiesa Cattolica, "che dalla metà degli anni '70 tratta l'omosessualità in modo critico, sprezzante e peccaminoso". Il documento del Cammino Sinodale a cui fa riferimento contiene commenti sul "cambiamento di opinione" - in relazione alla dottrina cattolica - sul matrimonio e su altri aspetti della sessualità.
La formula di Radbruch in un mondo bipolare
La giustizia è patrimonio di un particolare gruppo ideologico o è piuttosto un valore che tutti gli esseri umani e tutte le istituzioni politiche e i gruppi mediatici dovrebbero aspirare a scoprire e praticare?
"La formula, che prende il nome dal giurista tedesco Gustav Radbruch, afferma che alle leggi estremamente ingiuste può essere negata la validità, perché l'estrema ingiustizia non è e non può essere legge. Anni dopo, Robert Alexy studiò a fondo la suddetta formula, dimostrandone l'utilità nei processi legali. Rileviamo l'attualità di questo grande contributo al pensiero giuridico, prestando particolare attenzione alla sua utilità in un mondo in cui i media e l'opinione pubblica in generale concepiscono alcune delle questioni sociali controverse di oggi in modo bipolare e secondo le rispettive ideologie.
A più di trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino e mentre assistiamo alla guerra di invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sembra opportuno ricordare la teoria della negazione del diritto gravemente ingiusto elaborata dal giurista tedesco Gustav Radbruch dopo l'infelice esperienza degli anni del nazionalsocialismo, della seconda guerra mondiale e della successiva divisione dell'Europa in due blocchi con l'inizio della guerra fredda.
Radbruch è stato professore di filosofia del diritto e di diritto penale presso le università di Kiel e Heidelberg, ministro della Giustizia nella sfortunata Repubblica di Weimar (1921-1923) e uno dei principali autori della sua carta costituzionale. Inizialmente, come molti altri, apparteneva al partito nazista, ma sotto il nazismo fu epurato e privato della cattedra di filosofia giuridica nel 1933 - l'anno in cui Hitler fu nominato Cancelliere della Germania - e gli fu vietato di ricoprire qualsiasi incarico pubblico, politico o di insegnamento. Con il crollo di quel regime, nel 1945 riottenne la cattedra e fu decano a Heidelberg fino alla morte.
La sofferenza per gli orrori della Seconda guerra mondiale e l'indifendibilità causata dal relativismo giuridico dei decenni precedenti cambiarono il suo modo di pensare e, in contrasto con la visione positivista del diritto del suo connazionale Hans Kelsen, arrivò a concepire il mondo in due sfere, quella naturale e quella culturale. Il fenomeno giuridico rientrerebbe nel secondo, caratterizzato dalla ricerca della Giustizia, valore ad esso connaturato. Sulla base di questa costruzione, ha sviluppato il suo concetto di Legge come realtà culturale riferita ai valori.
Già da naturalista moderato, nella sua famosa opera "Arbitrarietà giuridica e diritto sovralegale", introdusse il suo grande contributo al pensiero giuridico, la formula che porta il suo nome, secondo la quale alle leggi estremamente ingiuste può essere negata la validità, perché l'estrema ingiustizia non è diritto. Significativamente, nell'anno del suo ritorno in Germania dall'esilio si svolsero anche i famosi processi di Norimberga, in cui i leader nazisti furono processati e condannati per i crimini genocidi commessi in Germania e nei Paesi occupati durante la guerra e in cui furono rivelate le vere atrocità. Queste prove avrebbero senza dubbio influenzato il suo ragionamento.
In Arbitrariedad Legal y Derecho Supralegal si stabilisce l'obbligo generale di applicare sempre il diritto positivo, a meno che non sia estremamente ingiusto al punto da denaturalizzare il diritto stesso. Resta inteso che non si tratta di una formula applicabile a qualsiasi tipo di ingiustizia nel diritto, poiché la sua generalizzazione potrebbe portare al caos giuridico.
Ci chiediamo se questi spunti provenienti dall'ambito giuridico non possano essere interessanti anche oggi, in un momento in cui i media e l'opinione pubblica in generale tendono spesso ad affrontare i grandi dibattiti etici in modo bipolare, stabilendo un quadro di "buoni e cattivi" che non sempre rispetta gli elementari principi di giustizia quando la verità mette in pericolo lo status quo e la solidità delle proprie convinzioni.
Secondo il Democracy Index 2021, solo Canada, Costa Rica, Uruguay, Islanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud e Taiwan sono democrazie complete. In questi Paesi sono in vigore leggi che consentono l'uccisione dei nascituri in avanzato stato di gestazione, l'esecuzione dei condannati a morte, l'eliminazione dei malati terminali o mentali attraverso leggi sull'eutanasia, l'imposizione attraverso leggi educative di alcuni approcci ideologicamente controversi come i postulati dell'ideologia gender, violando gravemente la libertà di insegnamento e di pensiero, togliere ad alcune persone il diritto di essere adottate da un padre e da una madre attraverso le leggi sulle adozioni, vietare i simboli religiosi ai funzionari pubblici in violazione della libertà religiosa, non dare asilo alle persone che fuggono da regimi autoritari ed estremamente ingiusti, lasciandole indifese e alla mercé dei satrapi grazie a certe leggi sugli stranieri, ecc.
Le leggi sopra citate possono essere considerate gravemente ingiuste, al punto da prendere in considerazione l'applicazione della formula di Radbruch, che potrebbe dichiararle illegali? Questa è l'opinione di molti cittadini, governi e comunicatori in vari Paesi.
Si dirà che si tratta di questioni molto complesse in cui si scontrano le diverse concezioni morali dei cittadini, e questo è indubbiamente vero. Ma è anche vero che il fatto che queste legislazioni siano fiorite negli ultimi decenni in varie nazioni che godono del prestigio di democrazie piene - sostenute da una maggioranza sociale o almeno legislativa - non conferisce loro automaticamente lo status di giuste.
La pretesa di Alexy sulla correttezza della legge non è altro che una pretesa di giustizia. Un sistema giuridico che aspira a essere corretto, cioè a svolgere bene la sua funzione, deve aspirare a essere giusto o almeno - se seguiamo la dottrina di Radbruch - a non essere estremamente ingiusto. E i principi del diritto che garantiscono la giustizia sono, come ci ha insegnato il giurista romano Ulpiano molti secoli fa: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (vivere con onore, dare a ciascuno il suo e non danneggiare gli altri).
Per fare due esempi di attualità, un sondaggio nazionale condotto dall'Università di Harvard e dalla società di sondaggi Harris conferma che 75% degli americani sono favorevoli al rovesciamento della Roe v. Wade da parte della Corte Suprema il 24 giugno 2022, affermando che non esiste un diritto costituzionale all'aborto. Potremmo anche parlare, su un altro spettro ideologico, dell'ingiustizia del veto all'immigrazione imposto dal presidente Donald Trump ai cittadini di cinque Paesi musulmani a cui è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti e successivamente confermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. O il mantenimento della pena di morte negli Stati Uniti.
Un cittadino americano sopravvissuto a un tentativo di aborto potrebbe chiedere un risarcimento in base alla clausola di Radbruch per le conseguenze di un tentato omicidio, o un cittadino dell'Iraq o della Somalia a cui è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti, causando così gravi lesioni personali, o la famiglia di una persona condannata a morte per il danno irreparabile causato dalla sua esecuzione?
La giustizia è patrimonio di un particolare gruppo ideologico o è piuttosto un valore che tutti gli esseri umani e tutte le istituzioni politiche e i gruppi mediatici dovrebbero aspirare a scoprire e a praticare? I diritti umani sono come "streghe e unicorni", come sostiene il filosofo scozzese Alasdair MacIntyre, o qualcosa di inventato dai partiti politici in base alle aspirazioni sociali di ogni momento storico, o piuttosto qualcosa di oggettivo che può essere scoperto se si studiano casi concreti con onestà e obiettività?
Siria: Paradiso perduto (I)
La Siria è una delle nazioni più antiche del mondo, con una storia antica che è intrinsecamente legata alla storia della nostra fede.
La storia della nazione siriana ha molto a che fare con la storia della fede cristiana. In quella che oggi è la Siria, i fedeli di Cristo cominciarono ad essere conosciuti come i I cristianiLì ci sono ancora villaggi in cui si parla l'antica lingua di Gesù, l'aramaico, e fu in questa terra che avvenne la conversione di Saulo, San Paolo, che avrebbe diffuso il messaggio di Cristo nel mondo conosciuto.
L'anima del mondo

Spesso pensiamo all'Oriente, e per estensione a tutte le aree del mondo che sembrano "esotiche" o lontane per la nostra mentalità occidentale, come aliene. Povera gente", si sente dire a proposito delle guerre, delle lotte fratricide e delle persecuzioni che affliggono questi Paesi. Eppure, mai come oggi la Siria è un luogo che dovremmo considerare "casa", almeno come cristiani.
Perché? Innanzitutto perché qui, nell'antica Antiochia siriana, che oggi si trova anche in Turchia (sebbene geograficamente e culturalmente sia un territorio siriano), i fedeli di Cristo erano chiamati I cristianiperché Pietro fu il primo vescovo di Antiochia, prima di arrivare a Roma; perché, ancora, Paolo svoltò sulla via di Damasco e da lì partì per la sua missione evangelizzatrice (a Damasco si può ancora visitare la casa di Anania); perché in una città della Siria, Edessa, la Sindone di Torino (nota in questa zona come grembiule) rimase per più di un millennio, fino al 1204, quando la città fu saccheggiata durante la Quarta Croce; perché in una città siriana, Edessa, la Sindone (conosciuta in quest'area come grembiule) è rimasta per più di un millennio, fino al 1204, quando la città fu saccheggiata durante la Quarta Crociata; perché, infine, esistono ancora villaggi in cui si parla l'antica lingua di Gesù, l'aramaico, e alcune delle chiese più antiche del mondo.
Ci sono molte altre ragioni, ma non abbiamo il tempo di elencarle. Tuttavia, basti ricordare che furono proprio i cristiani di Siria, un tempo maggioranza nel Paese (e anche, per diversi secoli, dopo la conquista islamica), a contribuire a conservare i manoscritti siriaci (traduzioni di testi latini e greci) e a trasmetterli all'Occidente attraverso le loro traduzioni arabe.
Nel Lettera a Diognetoun breve trattato apologetico composto probabilmente alla fine del II secolo, parla dei cristiani e del loro ruolo nel mondo a partire da un luogo assegnato loro da Dio, un luogo da cui non possono uscire. Infatti, i cristiani "rappresentano nel mondo ciò che l'anima è nel corpo". L'anima si trova in tutte le membra del corpo; e anche i cristiani sono sparsi per le città del mondo. L'anima, dunque, abita nel corpo, ma non ne esce; e anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo".
L'anima dà vita al corpo, così i cristiani hanno dato un'anima a questo mondo impazzito, e in questo caso non solo un'anima spirituale, ma anche culturale e civile.
Anche in Medio Oriente, un'area oggi conosciuta come il cuore dell'Islam piuttosto che del Cristianesimo, coloro che hanno contribuito a creare la civiltà islamica erano, paradossalmente, cristiani.
I cristiani, infatti, sono stati i letterati, i filosofi e gli scienziati che hanno codificato e dato una grammatica e un alfabeto alla lingua araba (insieme agli ebrei) e le basi alla cultura arabo-islamica (l'Islam era considerato da San Giovanni Damasceno nient'altro che un'eresia cristiana, fatto confermato da un gran numero di teologi e filosofi successivi, tra cui l'inglese Hilaire Belloc, molti secoli dopo, nel suo libro Le grandi eresie).
Una storia lunga e travagliata
La Siria ospita alcune delle più antiche città abitate del mondo (una di queste è Damasco, chiamata dai poeti arabi jannat ad-dunyah, "paradiso del mondo" e considerata, insieme a Gerico in Palestina, la più antica città ancora abitata del nostro pianeta) e civiltà.
Anche l'antenato della maggior parte degli alfabeti moderni ha avuto origine in Siria. Infatti, a Ugarit, città sulla costa siriana nei pressi di Lattakia, si sviluppò l'alfabeto ugaritico, un alfabeto in cui si utilizzavano ancora i caratteri cuneiformi di origine assiro-babilonese, ma che non avevano più un valore pittografico, come questo, bensì sillabico. Da questo sistema nacque l'alfabeto fenicio, poi rielaborato prima dai greci e poi dai romani.
Sede di diversi popoli semiti, tra cui gli Eblaiti, gli Ugariti, gli Amorrei e gli Aramei, con i rispettivi regni e città-stato, la Siria divenne una provincia romana nel 64 a.C..
Sotto i Romani, la sua capitale, Antiochia, divenne una delle città più grandi e fiorenti dell'Impero (raggiungendo una popolazione di circa 600.000 abitanti) e il centro del cristianesimo siriano, i cui principali esponenti furono San Pietro, primo vescovo di Antiochia, e San Tommaso. Egli, insieme a discepoli come Taddeo di Edessa e Mari (a cui è attribuita la paternità di una delle più antiche anafore eucaristiche del cristianesimo, l'Anafora di Addai e Mari) e a quelli successivi, è stato l'artefice dell'evangelizzazione di gran parte del Vicino e Medio Oriente (Siria, Libano, Iraq, Iran, persino India, dove sopravvivono le chiese siriache cattoliche di Syro-Malabar e Syro-Malankar, ma i missionari siriaci arrivarono fino alla Cina, attraverso la Via della Seta).

Nonostante la conquista islamica nel VII secolo (dal 651 Damasco divenne sede del califfato omayyade e la maestosa cattedrale, in cui sono ancora conservate le reliquie di San Giovanni Battista, fu parzialmente demolita e trasformata in moschea), avvenuta con il parziale consenso delle popolazioni cristiane, queste riuscirono a prosperare per secoli, nonostante le ovvie difficoltà.
Questo perché i cristiani preferivano sottomettersi a un elemento culturalmente più vicino al loro (gli arabi semiti) piuttosto che alla longa manus dell'imperatore bizantino, uno straniero che esigeva tributi sempre più esorbitanti. Il gizyah e il kharaj Le tasse islamiche (imposte di capitazione riservate a cristiani ed ebrei, considerati cittadini di seconda classe all'interno dello Stato musulmano e quindi soggetti a un regime speciale in termini di status personale e di diritti individuali e collettivi) erano considerate anche dai cristiani meno onerose di quelle bizantine.
Così, anche dopo le Crociate, le invasioni mongole e la definitiva sottomissione all'Impero Ottomano nel 1517, la Siria ha mantenuto una consistente minoranza cristiana (principalmente greco-ortodossa, ma anche siriaco-ortodossa, siriaco-cattolica, maronita, armena, ecc.)
Il dominio ottomano terminò alla fine della Prima Guerra Mondiale (1920), anche se il Paese non fu completamente indipendente fino al 1946, con la fine del Mandato francese durato 26 anni. Seguirono decenni di instabilità, con governi alterni e un maldestro tentativo di unirsi all'Egitto, uno Stato non contiguo ma un altro polo del nazionalismo arabo, per formare la Repubblica Araba Unita (1961).
Dal 1963, a seguito di un nuovo colpo di Stato, è al potere il partito Ba'ath, il cui principale esponente e dal 1970 presidente (e poco dopo dittatore de facto) è stato prima Hafiz al-Asad e poi, dopo la sua morte (2000), il figlio Bashar, attuale capo di Stato della Siria, che rimane al potere nonostante gli undici anni di guerra civile che hanno devastato il Paese.
La primavera araba e la guerra civile
Quella che poi è diventata la guerra civile siriana è iniziata con le rivolte scoppiate in diverse città siriane (soprattutto a Homs, Aleppo e Damasco) sulla scia delle cosiddette "primavere arabe", una serie di proteste popolari, soprattutto in Tunisia, volte a chiedere riforme economiche e sociali e a spingere la lotta alla corruzione, endemica nei Paesi arabi, soprattutto in quelli governati per decenni da partiti e regimi nazionalisti alimentati sia dall'Occidente che dalla Russia (la Siria è uno di questi ultimi).
In Siria, la situazione era particolare in quanto dal 2000, anno della sua ascesa al potere, il presidente Bashar al-Assad aveva intrapreso una serie di riforme volte a ridurre la presenza dello Stato nell'economia (fino ad allora era stato seguito un modello al tempo stesso nazionalista e socialista, nello stile del partito Ba'ath). Le riforme strutturali avviate da Assad, anche in ambito sociale, avevano aiutato la popolazione cristiana del Paese, circa 10% prima dello scoppio delle rivolte e della conseguente guerra, a vivere un periodo di notevole prosperità e libertà.
Tuttavia, i cristiani hanno inizialmente partecipato alle manifestazioni anti-corruzione del 2011. Tuttavia, si sono ritirati poco dopo, quando è diventato sempre più chiaro che erano guidati da gruppi e movimenti islamici radicali salafiti (tra cui i Fratelli Musulmani e Al Qaeda), spesso incoraggiati e armati dagli Stati Uniti e dai Paesi arabi sunniti del Golfo come il Qatar. Questi ultimi, caratterizzati da una visione salafita dell'Islam, si oppongono al regime di Assad perché il presidente siriano è un alawita (gli alawiti sono una setta di origine islamica sciita, quindi vicina all'Iran, e una minoranza nel Paese, dove il 70% della popolazione è sunnita) e, per i sunniti più estremisti, gli sciiti e le loro sette sono considerati peggio di cristiani, ebrei e pagani.
Nel momento in cui il radicalismo islamico ha rappresentato circa 75% del movimento di rivolta anti-Assad ed è diventato chiaro sia alle Nazioni Unite che all'Occidente che l'obiettivo dei ribelli era quello di formare uno Stato islamico sunnita in cui sarebbe stato in vigore il dominio sunnita, i ribelli sarebbero stati in grado di stabilire uno Stato islamico in cui avrebbero potuto esercitare il loro diritto all'autodeterminazione. sharia (legge islamica), poi dimostrata con la nascita del Califfato fondato dall'ISIS nel 2014, i primi quartieri a subire gli assalti armati dei ribelli sono stati proprio quelli cristiani, assediati e poi anche bombardati dal regime nel tentativo di riprendere il controllo.
Il conflitto, che si è poi esteso a macchia d'olio in tutto il Paese coinvolgendo Russia, Iran ed Hezbollah a sostegno di Assad e, a sostegno dei ribelli, i Paesi del Golfo Persico, gli Stati Uniti e la Turchia, è durato più di dieci anni ed è costato circa 600.000 morti, oltre 12 milioni di sfollati, di cui 6 milioni all'estero (portando la popolazione totale da circa 18 milioni a circa 18 milioni) e danni economici per 400 miliardi di dollari.È costato circa 600.000 morti, oltre 12 milioni di sfollati, di cui 6 milioni all'estero (portando la popolazione totale da 24 milioni a circa 18 milioni) e un tributo economico di 400 miliardi di dollari, oltre a una ferita mortale, forse incurabile, alla convivenza tra le varie componenti etno-religiose della Siria.

Scrittore, storico ed esperto di storia, politica e cultura del Medio Oriente.
Matera, la città visitata dal Papa
Veduta di Matera, Italia. Papa Francesco visiterà l'Italia meridionale il 25 settembre per celebrare la Messa di chiusura del Congresso Eucaristico Nazionale Italiano.
Messaggio di Papa Francesco per la 2ª Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
La giornata è stata istituita nel 2021 e viene celebrata ogni anno in tutta la Chiesa la quarta domenica di luglio, intorno alla festa di San Gioacchino e Sant'Anna, i "nonni" di Gesù. Quest'anno si svolge il 24 luglio.
Il Papa ha indirizzato un messaggio per questa occasione in cui invita i nonni e gli anziani a continuare a portare frutto e propone loro di vivere in modo particolare la dimensione della preghiera. Ha inoltre incoraggiato tutti ad andare a trovare gli anziani più soli, nelle loro case o nei residence in cui vivono.
Nella vecchiaia continueranno a dare frutti". (Il sale 92,15)
Cara sorella, caro fratello:
Il versetto del Salmo 92 "nella vecchiaia continueranno a portare frutto" (v. 15) è una buona notizia, un vero e proprio "vangelo", che possiamo annunciare al mondo in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Questo è in contrasto con ciò che il mondo pensa di questa età della vita; e anche con l'atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani che vanno avanti con poche speranze e non si aspettano più nulla dal futuro.
La vecchiaia spaventa molte persone. La considerano una sorta di malattia con cui è meglio non entrare in contatto. Gli anziani non ci interessano, pensano, ed è meglio che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra di loro, in strutture dove sono assistiti e dove noi siamo risparmiati dal doverci occupare delle loro preoccupazioni. È la "cultura dell'usa e getta", quella mentalità che, mentre ci fa sentire diversi dai più deboli e ignari delle loro fragilità, ci autorizza a immaginare percorsi separati tra "noi" e "loro". Ma, in realtà, la lunga vita - come insegna la Scrittura - è una benedizione e gli anziani non sono degli emarginati da cui allontanarsi, ma segni viventi della bontà di Dio che concede la vita in abbondanza. Beata la casa che si prende cura di una persona anziana! Beata la famiglia che onora i nonni!
In effetti, la vecchiaia non è una stagione facile da capire, anche per chi la sta già vivendo. Anche se arriva dopo un lungo viaggio, nessuno ci ha preparato ad esso e sembra quasi che ci colga di sorpresa. Le società più sviluppate investono molto in questa età della vita, ma non ci aiutano a interpretarla; offrono piani di assistenza, ma non piani di esistenza. . Per questo è difficile guardare al futuro e intravedere un orizzonte verso cui volgersi. Da un lato, siamo tentati di esorcizzare la vecchiaia nascondendo le rughe e fingendo di essere per sempre giovani; dall'altro, sembra che non resti che vivere senza speranza, rassegnati a non avere più "frutti da dare".
La fine del lavoro e l'indipendenza dei figli possono ridurre i motivi per cui abbiamo speso tante energie. La consapevolezza che le nostre forze stanno diminuendo o l'insorgere di una malattia possono mettere in crisi le nostre certezze. Il mondo - con i suoi tempi accelerati, di fronte ai quali facciamo fatica a stare al passo - sembra non lasciarci alternative e ci porta a interiorizzare l'idea dello scarto. È questo che porta il salmista a esclamare: "Non respingermi nella mia vecchiaia, non abbandonarmi quando le forze mi vengono meno" (71,9).
Ma lo stesso salmo - che scopre la presenza del Signore nelle diverse stagioni della vita - ci invita a continuare ad aspettare. Quando invecchieremo e ingrasseremo, lui continuerà a darci la vita e non permetterà che il male ci sconfigga. Confidando in Lui, troveremo la forza di lodarlo sempre di più (cfr. vv. 14-20) e scopriremo che invecchiare non è solo il naturale deterioramento del corpo o l'ineluttabile passare del tempo, ma il dono di una lunga vita. Invecchiare non è una condanna, è una benedizione!
Per questo motivo, dobbiamo vigilare su noi stessi e imparare a condurre una vecchiaia attiva anche dal punto di vista spirituale, coltivando la nostra vita interiore attraverso la lettura assidua della Parola di Dio, la preghiera quotidiana, la pratica dei sacramenti e la partecipazione alla liturgia. E, insieme al rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, soprattutto con la famiglia, i figli e i nipoti, ai quali possiamo offrire il nostro affetto e le nostre cure; ma anche con i poveri e gli afflitti, che possiamo avvicinare con l'aiuto concreto e la preghiera. Tutto questo ci aiuterà a non sentirci semplici spettatori nel teatro del mondo, a non limitarci a "guardare dal balcone", a guardare dalla finestra. Affinando i nostri sensi per riconoscere la presenza del Signore. saremo come "ulivi verdeggianti nella casa di Dio" (cfr. Il sale 52,10), e possiamo essere una benedizione per chi ci vive accanto.
La vecchiaia non è un tempo inutile in cui ci si mette da parte, lasciando i remi in barca, ma è una stagione per continuare a portare frutto. Una nuova missione ci attende e ci invita a guardare al futuro. "La particolare sensibilità di noi anziani, della vecchiaia per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono più umani, dovrebbe tornare a essere una vocazione per molti. E sarà una scelta d'amore degli anziani verso le nuove generazioni". . È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza Una rivoluzione spirituale e pacifica in cui vi invito, cari nonni e anziani, a svolgere un ruolo di primo piano.
Il mondo sta vivendo un momento di grave prova, segnato prima dalla tempesta inaspettata e furiosa della pandemia, poi da una guerra che colpisce la pace e lo sviluppo su scala globale. Non è un caso che la guerra sia tornata in Europa in un momento in cui la generazione che l'ha vissuta nel secolo scorso sta scomparendo. E queste grandi crisi possono renderci insensibili al fatto che ci sono altre "epidemie" e altre forme diffuse di violenza che minacciano la famiglia umana e la nostra casa comune.
Di fronte a tutto questo, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo, di una conversione che smilitarizzi i cuori, permettendo a tutti di riconoscersi come fratelli e sorelle. E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande responsabilità: insegnare alle donne e agli uomini del nostro tempo a vedere gli altri con la stessa comprensione e lo stesso sguardo tenero che rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la nostra umanità prendendoci cura degli altri e oggi possiamo essere maestri di uno stile di vita pacifico e attento ai più deboli. Il nostro atteggiamento può forse essere scambiato per debolezza o sottomissione, ma è il mite, non l'aggressivo o il prevaricatore, che erediterà la terra (cfr. Mt 5,5).
Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è quello di proteggere il mondo. "Siamo tutti passati attraverso le ginocchia dei nonni, che ci hanno portato in braccio". Ma oggi è il momento di tenere in ginocchio - con l'aiuto concreto o almeno con la preghiera - insieme ai nostri, tutti quei nipoti impauriti che non abbiamo ancora conosciuto e che magari fuggono dalla guerra o soffrono a causa di essa. Portiamo nel cuore - come San Giuseppe, padre tenero e premuroso - i piccoli dell'Ucraina, dell'Afghanistan, del Sud Sudan.
Molti di noi hanno maturato una coscienza saggia e umile, di cui il mondo ha tanto bisogno. Non ci si salva da soli, la felicità è un pane mangiato insieme. Testimoniamolo a coloro che si illudono di trovare la realizzazione personale e il successo nel confronto. Tutti, anche i più deboli, possono farlo. Anche lasciarsi accudire - spesso da persone di altri Paesi - è un modo per dire che la convivenza non è solo possibile, ma necessaria.
Care nonne e cari nonni, care vecchiette e cari vecchietti, in questo nostro mondo siamo chiamati ad essere gli artefici della rivoluzione della tenerezza. Lo facciamo imparando a usare sempre di più e meglio lo strumento più prezioso che abbiamo, e più adatto alla nostra età: la preghiera. "Diventiamo anche noi un po' poeti della preghiera: coltiviamo il gusto di trovare le nostre parole, rifacciamo nostre quelle che la Parola di Dio ci insegna". . La nostra invocazione fiduciosa può fare molto, può accompagnare il grido di dolore di chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori. Possiamo essere "il "coro" permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita".
Ecco perché la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è un'occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole festeggiare con coloro ai quali il Signore - come dice la Bibbia - ha concesso "un'età avanzata". Festeggiamo insieme! Vi invito a proclamare questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità, ad andare a trovare gli anziani più soli, nelle loro case o nelle residenze in cui vivono. Cerchiamo di fare in modo che nessuno viva questo giorno da solo. Avere qualcuno da aspettare può cambiare il senso delle giornate di chi non si aspetta più nulla di buono in futuro; e da un primo incontro può nascere una nuova amicizia. Visitare gli anziani soli è un'opera di misericordia del nostro tempo.
Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi gli architetti della rivoluzione della tenerezzaInsieme, per liberare il mondo dall'ombra della solitudine e dal demone della guerra.
Che la mia Benedizione, con la certezza della mia amorevole vicinanza, raggiunga tutti voi e i vostri cari. E voi, per favore, non dimenticate di pregare per me.
L
La Via Crucis di Gerusalemme: dove riecheggiano ancora i passi di Cristo
La Via Crucis è una delle devozioni più popolari tra i cristiani. Attraverso quattordici stazioni, i fedeli contemplano e meditano la Passione di Cristo, accompagnando Gesù nel suo cammino verso il luogo della crocifissione.
Testo originale dell'articolo in spagnolo qui
La devozione della Via Crucis ha origine dai racconti evangelici della passione e morte di Gesù. I vari evangelisti hanno raccolto la storia della vita del Signore, ma non nel modo in cui una biografia o uno studio sono attualmente concepiti.
I racconti della Passione non contengono tutti i dettagli del viaggio di Gesù verso il Golgota. Delle quattordici stazioni che compongono oggi la Via Crucis, nove sono direttamente ancorate ai racconti del Vangelo. Le stazioni delle tre cadute di Gesù e i suoi incontri con la Beata Vergine e con la Veronica sono il frutto della pia tradizione del popolo cristiano.
Il Via Dolorosa di Gerusalemme
Il Vangelo di Giovanni indica che Cristo fu portato dalla casa di Caifa al Pretorio. Lì, dopo l'impressionante colloquio con Pilato, il pretore "fece uscire Gesù e lo fece sedere sul seggio del giudizio in un luogo chiamato marciapiede, in ebraico Gabbatha". Era il giorno della preparazione della Pasqua. Era circa la sesta ora. Disse ai Giudei: "Ecco il vostro Re!". Gridarono: "Via lui, via lui, crocifiggilo!" Pilato disse loro: "Devo crocifiggere il vostro re?" I capi sacerdoti risposero: "Non abbiamo altro re che Cesare". Così lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Allora presero Gesù ed egli uscì, portando la sua croce, verso il luogo chiamato Luogo del Cranio, che in ebraico si chiama Golgota. Lì lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo a loro" (Gv 19,13-18).
Cristo era stato imprigionato, tenuto in catene, nella casa di Caifa, situata in una zona adiacente alle mura della città, non lontano dal palazzo di Erode. Da lì, ancora in catene, sarebbe stato portato alla Torre Antonia, sede del governo romano.
I ritrovamenti archeologici hanno collocato il praetorium menzionato da San Giovanni all'interno della Torre Antonia, costruita all'estremità orientale della seconda cinta muraria a nord-est della città.
L'impressionante modello di Gerusalemme all'epoca del Secondo Tempio (fino al 70 d.C.) che si può ammirare al Museo d'Israele ci dà un'idea di come sarebbe stata la città quando Gesù la attraversò portando la sua croce.
Il percorso sarebbe partito dalla Torre Antonia verso la periferia della città, dove si trovava il tumulo del Golgota (oggi all'interno della Basilica del Santo Sepolcro).
La distanza era di circa 600 metri, circa 2000 passi, che Cristo avrebbe percorso carico della traversa orizzontale (patibolo) della croce, il cui peso avrebbe oscillato tra le 110 e le 150 libbre circa.
Tutto questo dopo essere stato imprigionato (probabilmente appeso per le mani), aver ricevuto decine di frustate nel Pretorio, e con la testa sanguinante per le spine della corona intrecciata dai soldati. Le orme di Cristo, che ancora riecheggiano nella Città Santa, hanno camminato per la prima volta in un'area di confine. Via Crucis.
Oggi, il Via Dolorosa a Gerusalemme segue solo una parte di quello che sarebbe stato il percorso di Gesù dal Pretorio al luogo dell'esecuzione. A quel tempo, il luogo si trovava fuori dalle mura della città, in una sorta di terra desolata. Oggi la Basilica del Santo Sepolcro, che contiene sia il Golgota che la tomba in cui fu deposto Cristo, si trova nel quartiere cristiano della cosiddetta Città Vecchia di Gerusalemme.
Il Via Dolorosa non è una semplice strada, ma un percorso composto da parti di diverse strade, ed è diviso tra i quartieri musulmani e cristiani.
La storia della devozione
Gli alti e bassi di questa devozione sono stati influenzati dalle vicissitudini storiche attraverso cui è passato l'attuale Israele. I viaggiatori del tempo ci hanno lasciato descrizioni delle varie stazioni visitate in pellegrinaggio dalla Chiesa di Gerusalemme. Una delle fonti più ricche è la ben nota Itinerarium Egeriaedalla fine del IV secolo. Egeria, una pellegrina che si recò in Terra Santa dalla provincia romana della Galizia nel 381-384 d.C., scrisse il suo resoconto di viaggio, Itinerarium ad Loca Sanctaverso la fine del secolo: in esso descrive il suo viaggio nei Luoghi Santi in Oriente, le liturgie e le funzioni religiose svolte in Terra Santa.
La caduta dell'impero bizantino e la successiva dominazione islamica nell'area ostacolarono la pietà popolare dei cristiani e dei pellegrini locali. I cristiani presenti a Gerusalemme attraversarono tempi difficili e, sebbene la devozione alla Passione di Cristo non scomparve mai, la quasi impossibilità di pellegrinaggio portò a un declino della pratica di seguire le orme della Passione.
Dopo la riconquista della Città Santa da parte dei Crociati, queste pratiche di pietà ritornarono. Nella prima metà del XIV secolo, papa Clemente VI affidò ai francescani "la guida, l'istruzione e la cura dei pellegrini latini, nonché la custodia, la manutenzione, la difesa e i riti dei santuari cattolici di Terra Santa", e si sviluppò la pratica di commemorare la via percorsa da Gesù stesso.
Le stazioni del Via Dolorosa
Dal 1880, ogni venerdì (tranne una pausa durante la pandemia), a partire dalle 15:00, la comunità francescana conduce solennemente la Via Crucis per le strade di Gerusalemme.
Il percorso inizia alla Porta dei Leoni, nel cortile della Scuola Omariya, una madrassa islamica che occupa l'area dell'antica fortezza Antonia.
A pochi metri di distanza troviamo due piccole chiese, una di fronte all'altra, dedicate alla prima e alla seconda stazione. Le chiese, di piccole dimensioni, sono state costruite nel probabile luogo in cui si trovava il cortile del Pretorio. Come curiosità, sul pavimento della cappella che ricorda la presa della croce da parte di Cristo, si possono vedere "tavole" di antichi giochi di dadi tagliate nella pietra, risalenti ai primi secoli e che potrebbero far parte di quei giochi con cui i soldati tirarono a sorte i vestiti di Gesù. La terza stazione è contrassegnata da una cappella del Patriarcato armeno cattolico. Si tratta di uno dei punti più conosciuti della Via Dolorosa.
Vicino troviamo l'arco della porta che segna la quarta stazione: Gesù incontra Maria, sua Madre. Una piccola cappella francescana, poco distante dalla chiesa di Santa Maria dello Spasmo (restaurata dagli armeni nel 1881), ricorda l'episodio di Simone di Cirene che si contempla nella quinta stazione.
La sesta stazione è una cappella greco-cattolica. L'episodio della Veronica, frutto della pietà popolare, è ricordato nel mosaico dell'oratorio. A sud si possono vedere i resti di un antico muro e gli archi di un edificio non identificato, che alcuni ritengono essere il monastero dei Santi Cosma e Damiano (costruito negli anni 548-563 d.C.). All'esterno, una colonna in pietra con l'iscrizione Pia Veronica faciem christi linteo deterci[t] è un altro dei punti più significativi di questo percorso. Da qui, le stazioni entrano nel quartiere cristiano, su quella che sarebbe stata la cardo massimo di Gerusalemme al tempo del Signore. Siamo già molto vicini alla Basilica del Santo Sepolcro, dove si recitano le ultime cinque stazioni della Via Crucis.
Al posto della settima stazione si trova una piccola cappella francescana, nella quale si trova una colonna che probabilmente faceva parte delle colonne che segnavano la strada principale della Gerusalemme romana. Il luogo dell'ottava stazione è indicato da una piccola croce nera incisa sulla parete del muro del monastero greco di San Charalambos. A questo punto, il Via Dolorosa "si interrompe", per cui si torna al bivio precedente per proseguire il cammino verso il Santo Sepolcro.
Quasi all'ingresso dello strano cortile che conduce alla Basilica del Santo Sepolcro, la nona stazione è indicata su una colonna posta vicino alla porta del monastero copto, dietro l'abside della Basilica del Santo Sepolcro.
All'interno si trovano le cinque stazioni finali della Via Crucis, che si riferiscono agli eventi che si sono svolti direttamente tra il Calvario e la tomba scavata nella roccia di Giuseppe d'Arimatea, dove Gesù fu deposto dopo la sua morte.
Oggi queste due aree, distanti solo pochi metri l'una dall'altra, sono coperte da un unico tetto, anche se sono chiaramente differenziate e continuano a manifestare, con grida silenziose, la grandezza della salvezza operata da Cristo attraverso la sua morte e resurrezione.
Nella Città Santa, la meditazione sui misteri della Passione assume un'intensità e un significato particolari. Solo a Gerusalemme chi prega questa devozione può dire "qui". QuiIn questo luogo, Gesù fu condannato a morte; qui è morto sulla croce; e quiIn questo luogo è risorto e ha fatto di tutta la terra la casa dei suoi figli.
Decalogo per la preparazione al matrimonio
I dieci punti chiave che emergono dalla lettura delle linee guida pastorali pubblicate nel giugno 2022, che tengono conto della ricchezza delle situazioni che le famiglie stanno affrontando attualmente
Traduzione dell'articolo in inglese
Dopo aver letto e approfondito il tema del Itinerari catecumenali per la vita matrimonialeDalla lettura di questo documento si può estrarre un decalogo di idee chiave, di cui si può trovare un'ampia sintesi qui.
1- Il scopo di preparazione al matrimonio nella Chiesa è il santità coniugale: formare matrimoni in grado di evangelizzare la nostra società.
2- Il grazia del sacramento porta gli sposi a prendere il la consapevolezza della presenza efficace di Cristo nella loro comunione di vita e di amore coniugale.
3- Il grandezza della vocazione degli sposi cristiani richiede un lavoro ecclesiale serio e prolungato, con un approccio formativo attraente, onnicomprensivo, profondo e intenso.
4- Il modo corretto per realizzare un matrimonio cristiano è un "....".catecumenato". o itinerario di fede, in cui i futuri sposi abbracciano il dono divino e affrontare il protagonismo del suo processo di preparazione, guidati e accompagnati dai pastori e dagli altri membri della Chiesa in modo tempestivo.
5- La formazione ad un amore coniugale maturo presuppone una processo di formazione continua, in varie fasidalla preparazione remoto nell'infanzia e nella giovinezza (in famiglia, in parrocchia, a scuola, nei movimenti e nei gruppi ecclesiali), fino alla prossimo e immediato alla celebrazione del sacramento (della durata di almeno un anno), che proseguirà anche dopo la contrazione del sacramento nella vita matrimoniale (soprattutto nei primi anni).
6- La Chiesa deve istruire ed essere vicini della sposa e dello sposo mentre si recano al matrimonio, con uno stile positivo, incoraggiante e testimoniale da fiducia e dialogo sincero; è anche necessario preghiera personale e comunitario, con la puntuale celebrazione sacramentale della Eucaristia e il Riconciliazione. In questo modo, i futuri sposi potranno accogliere con speranza il Vangelo del matrimonio e della famiglia e viverlo all'interno della comunità ecclesiale.
7- La buona novella del matrimonio cristiano deve essere trasmessa in modo processo graduale di purificazione e crescitacon misericordia e prudenza. In questo modo, i candidati allo stato matrimoniale potranno assimilare la benedizione del sacramento, superando con l'aiuto appropriato possibile carenze e limiti e migliorare la comunicazione di coppia.
8- Occorre assicurarsi che gli sposi comprendano il significato, gli scopi, le caratteristiche e i vantaggi del matrimonio. il matrimonio secondo il piano di Dio della creazione e della redenzione. Potranno poi sceglierlo in modo consapevole e maturo, in un esercizio di riflessione e discernimentoevitando le confusioni culturali di alcune diffuse ideologie sbagliate.
9- L'educazione affettivo-sessuale del cuore attraverso la virtù umana e cristiana della castità, alleata dell'amoree la spiegazione ragionata della dottrina della procreazione responsabile, ci permetterà di comprendere e abbracciare con gioia la bellezza del significato del corpo umano nella sua mascolinità e femminilità come chiamata alla comunione interpersonale.
10- La preparazione e l'accompagnamento ecclesiale adeguati e permanenti sono garanzia dell'adempimento della promessa di Dio inscritta nella vocazione coniugale. In questo modo, l'alleanza coniugale può portare frutto nella gioia feconda delle case cristiane, per la gloria di Dio e l'estensione del suo regno nel nostro mondo.
Preparazione adeguata al matrimonio cristiano
L'Anno della famiglia "Amoris laetitia" si concluderà il 26 giugno 2022. Pochi giorni prima sono stati pubblicati gli Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Un documento che si propone di aggiornare, rinnovare e soprattutto rendere reale l'inserimento delle famiglie cristiane nel cammino della Chiesa con le circostanze attuali.
 Perché sposarsi? Il matrimonio cristiano nel XXI secolo
Perché sposarsi? Il matrimonio cristiano nel XXI secolo Il matrimonio cristiano: una grande speranza
Il matrimonio cristiano: una grande speranza Matrimonio: "Missione possibile
Matrimonio: "Missione possibileIl Anno della Famiglia "Amoris laetitia".Gli Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale sono stati pubblicati il 26 giugno 2022. Pochi giorni prima sono stati pubblicati gli Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Si tratta di orientamenti pastorali che, tenendo conto della ricchezza delle situazioni che le famiglie stanno attraversando, propongono una seria revisione della formazione al matrimonio cattolico. gli itinerari sono impegnati in un catecumenato pratico e reale, basato sull'accompagnamento degli sposi e delle famiglie lungo tutta la loro vita.
1.Vademecum sulla cura pastorale delle coppie sposate
Il 15 giugno 2022, il Dicastero vaticano per i Laici, la Famiglia e la Vita ha pubblicato un importante documento dal titolo: Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Si tratta di un vademecum o manuale puntuale con linee guida o linee guida per un adeguato ministero di preparazione al matrimonio per il nostro tempo.
In continuità con il magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il Santo Padre Francesco ha spiegato in varie occasioni la necessità di questo catecumenato matrimoniale, che è "un antidoto per evitare il proliferare di celebrazioni matrimoniali nulle o incoerenti" (Discorso alla Rota Romana, 21-1-2017).
In effetti, da un punto di vista negativo, la necessità di preparazione è oggi ancora più urgente, visti i deplorevoli tassi di fallimento coniugale. Non possiamo restare a guardare impassibili mentre il tessuto familiare si sgretola in una controcultura della rottura e del divorzio, che provoca tanta distruzione umana.
La Chiesa, in quanto madre e maestra, riconosce il dovere che ha di "accompagnare responsabilmente a coloro che manifestano l'intenzione di sposarsi, affinché siano preservati da i traumi della separazione e non perdere mai la fede nell'amore" (Prefazione).
In senso positivo, l'originalità e la finalità della proposta di matrimonio catecumenato è decisivo: "mira a far risuonare tra gli sposi il mistero della grazia sacramentale, che corrisponde loro in virtù del sacramento: a far risuonare tra gli sposi il mistero della grazia sacramentale, che corrisponde loro in virtù del sacramento: a far risuonare tra gli sposi il mistero della grazia sacramentale. presenza viva di Cristo con loro e tra di loro"; per questo è necessario "seguire con loro il cammino che li porta ad avere un incontro con Cristo, o ad approfondire questo rapporto, e a fare un autentico discernimento della propria vocazione nuziale" (n. 6). Il dono dello Spirito deve essere accolto correttamente per produrre frutti di santità e di evangelizzazione.
2. Formazione alla santità coniugale
A questo proposito, è necessario riconoscere una una certa incoerenza La Chiesa dedica molto tempo, diversi anni, alla preparazione dei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa, ma poco tempo, solo poche settimane, a quelli che si preparano al matrimonio" (Prefazione). È quindi necessario un rinnovato apprezzamento della vocazione al matrimonio, in conformità con la chiamata universale alla santità e alla missione - che include i fedeli laici con la loro specificità - proclamata con enfasi dal Concilio Vaticano II. Si deve affermare che "il sacramento dell'Ordine, la consacrazione religiosa e il sacramento del matrimonio meritano la stessa curaperché il Signore chiama uomini e donne all'una o all'altra vocazione con la stessa intensità e lo stesso amore" (n. 7). Per questo motivo, gli sposi cristiani hanno bisogno di una formazione integrale, profonda e costante, affinché possano svolgere il loro compito per il bene dell'intera comunità umana.
Va notato che questo documento vaticano ha pretese limitate, in quanto non è un manuale per il corso prematrimoniale, né prende in considerazione tutti i temi della pastorale familiare, ma si limita a offrire le le indicazioni più importanti per la preparazione alla vita matrimoniale. P
Pertanto, sono molti gli strumenti dottrinali e pastorali da articolare, come specificato nella Elenchi del ministero della famiglia delle conferenze episcopali e delle diocesi.
Così, ad esempio, Francesco indica che questo documento dovrà essere integrato da "un altro documento che indichi metodi pastorali concreti e possibili itinerari di accompagnamento, specificamente dedicati a quelle coppie che hanno sperimentato il fallimento del loro matrimonio e vivono una nuova unione o si sono risposate civilmente" (Prefazione).
3. Mainstreaming, sinodalità, continuità
Dobbiamo tenere presente che non è un testo normativo ma pastoraleaperta alla considerazione delle diverse realtà dei soggetti e degli ambienti da evangelizzare. Per questo motivo, questi "linee guida che chiedono di essere accolti, adattato e mettere in pratica nelle concrete situazioni sociali, culturali ed ecclesiali" (Prefazione), in un esercizio prudente da parte dei pastori e degli altri operatori del delicato compito di preparazione alla vita matrimoniale cristiana.
Vengono identificati tre principi generali dell'azione pastorale. In primo luogo, il mainstreaming, il che "significa che la pastorale della vita matrimoniale non si limita all'ambito ristretto degli incontri dei fidanzati, ma attraversa molti altri ambiti pastorali ed è sempre presente in essi" (n. 12). In realtà, è la vita stessa della coppia (fidanzati o sposi) che viene accompagnata con cura dalla Chiesa, affinché la vocazione produca tutti i frutti di santità che contiene in germe, capaci di irradiare e fecondare la società con il Vangelo del matrimonio e della famiglia.
In secondo luogo, il sinodalitàper "La Chiesa è comunione e realizza concretamente la sua comunione nel camminare insieme, nel coordinamento di tutti gli ambiti pastorali e nella partecipazione attiva di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice" (n. 13). In questo campo di azione ecclesiale, come in altri, dobbiamo evitare un riduzionismo clericale o che molti si disimpegnino dal mandato del Signore trascurando i loro doveri: siamo tutti responsabili - ciascuno secondo la propria vocazione, le proprie capacità e i propri carismi - dell'evangelizzazione della società, delle culture e dei popoli.
Il terzo criterio è la continuità, che "è si riferisce al carattere non episodico, ma prolungato nel tempo, che include permanente. Questo permette di stabilire itinerari pedagogici che, nelle varie tappe di crescita, accompagnino il radicamento della vocazione al matrimonio nel cammino di iniziazione cristiana alla fede" (n. 14). Si verifica qualcosa di analogo ai processi di educazione o di maturazione umana: la loro interruzione o trascuratezza è controproducente e spesso dannosa. Si devono considerare diverse modalità, adattate in modo opportuno alle fasi e alle situazioni della vita, ma il compito della formazione umana e cristiana non deve mai essere abbandonato. A questo proposito, è necessario ricordare di evitare "lunghi periodi di trascuratezza pastorale di alcune fasi della vita dei singoli e delle famiglie, che purtroppo portano all'allontanamento dalla comunità e spesso anche dalla fede" (n. 15). Se la formazione viene trascurata, la confusione e l'esposizione a deformazioni ideologiche, come l'emotività passionale o il pansessualismo materialista, avanzano irrimediabilmente. Una formazione adeguata e ininterrotta, invece, favorisce lo sviluppo di persone di giudizio, solidamente fondate nella verità del Vangelo e nelle virtù umane e cristiane.
4. Catecumenato
Aggiungiamo che, sebbene le modalità e gli adattamenti possano essere molto vari, il catecumenato matrimoniale non è una cosa qualsiasi: ha una coerenza e alcune caratteristiche elementari, che sono esplicitate in questo documento. Inoltre, questa istituzione si ispira alla bella e secolare tradizione ecclesiale della preparazione al battesimo degli adulti. "Il Rituale dell'iniziazione cristiana degli adulti può essere un quadro di riferimento da cui trarre ispirazione" (n. 19).
Per questo motivo, "nell'elaborazione di questo progetto è necessario tenere conto di alcune requisitiper la durata del tempo sufficiente per permettere alle coppie di riflettere e maturare; che, a partire dall'esperienza concreta dell'amore umano, della fede e delle incontro con Cristo essere posto al centro della preparazione al matrimonio; che sia organizzato da tappesegnati - ove possibile e appropriato - da riti di passaggio celebrati all'interno della comunità; comprendendo tutti questi aspetti elementi: formazione, riflessione, dialogo, confronto, liturgia, comunità, preghiera, festa" (n. 16).
Il documento ritiene che una proposta concreta per iniziare questo percorso potrebbe essere l'attuazione nelle diocesi, laddove possibile, di una "progetto pilota". (n. 17). Tuttavia, "questo strumento pastorale non può essere semplicemente imposto come l'unico modo per prepararsi al matrimonio, ma deve essere usato con discernimento e buon senso" (n. 16). Infatti, un obbligo indiscriminato potrebbe avere effetti controproducenti, come l'allontanamento di molti dal sacramento del matrimonio o l'adempimento esteriore e formale, in quanto requisito imposto da sopportare e soddisfare "a malincuore". Si tratta piuttosto di un suggerimento coerente, che deve essere mostrato ai candidati come un'offerta plausibile di formazione integrale. Affinché questo strumento formativo sia veramente efficace, deve essere presentato in modo adeguato e attraente, in modo che gli stessi candidati al sacramento del matrimonio arrivino a scoprire, desiderare e assumere un ruolo guida nel progetto.
5. Guidare, aiutare, accompagnare
Nella caratterizzazione di questa modalità formativa, il documento considera alcune caratteristiche generali e metodologiche: il suo intento deve essere quello di "... fornire la migliore formazione possibile agli studenti e alle loro famiglie".guidare, aiutare ed essere vicini alle coppie in un cammino da percorrere insieme"Non è una preparazione per un esame da superare, ma per una vita da vivere"; il moralismo va evitato e bisogna invece fare attenzione a "...".proattiva, persuasiva, incoraggiante e tutta orientata al bene e al bello che è possibile vivere. nel matrimonio"; deve anche prendere in considerazione ".gradualità, accoglienza e sostegnoma anche la testimonianza di altri sposi cristiani che siano accoglienti e presenti lungo il cammino", perché ciò contribuirà a "creare un clima di amicizia e di fiducia" (n. 20), così necessario per l'efficacia di questo cammino verso il matrimonio cristiano.
Ogni persona e ogni coppia sarà accompagnata nel suo cammino di riflessione, conversione e comprensione del significato umano e cristiano della vita matrimoniale, "sempre seguendo la logica della rispettoil pazienza e il misericordia. Tuttavia, non porta mai ad oscurare i requisiti del verità e carità del Vangelo proposto dalla Chiesa, e non si deve mai permettere che oscuri il piano divino dell'amore umano e del matrimonio nella sua pienezza. bellezza e grandezza" (n. 56).
In genere, "il squadra di accompagnatori che guida il cammino può essere formato da coppie assistite da un sacerdote e da altri esperti nella pastorale familiare" (n. 21). La presenza di coppie sposate non è dovuta solo alla carenza di clero, ma risponde anche alla vocazione di evangelizzatori degli sposi e alla connaturalità della forma di vita che desiderano intraprendere.
Inoltre, occorre tenere presente che "alcune questioni complesse relative alla sessualità coniugale o all'apertura alla vita (ad esempio la paternità responsabile, l'inseminazione artificiale, la diagnosi prenatale e altre questioni bioetiche) hanno forti implicazioni etiche, relazionali e spirituali per i coniugi, e richiedono oggi una formazione specifica e una chiarezza di idee" (n. 22). Il documento ricorda anche "l'urgenza di una formazione più adeguata di sacerdoti, seminaristi e laici (comprese le coppie sposate) nel ministero di accompagnare i giovani al matrimonio" (n. 86).
6. Valutare situazioni e atteggiamenti
È inoltre necessario considerare, distinguere e accompagnare le varie situazioni esistenziali in modo appropriato e tempestivo di coloro che si avvicinano al sacramento del matrimonio ai nostri giorni. Il gran numero di persone che vivono più o meno lontane dalla fede e dalla Chiesa richiede una proposta sollecita e tempestiva: "L'esperienza pastorale in gran parte del mondo mostra ormai la presenza costante e diffusa di nuove richieste di preparazione al matrimonio sacramentale da parte di coppie che già convivono, hanno contratto matrimonio civile e hanno figli. Tali richieste non possono più essere eluse dalla Chiesa, né possono essere appiattite in percorsi predisposti per chi proviene da un cammino di fede minimale; richiedono piuttosto forme di accompagnamento personalizzato" (n. 25).
Spesso incontriamo "coppie che hanno scelto di vivere insieme senza sposarsi, ma che tuttavia rimangono aperte alla religione e sono disposte ad avvicinarsi alla Chiesa". Con un occhio di riguardo, hanno bisogno di essere accolti con calore e senza legalismoapprezzando il suo desiderio di famiglia" (n. 40). Un'adeguata azione pastorale non si pone in schemi teorici, ma si colloca nel luogo vitale - atteggiamenti, disposizioni, situazioni, ecc. - in cui le persone si trovano per aiutarle con la sapienza umana e soprannaturale secondo le tappe di guarigione e di crescita nella conversione in atto e nell'ascesa verso la pienezza umana che è la santità.
7. Rituali significativi
Il documento propone alcuni riti simbolici o gesti quasi liturgici di iniziazione o di culmine dei vari stadi o fasi di questo processo o percorso formativo. "Tra i riti da considerare, prima di arrivare al rito del matrimonio vero e proprio, possono esserci: la consegna della Bibbia agli sposi, la presentazione alla comunità, la benedizione degli anelli di fidanzamento, la consegna di una preghiera di coppia che li accompagnerà nel loro cammino. L'opportunità di ciò sarà valutata in base alla realtà ecclesiale locale. Ognuno di questi riti può essere accompagnato da un ritiro" (n. 23).
Questa iniziativa è stata realizzata con cautelaDa un lato, è importante evitare di creare aspettative eccessive che forzino la libertà dei candidati; dall'altro, è altrettanto importante evitare la confusione o l'identificazione con i riti propri del sacramento. Per questo motivo, il testo esorta alla "necessaria prudenza e a un'attenta valutazione di come proporre questi riti, in base al contesto sociale in cui si agisce". In alcuni casi, ad esempio, può essere preferibile che questi riti vengano celebrati solo all'interno del gruppo di coppie che seguono il viaggio, senza coinvolgere le famiglie o altre persone. In altri casi, invece, è preferibile evitarli del tutto" (n. 26). Pertanto, questi riti sono suggerimenti da tenere in considerazione e utilizzare con cautela per trarre vantaggio dalla sua stimolo perseverare con entusiasmo nel percorso formativo ed evitare possibili effetti controproducenti.
8. Passi. Preparazione a distanza
Dal momento che l'obiettivo è quello di accompagnare la crescita interna, questo processo o percorso articolato deve tenere in considerazione i seguenti aspetti varie fasi dello sviluppo formativo e della maturità umana e cristiana. Pertanto, il documento suggerisce che "in una prospettiva pastorale di lungo periodo, sarebbe bene che il cammino catecumenale vero e proprio fosse preceduto da una fase pre-catecumenale: ciò coinciderebbe praticamente con il lungo periodo di preparazione a distanza al matrimonio, che inizia nell'infanzia. Il corretta fase catecumenale è costituito da tre fasi distinte: la preparazione imminenteil preparazione immediata e l'accompagnamento del primi anni di vita matrimoniale" (n. 24).
Nell'educazione familiare ed ecclesiale al vero amore durante l'infanzia e la giovinezza, i bambini e i giovani sono obiettivi della preparazione a distanza sono: "a) educare i bambini all'autostima e alla stima per gli altri, alla conoscenza della propria dignità e al rispetto per gli altri; b) presentare ai bambini l'antropologia cristiana e la prospettiva vocazionale contenuta nel battesimo che porterà al matrimonio o alla vita consacrata; c) educare gli adolescenti all'affettività e alla sessualità in vista della futura chiamata a un amore generoso, esclusivo e fedele (nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata); d) proporre ai giovani un cammino di crescita umana e spirituale per superare immaturità, paure e resistenze per aprirsi a relazioni di amicizia e di amore, non possessivo o narcisistico, ma libero, generoso e donativo" (n. 36). 36).
9. Accoglienza: annuncio e maturazione del progetto coniugale
Nel fase intermedia o di ricezione dei candidati al catecumenato matrimoniale, "sarà decisivo lo stile di relazione e di accoglienza messo in atto dall'équipe pastorale"; infatti "è importante che il momento dell'accoglienza diventi un annuncio della kerigmaper garantire che il amore misericordioso di Cristo costituisce l'autentico luogo spirituale in cui la coppia viene accolta" (n. 38).
In questo caso il documento pone l'accento su alcuni caratteristiche dello stile di evangelizzazione che è particolarmente importante per gli sposi: "La pastorale matrimoniale deve sempre avere un carattere gioioso e cherigmatico -Lo stesso sacramento del matrimonio deve essere oggetto di un vero e proprio annuncio da parte della Chiesa; la fedeltà, l'unicità, la definitività, la fecondità e la totalità sono, del resto, le dimensioni essenziali di ogni legame d'amore autentico, compreso, voluto e coerentemente vissuto da un uomo e da una donna" (n. 39).
È necessario aiutare a superare gli atteggiamenti superficiali che - spesso inconsapevolmente e incolpevolmente - sono tenuti da coloro che chiedono alla Chiesa il sacramento nuziale, perché "è importante che ci sia la volontà interiore di iniziare un cammino di conversione alla fede attraverso il catecumenato matrimoniale" (n. 42). Nel discernimento di intenzione matrimoniale La dottrina ecclesiastica distingue tra la virtù della fede nei candidati e la volontà di desiderare un vero matrimonio. "La presenza di una fede viva ed esplicita nelle coppie è ovviamente la situazione ideale per arrivare al matrimonio con l'intenzione chiara e consapevole di celebrare un vero matrimonio. Tuttavia, una condizione necessaria per l'accesso al sacramento del matrimonio e alla sua validità rimane la loro intenzione di fare ciò che la Chiesa intende fare nel celebrare il matrimonio tra battezzati" (n. 44).
Pertanto, "se rifiutano esplicitamente e formalmente ciò che la Chiesa vuole realizzare nella celebrazione del matrimonio, gli sposi non possono essere ammessi alla celebrazione sacramentale" (n. 45). I pastori non possono trascurare la formazione e la conversione delle anime, perché hanno il grave dovere di "far conoscere la volontà della Chiesa nella celebrazione del matrimonio" (n. 45). per far emergere le vere intenzioni L'intenzione della Chiesa è che la preparazione e la celebrazione del matrimonio non si riducano ad atti puramente esteriori, ma che gli sposi stessi ne siano consapevoli. Se invece, senza negare ciò che la Chiesa vuole ottenere, vi è una disposizione imperfetta da parte di coloro che desiderano sposarsi, non si deve escludere la loro ammissione alla celebrazione del sacramento" (n. 45).
In questa fase è necessario "approfittare di questa situazione come un un momento favorevole per riscoprire la propria fede e portarla a maggiore maturità.Il progetto è un ritorno alle radici del suo battesimo, riaccendere il seme della vita divina che è già stata seminata in loro, e invitandoli a riflettere sulla scelta del matrimonio sacramentale come consolidamento, santificazione e piena realizzazione del loro amore" (n. 45). Pertanto, con pazienza e zelo, i pastori e gli altri incaricati di questo compito devono favorire lo sviluppo delle giuste condizioni interiori per arrivare a un matrimonio vero e preparato nelle migliori condizioni possibili.
Tuttavia, spesso accade che entrambe le parti o "una di esse" si rifiutino di seguire il cammino catecumenale. In tutti questi casi, spetterà al presbitero valutare il modo migliore di procedere nella preparazione al matrimonio" (n. 46), in modo da garantire non solo la validità del sacramento, ma anche che non venga sprecato e produrre frutti di vita Cristiano.
10. Prossima preparazione: cammino di fede vocazionale
Per quanto riguarda il momento principale del catecumenato, "in termini generali, si suggerisce che il preparazione imminente durano circa un annoa seconda della precedente esperienza di fede e di coinvolgimento ecclesiale della coppia. Una volta presa la decisione di sposarsi, possono iniziare i preparativi immediati. al matrimonio, della durata di alcuni mesi, per diventare una vera e propria iniziazione al sacramento del matrimonio" (n. 48).
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario cambiare drasticamente il modo in cui la mentalità dei pastori e poi del popolo di Dio, in modo che tutti si rendano conto che la preparazione al matrimonio è una cosa serio e intensoQuesto non deve rimanere la patina superficiale di un corso breve. A questo proposito può essere utile considerare l'analogia con la rigore nel formazione accademica e professionale che sono così esigenti nel nostro tempo. Per, in modo simile alle competenze tecniche, artistiche o sportive, preparare soggetti virtuosiLa formazione di coloro che sono veramente capaci di vero amore sponsale, che hanno raggiunto la maturità della libertà del dono di sé, richiede uno sforzo formativo di grande portata, intensità e durata.
"Il catecumenato matrimoniale in questa fase assumerà il carattere di un vero e proprio catecumenato. viaggio di fedeDurante il quale il messaggio cristiano sarà riscoperto e riprodotto nella sua perenne novità e freschezza. Anche i candidati al matrimonio saranno gradualmente iniziati alla preghiera cristiana" (n. 49). Durante questo periodo, "le coppie devono essere aiutate a avvicinarsi alla vita della chiesa e di partecipare in esso. Con dolcezza e calore umano, saranno invitati a partecipare ai momenti di preghiera, all'Eucaristia domenicale, alla confessione, ai ritiri, ma anche ai momenti di festa e di convivialità" (n. 50).
Sarà inoltre "indispensabile preparare un itinerario di riflessione sul patrimonio coniugalee quindi essere pronti ad accettare queste grazie e ad accogliere questi beni come un dono" (n. 51). "Sarà importante in questa fase di approfondire tutto ciò che ha a che fare con la relazione di coppia e le dinamiche interpersonali con le sue regole, le sue leggi di crescita, gli elementi che lo rafforzano e quelli che lo indeboliscono" (n. 52). Per questo è necessario affidarsi ai contributi delle scienze umane.
Inoltre "hanno bisogno di essere adeguatamente esplorati: le dinamiche umane di sessualità coniugaleLa corretta concezione della paternità responsabile, l'educazione dei figli" (n. 53). E, infine, è necessario "prendere coscienza della possibili carenze psicologiche e/o affettiveche possono indebolire o addirittura annullare del tutto l'impegno di donazione e di amore reciproco che gli sposi si promettono. Ma possono essere lo stimolo per iniziare un processo di crescita più serio che prepara a una condizione sufficiente di libertà interiore e di maturità" (n. 54).
L'obiettivo specifico di questa tappa centrale del catecumenato matrimoniale è quello di "completare il percorso di formazione". discernimento di ogni coppia sulla propria vocazione matrimoniale. Questo può portare a una decisione libera, responsabile e ponderata di sposarsi, oppure può portare a una decisione altrettanto libera e ponderata di porre fine alla relazione e di non sposarsi. Questo discernimento, che deve avvenire anche nell'ambito del dialogo spirituale" (n. 55).
11. Imparare la castità, alleata dell'amore
Uno dei temi centrali di questa fase formativa deve essere la corretta comprensione e il apprendimento vitale della virtù umana e cristiana della castitàEssa "deve essere presentata come un vero alleato dell'amore, non come la sua negazione". È, infatti, la via privilegiata per imparare a rispettare l'individualità e la dignità dell'altro, senza subordinarla ai propri desideri. È di fondamentale importanza per guidare e alimentare l'amore coniugale, preservandolo da qualsiasi manipolazione. Insegna, in qualsiasi stato di vita, a essere fedeli alla verità del proprio amore.
Ciò significa, per gli sposi, vivere la castità in continenza e, una volta sposati, vivere l'intimità coniugale con rettitudine morale. La castità facilita la conoscenza reciproca tra gli sposi, perché, impedendo che la relazione si fissi sulla strumentalizzazione fisica dell'altro, permette una dialogo più profondoa manifestazione più libera del cuore e l'emergere di tutti gli aspetti della propria personalità - umani e spirituali, intellettuali e affettivi - in modo da consentire una vera crescita nella relazione, nella comunione personale, nella scoperta della ricchezza e dei limiti dell'altro: e questo è il vero scopo del periodo di fidanzamento.
Sono diversi e belli valori e le attenzioni che la virtù della castità insegna: la rispetto dell'altro, l'attenzione a non assoggettarlo mai ai propri desideri, il pazienza e il delicatezza con il coniuge nei momenti di difficoltà, fisicamente e spiritualmente, la forza e l'impegno di un'altra persona. autocontrollo necessario in caso di assenza o malattia di uno dei coniugi, ecc.
12. Cura della sostanza e della forma
Per quanto riguarda il metodologia di questa fase centrale, va sottolineato che "è necessario che la trasmissione di contenuti Gli approcci teorici devono essere accompagnati dalla proposta di un percorso spirituale che includa esperienze di preghiera (personale, comunitario e di coppia), celebrazione dei sacramenti, ritiri spirituali, tempi di adorazione eucaristica, esperienze missionarie, attività caritative" (n. 58). Senza trascurare il tono testimonianza da fiducia che rende possibile l'autentica apertura e il rinnovamento interiore.
In breve, il obiettivi della prossima preparazione sono: "a) riproporre una catechesi di iniziazione alla fede cristiana e un approccio alla vita della Chiesa; b) vivere un'iniziazione specifica al sacramento del matrimonio e prendere chiara coscienza delle sue note essenziali; c) approfondire i temi legati alla relazione di coppia e prendere coscienza delle proprie carenze psicologiche e affettive; d) completare una prima fase di discernimento della coppia sulla vocazione nuziale; e) continuare un cammino spirituale con maggiore decisione" (n. 63).
13. Preparazione immediata all'impegno
Nel mesi precedenti La preparazione immediata alle nozze avviene prima della celebrazione del matrimonio. "Sarà opportuno ricordare i contenuti principali del percorso di preparazione finora seguito: si porrà l'accento sulle condizioni indispensabili di libertà e di piena consapevolezza degli impegni assunti nella scelta da compiere, legata alle caratteristiche essenziali del matrimonio" (n. 65).
Gli obiettivi della preparazione alle porte della celebrazione del sacramento sono: "a) ricordare gli aspetti dottrinali, morali e spirituali del matrimonio; b) fare esperienze spirituali di incontro con il Signore; c) prepararsi a una partecipazione consapevole e fruttuosa alla liturgia nuziale" (n. 73).
14. Colmare i vuoti e favorire l'inserimento ecclesiale
Sebbene questo percorso rappresenti il quadro formativo ideale e completo, è tuttavia realisticamente frequenti e regolari "che alcune coppie vengono inserite solo ora nell'itinerario catecumenale, e che la preparazione immediata è l'unica possibilità concreta per loro di ricevere un minimo di formazione. in vista della celebrazione del sacramento del matrimonio. Per loro sarebbe opportuno organizzare alcuni incontri personalizzati con l'équipe pastorale di preparazione al matrimonio, per far sentire loro la cura e l'attenzione, per approfondire insieme alcuni aspetti più personali della scelta matrimoniale, secondo la situazione della coppia, e per stabilire un rapporto di fiducia, cordialità e amicizia con gli accompagnatori" (n. 65).
Si tratta di compensare le mancanze con la carità, ma senza pensare che questa situazione eccezionale, per quanto diffusa, sia la normalità o il bene. Con pazienza e prudenza, i pastori e gli altri membri della comunità cristiana devono cercare di inserirsi nella vita della Chiesa a chi è lontano e invitare tutti a partecipare a processi di formazione alla fede adeguati.
In questa fase, inoltre, è necessario "mettere sempre al centro l'incontro con il Signore come fonte di tutta la vita cristiana". Infatti, è sempre necessario andare oltre la semplice visione sociologica del matrimonio al fine di far comprendere ai coniugi la mistero di grazia che è implicito in essa" (n. 66). In quest'ultima fase che precede la celebrazione del matrimonio "sarà utile riformulare l'annuncio cherigmatico di redenzione di Cristo che ci salva dalla realtà del peccato, che sempre incombe sulla vita dell'uomo"; così come "il ricorso al perdono di Dio che, nella sacramento della riconciliazioneEgli dona il suo amore in modo più potente di qualsiasi peccato" (n. 67).
15. Catechesi liturgica
La celebrazione del sacramento contiene una ricchezza divina trascendente, che non deve essere ridotta ad alcuni aspetti meramente umani come quelli sociali, festivi o sentimentali. Spetta ai sacri ministri e agli altri catechisti aprire le menti delle coppie a queste dimensioni sacramentali e missionarie - trascendenti e affascinanti - che esse intravedono appena. "Le coppie dovrebbero essere informate sulla valore straordinario come segno sacramentale che la loro vita matrimoniale acquisirà.Il rito nuziale diventerà un sacramento permanente di Cristo che ama la Chiesa. Gli sposi cristiani sono chiamati a diventare un sacramento permanente. icone viventi di Cristo Sposo. È il modo stesso in cui gli sposi vivono e si relazionano tra loro che deve rendere presente al mondo l'amore generoso e totale con cui Cristo ama la Chiesa e tutta l'umanità. Perché questa è la straordinaria testimonianza che tanti sposi cristiani danno al mondo: la loro capacità di donazione reciproca e di dedizione ai figli, la loro capacità di fedeltà, di pazienza, di perdono e di compassione sono tali da far intravedere che alla base del loro rapporto c'è una fonte soprannaturale, un qualcosa di piùinspiegabile in termini umani, che alimenta incessantemente il suo amore" (n. 68).
In tutto il processo di preparazione al matrimonio cristiano e, successivamente, nella vita matrimoniale, si deve contare sul potente e decisivo aiuto divino: "La consapevolezza di una nuova effusione dello Spirito Santo durante il rito nuziale, che, inserendosi in il dinamismo della grazia iniziato nel battesimo, dà una nuova connotazione alla carità divina infusa in noi dal battesimo stesso e che ora assume i tratti della carità divina. carità coniugale. È molto tempestivo invocare i santi/battiti cLa Chiesa si rivolge anche ai fedeli del nostro tempo, che hanno già vissuto l'esperienza di essere mariti e mogli, padri e madri, e anche ai santi intercessori, per valorizzare la dignità dello stato di vita matrimoniale nella comunità ecclesiale e per aiutarli a comprendere la bellezza e la potenza di questo sacramento nell'economia della salvezza" (n. 69).
16. Ritiro preliminare e confessione
Il documento insiste su una proposta molto appropriata: "Pochi giorni prima del matrimonio, un ritiro spirituale di uno o due giorni sarà molto utile. Sebbene ciò possa sembrare irrealistico, visti i numerosi impegni dovuti all'organizzazione del matrimonio, va detto che è proprio la frenesia delle tante incombenze pratiche legate all'imminente celebrazione che può distrarre gli sposi da ciò che conta di più: la celebrazione del sacramento e l'incontro con il Signore che viene a dimorare nel suo amore essere umano riempiendolo del suo amore divino. Se un vero e proprio ritiro non è possibile, un tempo di preghiera più breve (per esempio, un incontro serale, come una veglia di preghiera) può servire come alternativa" (n. 70). "Coinvolgere i genitori, i testimoni e i familiari più stretti. in un momento di preghiera prima del matrimonio, può essere un'occasione molto bella per tutti" (n. 72).
Aggiunge un altro elemento essenziale: andare al sacramento della penitenza per ricevere la grazia del matrimonio nel miglior modo possibile, puliti dal peccato grave e purificati anche dalle colpe minori. "Nel periodo che precede il matrimonio - nel contesto del già citato ritiro spirituale o della veglia di preghiera, o anche in un altro contesto - la celebrazione del sacramento della riconciliazione è di grande importanza" (n. 71). In questo modo possono ricevere degnamente la Santa Comunione - fonte di tutte le benedizioni divine e presenza dell'alleanza nuziale di Cristo - durante la celebrazione delle nozze.
17. Cura pastorale degli sposi
La terza fase di questo processo riguarda la la prima vita coniugale. Infatti, "il cammino catecumenale non si conclude con la celebrazione del matrimonio. Infatti, più che come un atto isolato, deve essere considerato come l'ingresso in uno stato permanente, che quindi richiede un apprendimento permanente specifico, fatto di riflessione, dialogo e sostegno da parte della Chiesa. Per questo è necessario accompagnare almeno i primi anni di vita matrimoniale e non lasciare gli sposi nella solitudine" (n. 74).
Non è bene che il matrimonio sia solo, possiamo dire, imitando l'affermazione del Signore nel racconto della creazione della donna. "Gli sposi devono essere consapevoli che la celebrazione del matrimonio è l'inizio di un percorso, e che la coppia è ancora una progetto apertonon un'opera finita" (n. 75). A tal fine, "si proporrà coppie la continuazione del cammino catecumenale, con incontri regolari" (n. 76). Nella nostra società, con una mentalità così contraria alla vera antropologia del matrimonio, è molto necessario che le coppie di sposi trovino la compagnia della comunità cristiana che rafforza e sostiene le motivazioni del loro cammino.
Spesso accade che l'attenzione delle giovani coppie si concentri sulla necessità di guadagnare e sui figli, trascurando la qualità del rapporto reciproco e dimenticando la presenza di Dio nel loro amore. "Vale la pena di aiutare le giovani coppie a conoscere come trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e abbracciare la grazia di Dio" (n. 77).
18. Vivere il dono
Il documento ricorda come il significato del sacramento debba essere dispiegato in tutta la sua bellezza: "questo è un momento opportuno per una vera e propria mistagogia matrimoniale, cioè un'introduzione al mistero. Ripercorrere i diversi momenti del rito nuziale, si potrebbe approfondire il suo ricco significato simbolico e spirituale e le sue conseguenze concrete nella vita matrimoniale: il consenso scambiato (la volontà di unirsi, e non un sentimento passeggero, alla base del matrimonio, volontà che deve essere sempre rafforzata); la benedizione dei segni che ricordano il matrimonio, ad esempio gli anelli (la promessa di fedeltà che deve essere sempre rinnovata); la solenne benedizione degli sposi (la grazia di Dio che scende sul rapporto umano, lo assume e lo santifica, alla quale dobbiamo sempre essere aperti); il ricordo del matrimonio nella preghiera eucaristica (immergere sempre l'amore coniugale nel mistero pasquale di Cristo per rinvigorirlo e renderlo sempre più profondo)" (n. 77).
In definitiva, nella catechesi matrimoniale mistagogica, come in quella battesimale, l'invito è: Diventa ciò che sei! Ora siete una coppia sposata, quindi vivete sempre più come una coppia sposata! Il Signore ha benedetto e riempito di grazia la vostra unione, quindi!fate fruttificare questa grazia!
19. Nuovi temi e interessi
Fin dall'inizio della vita matrimoniale, è importante ricevere una aiuto per il calcestruzzo vivere la relazione interpersonale con serenità. Ci sono molte cose nuove da imparare: "accettare la diversità dell'altro che si manifesta immediatamente; non avere aspettative irrealistiche sulla vita insieme e vederla come un percorso di crescita; gestire i conflitti che inevitabilmente sorgono; conoscere le diverse fasi attraverso cui passa ogni relazione d'amore; dialogare per cercare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle della coppia e della famiglia; acquisire sane abitudini quotidiane; stabilire fin dall'inizio un rapporto corretto con le famiglie d'origine; iniziare a coltivare una spiritualità coniugale condivisa (n. 78).
C'è molti aspetti della vita coniugale e familiare che possono essere oggetto di dialogo e catechesi negli ultimi anni. "È essenziale, ad esempio, educare le coppie sul delicato tema della sessualità all'interno del matrimonio. e le questioni correlate, cioè la trasmissione della vita e la regolamentazione delle nascite, e su altre questioni morali e bioetiche. Un altro ambito da non dimenticare è quello dell'educazione umana e cristiana dei figli, che costituisce una grave responsabilità per i genitori e su cui le coppie di sposi devono essere sensibilizzate e adeguatamente formate" (n. 79). L'insegnamento della Chiesa offre ai coniugi un tesoro di saggezza sulle varie questioni della vita coniugale e familiare.
Questi primi anni di matrimonio sono un "fase di apprendimento in cui la vicinanza e i suggerimenti concreti di coppie sposate matureche condividono con i più giovani ciò che hanno imparato lungo il cammino, saranno di grande aiuto" (n. 80).
20. Cura pastorale del collegamento e risorse varie
La pastorale del matrimonio sarà prima di tutto "una pastorale del legameAiuterà le coppie, ogni volta che si troveranno di fronte a nuove difficoltà, ad avere a cuore, prima di tutto, la difesa e il consolidamento dell'unione coniugale, per il loro bene e per quello dei loro figli" (n. 81). "È fondamentale incentrare il cammino della coppia sull'incontro con Cristo: la coppia ha bisogno di incontrare continuamente Cristo. e nutriti dalla sua presenza" (n. 82). Egli è il modello, la fonte e il sostegno della fedeltà promessa: solo con la sua grazia, nella comunione ecclesiale, si può rafforzare la comunione del "noi" coniugale.
La cura costante e permanente della Chiesa nei confronti delle coppie di sposi può essere attuata attraverso vari mezzi di comunicazione pastorale: "ascolto della Parola di Dio; incontri di riflessione su temi di attualità riguardanti la vita coniugale e familiare; partecipazione delle coppie di sposi a celebrazioni liturgiche appositamente pensate per loro; ritiri spirituali regolari per le coppie di sposi; adorazione eucaristica organizzata per le coppie di sposi; conversazione e accompagnamento spirituale; partecipazione a gruppi familiari per condividere esperienze con altre famiglie; partecipazione ad attività caritative e missionarie". Per i coniugi è necessario sviluppare una vera spiritualità coniugale per alimentare e sostenere lo specifico cammino di santità che seguono nella vita matrimoniale" (n. 83).
Questa spiritualità comprende la covocazione coniugale, la vita e l'impegno per la santità dei laici, nonché l'evangelizzazione della cultura familiare. Con lo sviluppo dell'identità coniugale, "il senso della missioneche scaturisce dal sacramento, può crescere. È opportuno invitare le coppie di sposi a coinvolgersi nella pastorale ordinaria della famiglia nelle loro parrocchie o in altre realtà ecclesiali" (n. 84).
In breve, il obiettivi di accompagnamento nei primi anni di vita matrimoniale sono: "a) presentare, in una catechesi matrimoniale mistagogica, le conseguenze spirituali ed esistenziali del sacramento celebrato nella vita concreta; b) aiutare le coppie, fin dall'inizio, a stabilire la relazione interpersonale nel modo giusto; c) approfondire i temi della sessualità nella vita matrimoniale, della trasmissione della vita e dell'educazione dei figli"; d) infondere nelle coppie di sposi la ferma volontà di difendere il vincolo matrimoniale in ogni situazione di crisi che possa presentarsi; e) proporre l'incontro con Cristo come fonte indispensabile per rinnovare la grazia coniugale e per acquisire una spiritualità coniugale; f) richiamare il significato della missione specifica dei matrimoni cristiani" (n. 85).
21. Accompagnare in situazioni coniugali difficili
Infine, si considera l'accompagnamento ecclesiale delle coppie sposate in situazioni di crisi. "Nella storia di ogni matrimonio ci possono essere momenti in cui la comunione coniugale diminuisce e i coniugi si trovano in periodi, a volte lunghi, di sofferenza, di fatica e di incomprensione, attraversando vere e proprie crisi coniugali. Fanno parte della storia delle famiglie: sono fasi che, se superate, possono aiutare la coppia a essere felice in modo nuovo, sulla base delle possibilità che una nuova tappa apre, facendo maturare ancora di più il vino dell'unione. Tuttavia, per evitare che la situazione di crisi diventi irrimediabile, è consigliabile che la parrocchia o la comunità abbiano un servizio pastorale per l'accompagnamento di coppie in crisi" (n. 87). Il consultori familiari (COF) sono un riferimento fondamentale a questo proposito.
In effetti, l'esperienza dimostra che in situazioni difficili o critiche, la maggior parte delle persone non si rivolge all'accompagnamento pastorale, forse "perché non lo sente comprensivo, vicino, realistico, incarnato". Ecco perché, "È importante che - oltre al pastore - siano i coniugi, soprattutto quelli che hanno vissuto una crisi dopo averla superata, a diventare accompagnare le coppie in difficoltà o già divisi" (n. 88). "Si tratta di garantire non solo un accompagnamento psicologico, ma anche spiritualerecuperare, attraverso un cammino mistagogico graduale e personalizzato e i sacramenti, il significato profondo del legame e la consapevolezza della presenza di Cristo tra i coniugi" (n. 90). Questi tutor o mentori La consulenza matrimoniale può essere un aiuto decisivo per salvare e santificare soprattutto chi è in difficoltà.
Si osserva che, purtroppo, "ci sono situazioni in cui la separazione è inevitabile. In questi casi, è indispensabile un discernimento particolare per accompagnamento pastorale i separati, i divorziati, gli abbandonati. Il dolore di coloro che hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio o l'abbandono, o che sono stati costretti a interrompere la convivenza a causa dei maltrattamenti subiti dal coniuge, deve essere particolarmente accolto e apprezzato. Perdonare l'ingiustizia subita non è facile, ma è un percorso che la grazia rende possibile. Da qui la necessità di un pastorale di riconciliazione e mediazioneattraverso centri di ascolto specializzati da istituire nelle diocesi" (n. 93).
Si ritiene che "le persone divorziate che non si sono risposate - che spesso sono testimoni di fedeltà coniugale- trovare nell'Eucaristia il nutrimento che li sostiene nella loro condizione. La comunità locale e i pastori dovrebbero accompagnare queste persone con sollecitudine, soprattutto quando ci sono bambini o quando la loro situazione di povertà è grave". (n. 94).
22. Costruire la famiglia sulla roccia
La Conclusione ricorda che questo documento risponde al profondo "desiderio di offrire alle coppie una migliore e più approfondita preparazione al matrimonio, attraverso una itinerario sufficientemente ampio, ispirato al catecumenato battesimaleL'obiettivo è quello di fornire loro un'adeguata formazione alla vita matrimoniale cristiana, basata su un'esperienza di fede e di incontro con Gesù, che non si limiti, quindi, a pochi incontri in prossimità della celebrazione, ma che permetta loro di percepire la carattere quasi permanente della pastorale della vita matrimoniale che la Chiesa intende realizzare". Tutta la comunità ecclesiale deve essere coinvolta nella missione di accompagnamento delle coppie. Nei compiti di formazione e di aggiornamento è necessario lavorare con senso di complementarità e corresponsabilità.
In questo percorso di formazione integrale, "non solo il metodo del catechesima anche il dialogo con i partner, il incontri individuale, i momenti liturgici di preghiera e celebrazione sacramenti, riti, ritiri e interazione con l'intera comunità ecclesiale". Nel corso di questo processo, si deve tenere conto della carattere cherigmatico della proposta cristiana, cioè la sua forza, bellezza e novità. Il "sacramento del matrimonio è presentato come una buone notizieÈ un dono di Dio alle coppie che desiderano vivere pienamente il loro amore". Evitando le dicotomie, "il percorso di crescita umana e il processo di crescita spirituale sono sempre tenuti insieme".
La formazione delle coppie di sposi cristiani deve essere "inserita nella realtà concreta di oggi e non deve temere di affrontare temi e questioni che rappresentano sfide sociali e culturali", tra cui la "... necessità di un "approccio olistico" al matrimonio e la necessità di "un approccio olistico" al matrimonio.formazione della coscienza morale personale e la formulazione di un progetto di vita familiare".
L'accompagnamento pastorale deve essere personalizzatobasato principalmente sulla testimonianza degli accompagnatori e delle altre coppie coinvolte nel viaggio. In ogni caso, si tratta di portare ad una seria discernimento L'obiettivo è quello di preparare le coppie alla celebrazione del matrimonio e alla vita matrimoniale come frutto di una decisione consapevole, libera e gioiosa. Mentre prepara le coppie al sacramento del matrimonio, le prepara anche al sacramento del matrimonio. iniziazione alla vita ecclesiale e li aiuta a trovare nella Chiesa il luogo dove coltivare il vincolo matrimoniale e continuare a crescere per tutta la vita nella loro vocazione e nel servizio agli altri, sviluppando così pienamente la loro identità sponsale e la loro missione ecclesiale. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione all'accompagnamento delle coppie sposate in crisi.
Offrendo alle nuove generazioni percorsi di crescita catecumenale verso il matrimonio, rispondiamo a uno dei bisogni più urgenti della società di oggi: accompagnare i giovani verso la piena realizzazione di quello che rimane uno dei loro più grandi "sogni" e uno dei loro principali obiettivi nella vita, ovvero stabilire un rapporto solido con la persona che amano e costruire un matrimonio santo ed evangelizzante sulla base del sacramento.
"Abba, Padre caro". 17a domenica del Tempo Ordinario
Andrea Mardegan commenta le letture della XVII domenica del Tempo Ordinario e Luis Herrera tiene una breve omelia video.
Commento alle letture di domenica 17
La ricostruzione di Luca del contesto in cui la preghiera di Gesù al Padre, che da sempre definisce i cristiani, viene consegnata ai suoi discepoli, è molto realistica.
Gesù si mette in disparte a pregare, come il lettore del Vangelo di Luca è abituato a vedere: "Era solito ritirarsi in campagna e dedicarsi alla preghiera". (5, 16); "In quei giorni Gesù si recò sul monte a pregare e passò la notte a pregare Dio". (6, 12); "Gesù stava pregando da solo" (9:18); "prese Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare" (9:18). (9, 28).
La persona che vi chiede della preghiera è "uno dei suoi discepolianche se la sua richiesta sembra essere fatta a nome di tutti: "Insegnaci a pregare".. La motivazione data corrisponde all'usanza del tempo: ogni gruppo aveva il suo modo di pregare, i discepoli di Giovanni, gli Esseni, i Farisei.
Ma deve essere stato ancora più affascinante per i discepoli vedere Gesù pregare con un'insolita familiarità con Dio. E desideravano poter attingere a questo stesso modo di pregare. Per scoprire il suo segreto.
Infatti, in quella parola, "Padre", è racchiuso il segreto che i discepoli volevano scoprire, e da quel momento la Chiesa nascente iniziò a imitare Gesù nel suo rapporto con il Padre. G. Ravasi scrive: "A differenza di Matteo, che usa la forma più giudaizzante e meno originale 'Padre nostro', Luca ha solo 'Padre', tradotto dall'originale aramaico usato da Gesù, Abbà, 'caro padre', 'papà'. E in questo non c'è solo l'ipsissima vox Iesu, c'è l'eco di una parola storica di Gesù, come ha mostrato lo studioso tedesco J. Jeremias, ma anche la voce coraggiosa della Chiesa che scopre Dio vicinissimo e "umano" in un rapporto assolutamente nuovo e inedito: "Siamo davanti a qualcosa di nuovo e inedito, che supera i limiti del giudaismo". Qui vediamo chi era il Gesù storico: l'uomo che aveva il potere di rivolgersi a Dio come Abbà, e che ha reso peccatori e pubblicani partecipi del regno, autorizzandoli a ripetere quest'unica parola: 'Abbà, Padre caro'" (Geremia)..
La parabola che segue immediatamente offre una nuova sfumatura del clima della relazione con il Padre, quella dell'amicizia. Ci sono tre amici. Uno arriva all'improvviso la sera da un viaggio, senza nulla, e chiede ospitalità al suo amico, che non ha nulla per sfamarlo, e si rivolge a un terzo amico per chiedergli in prestito tre pani.
In poche parole Gesù racconta tutta la vivacità del rapporto fraterno, che è anche amicizia nella Chiesa, e del rapporto filiale, che è anche amicizia con Dio, che solo può aiutare in molte questioni in cui intercediamo per i nostri fratelli. È l'unico che può dare lo Spirito Santo.
L'omelia sulle letture della domenica 17
Il sacerdote Luis Herrera Campo offre il suo nanomiliauna breve riflessione di un minuto per queste letture.
Cattolici e sciiti affrontano il futuro, giornate di dialogo a Roma
Autorità sciite di diversi Paesi del Medio Oriente si sono riunite a Roma insieme a studiosi e rappresentanti della Chiesa cattolica in un incontro promosso dalla Comunità di Sant'Egidio.
Autorità sciite di diversi Paesi del Medio Oriente insieme a studiosi e rappresentanti della Chiesa cattolica, come i cardinali Louis Raphaël I Sako, patriarca di Baghdad dei Caldei, e José Tolentino De Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
La conferenza del 13 e 14 luglio, che si è aperta con le relazioni di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, e di Jawad Al-Khoei, segretario generale dell'Istituto Imam Al-Khoei, si è basata sulla proposta di rafforzare i fili del dialogo tra i due mondi, cattolico e sciita, dopo lo storico incontro tra Papa Francesco e il Grande Ayatollah Al-Sistani a Najaf nel marzo 2021. Ecco cosa ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in occasione di questo evento: "Il Santo Padre ha incontrato questa mattina a Najaf il Grande Ayatollah Sayyid Ali Husaini Sistani.
Durante la visita di cortesia, durata circa 45 minuti, il Santo Padre ha sottolineato l'importanza della collaborazione e dell'amicizia tra le comunità religiose affinché, coltivando il rispetto reciproco e il dialogo, possano contribuire al bene dell'Iraq, della regione e dell'intera umanità.
L'incontro è stato l'occasione per il Papa di ringraziare il Grande Ayatollah Al-Sistani per aver, insieme alla comunità sciita e di fronte alle violenze e alle grandi difficoltà degli ultimi anni, alzato la voce in difesa dei più deboli e dei perseguitati, affermando la sacralità della vita umana e l'importanza dell'unità del popolo iracheno. Nel congedarsi dal Grande Ayatollah, il Santo Padre ha ribadito la sua preghiera a Dio, Creatore di tutto, per un futuro di pace e fratellanza per l'amata terra dell'Iraq, per il Medio Oriente e per il mondo intero".
Quattro sessioni, dedicate ai valori umani condivisi, alla responsabilità nella comunità religiosa, ai modelli di pensiero e all'incontro tra generazioni: la base della comprensione reciproca tra cattolici e sciiti. Sullo sfondo, l'impegno per la pace, il rapporto con la politica e lo Stato, la vita spirituale, il valore della famiglia, il ruolo dei credenti nella società contemporanea.
Con l'obiettivo di offrire una via di dialogo non astratta ma praticabile, capace di aprire nuovi orizzonti per il futuro in un momento storico delicato nei rapporti tra Cristianesimo e Islam, come tra Occidente e Oriente.
Da qui l'idea - proposta da Jawad Al-Khoei e condivisa da Andrea Riccardi e dal cardinale Louis Sako, patriarca di Baghdad - di creare una commissione permanente tra cattolici e sciiti per affrontare questioni di interesse comune in uno spirito di cooperazione e fratellanza. Una seconda proposta operativa riguarda la convocazione di una nuova riunione in Iraq, a Najafa.
Questa iniziativa ha registrato numerose posizioni, che vale la pena ricordare, anche se in rapida revisione.
Zaid Bahr Al-Uloom, direttore dell'Accademia Al-Balagha, Istituto Imam Al-Khoei, ha osservato che "il dialogo non significa fusione di religioni, ma comprensione reciproca" e che "la guerra religiosa mette musulmani e cristiani nella stessa trincea".
Per questo dobbiamo costruire ponti e abbattere muri", afferma Andrea Riccardi, appena tornato "da un lungo viaggio in Africa". Molti Paesi stanno subendo gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun Paese è un'isola. Il mondo globale ha bisogno di dialogo per trovare un'anima che non ha.
Sulla stessa linea, Vittorio Ianari (Sant'Egidio), che ha presieduto l'apertura dei lavori, ha invocato il dialogo e la cultura, ingredienti fondamentali per aprire una prospettiva di futuro in un mondo travagliato.
Con l'audacia di proporre la "via semplice e radicale del Buon Samaritano", secondo le parole di Marco Impagliazzo, storico, presidente della Comunità di Sant'Egidio: è la via che "punta alla fratellanza universale come scelta senza alternative".
Non è quindi possibile seguire imperterriti i passi che ci hanno fatto ammalare, che hanno fatto ammalare il mondo. È tempo di prendere strade diverse. È tempo di assumere la stessa logica che sottolinea il testo evangelico, la logica per cui non importa quale nazione o tradizione io sono e voi siete".
La Chiesa di Francesco", ha concluso Impagliazzo, "non accetta di ridursi, di chiudersi in se stessa, di essere una comunità senza sogni. Continua a parlare perché il mondo sia diverso, perché il mondo abbia un futuro.
Il cardinale Louis Sako, patriarca di Baghdad, ha proposto un appello congiunto per la pace in Ucraina da parte di cattolici e sciiti, auspicando una cooperazione più proficua.
Il Cardinale Tolentino, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ha sottolineato l'importanza dell'ospitalità come "luogo teologico e umano che unisce profondamente le religioni, tutte rispondenti al vuoto e allo smarrimento dell'uomo". Non assaggiamo questo dono. I testi sacri", ha aggiunto, presentano costantemente "un modello predisposto alla diversità, con una visione sorprendentemente nuova".
Un'ambivalenza rivolta al mondo ebraico e greco: "l'apertura, l'accoglienza, l'ospitalità" dimostrano che il cristianesimo "è stato plurale fin dall'inizio". Le riflessioni sono state al centro anche dell'intervento di Ismail Al-Khaliq, direttore della Fondazione al-Khoei di Parigi: "Le religioni abramitiche che si muovono verso la libertà mostrano come liberarsi dalla schiavitù e dal peccato".
E sulla lotta all'estremismo e al terrorismo, Al-Khaliq ha raccontato l'esperienza francese che, "in nome di Maria", ha visto incontri interreligiosi in dieci chiese, moschee e sale pubbliche, l'ultimo dei quali a Saint Sulpice con 30 gruppi e comunità. Un percorso che sarà replicato in altre realtà.
Il professore libanese Mahdi Al-Amin, citando la dichiarazione di Nostra AetateHa affermato che è necessaria una visione coranica "che riconosca l'alterità religiosa e stabilisca le basi per il dialogo con essa". Immaginare spazi e modi di stabilire relazioni religiose e umane che possano sviluppare un dialogo che riconosca l'altro". Ha riconosciuto che il Papa ha compiuto passi importanti, ma ha auspicato che venga redatto un documento con gli sciiti, sulla falsariga di quello che è stato redatto per la Chiesa. Dichiarazione di Abu Dhabi firmato con Al-Tayyeb.
Tra i temi principali della conferenza, quello della libertà ha accompagnato le riflessioni del professor Armand Puig, rettore dell'Ateneo Sant Pacià di Barcellona, che ha ricordato che "Dio sceglie di liberare l'uomo perché ha fede in lui". Ha creduto in noi prima che noi credessimo in Lui.
L'inizio del XXI secolo sembra essere una continua scia di enormi fallimenti. "Ma non è questa la storia che Dio ha progettato per i suoi figli, non è questo il sogno di pace che i figli di Abramo vogliono condividere. Il futuro dell'umanità non può essere una condanna". È necessario riflettere "su un modello di pensiero per tradurlo nella vita concreta".
Per quanto riguarda i migranti, Daniela Pompei, responsabile dei servizi di Sant'Egidio per i migranti, ha ricordato la fruttuosa esperienza dei corridoi umanitari, cruciali per garantire accoglienza e integrazione.
Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nell'affrontare il tema dell'assistenza agli anziani in una società sempre più "vecchia", ha fatto riferimento alla commissione commissionata dal governo italiano, da lui presieduta, che ha elaborato un documento, avallato dal premier Draghi, sui diritti degli anziani e sui doveri della società nei loro confronti. Con enfasi su: il diritto alla protezione e alla dignità; la cura responsabile e il rispetto della volontà degli anziani; il diritto a una vita di relazione e il dovere di non abbandonarli. E l'importanza della vita spirituale nell'ultima fase della vita, in cui le religioni giocano un ruolo decisivo.
Dal dialogo tra cattolici e sciiti, di cui l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio è espressione, scaturisce una forte condanna del terrorismo e dell'estremismo religioso, fenomeni che possono essere definiti come il risultato di una comprensione distorta della religione, frutto dell'ignoranza degli insegnamenti della religione stessa, oltre che dell'ignoranza dell'altro.
Con la necessità che le religioni non rimangano isolate, ma dialoghino nell'incontro e nella visita, attraverso i quali le pluralità possono comprendersi meglio e contribuire a un mondo più pacifico.
Guardate il cielo e vedrete
Che la contemplazione delle immagini di Webb ci aiuti a non diventare arroganti, a non sbagliarci sulla condizione umana e a capire che è proprio perché siamo così piccoli e fragili che siamo così preziosi.
Traduzione dell'articolo in inglese
Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato lunedì alla Casa Bianca l'immagine a infrarossi più profonda e nitida mai scattata dell'universo lontano.
La fotografia mostra l'ammasso di galassie SMACS 0723 come appariva 4,6 miliardi di anni fa (questo è il tempo impiegato dalla luce per raggiungere le lenti del James Webb Space Telescope che l'ha catturata).
È impressionante vedere come centinaia di galassie, ognuna con le sue centinaia di migliaia di stelle, si comprimano per entrare nell'immagine a colori.
Come spiega la NASA, l'inquadratura cattura una porzione di universo piccola come una persona sulla terra vedrebbe un granello di sabbia tenuto a distanza di un braccio. Quanto c'è ancora da esplorare!
Con la consegna delle prime immagini, Webb ha dimostrato di essere il principale osservatorio scientifico spaziale del mondo, subentrando al leggendario telescopio Hubble.
Questo meraviglioso dispositivo è frutto della collaborazione di agenzie spaziali americane, europee e canadesi, ma il Presidente Biden si è preso la libertà di anticipare di un giorno la data di rilascio concordata con i partner del progetto per mettere in gioco la sua medaglia, affermando: "Queste immagini ricorderanno al mondo che l'America può fare grandi cose e ricorderanno al popolo americano, soprattutto ai nostri figli, che nulla è al di là delle nostre capacità".
La frase è particolarmente scioccante quando, solo pochi giorni prima, il presidente aveva firmato un ordine esecutivo per "negare ai bambini non nati il loro più basilare diritto umano e civile, il diritto alla vita", come avrebbe affermato l'arcivescovo di Baltimora e presidente della Commissione per le attività a favore della vita della Conferenza episcopale statunitense.
Naturalmente, si tratta di due questioni molto diverse e può sembrare grossolano confonderle, ma, in fondo, entrambe le azioni rivelano l'autosufficienza, non di un individuo, ma di un sistema che crede davvero che "non c'è nulla al di là delle nostre capacità".
L'uomo orgoglioso non indietreggia di fronte all'evidenza della vita umana non ancora nata, nemmeno di fronte al mistero rabbrividente dello spazio insondabile. Se io sono Dio, chi può impedirmi di fare ciò che voglio?
Era l'inizio degli anni '80 quando ebbi la fortuna di vedere una delle serie scientifiche più famose della storia: Cosmos di Carl Sagan. Ripeto sempre che, paradossalmente, questa magnifica opera di un agnostico convinto e militante è stata fondamentale per la mia vita di fede.
Ricordo che rimasi estasiato contemplando le immagini del nostro universo e ascoltando le sue chiare spiegazioni che mi fecero ammirare la bellezza della natura e allo stesso tempo il genio dello spirito umano che è in grado di comprenderla e darle un senso.
Erano gli anni della guerra fredda, quando la paura di una bomba nucleare incombeva sul subconscio collettivo. Film come "The Day After" e "War Games" ci hanno messo di fronte alla cruda realtà: la vita sulla terra è appesa all'arroganza di quattro persone potenti o a un computer mal configurato.
Nella mia coscienza di bambino, non riuscivo a trovare una spiegazione al doppio aspetto dell'essere umano: qualcuno che è capace del meglio e del peggio.
Deluso, ho trovato la chiave nella catechesi della Prima Comunione (quegli anni meravigliosi), quando abbiamo cantato "Pensavo che l'uomo fosse grande per la sua potenza, grande per la sua conoscenza, grande per il suo coraggio, pensavo che l'uomo fosse grande e mi sbagliavo, perché solo Dio è grande".
Ho scoperto allora, e dopo 40 anni di esperienza continuo a confermarlo, che ogni volta che gli esseri umani cercano di prendere il posto di Dio si schiantano miseramente e che le persone veramente grandi sono quelle che, pur facendo del loro meglio, riconoscono di non sapere tutto, di non poter fare tutto.
Sono coloro che, contemplando l'immensità del cosmo, riescono a vedere la sua assoluta insignificanza spazio-temporale e, quindi, il valore assoluto di ogni abitante del pianeta Terra.
In questi anni '20 del XXI secolo, quando le valigette nucleari sono state rispolverate, abbiamo bisogno di uomini e donne capaci di commuoversi per il valore inalienabile di ogni vita umana, persone che usino tutte le loro capacità, non a favore della morte, ma a favore della vita.
Che la contemplazione delle immagini di Webb ci aiuti a non diventare presuntuosi, a non sbagliarci sulla condizione umana e a capire che è proprio perché siamo così piccoli e fragili che siamo così preziosi.
Come un giocattolo di vetro.
Giornalista. Laurea in Scienze della Comunicazione e laurea in Scienze Religiose. Lavora nella Delegazione diocesana dei media di Malaga. I suoi numerosi "thread" su Twitter sulla fede e sulla vita quotidiana sono molto popolari.
Borja BarraganLa Chiesa investe affinché questi beni portino frutti che possano essere utilizzati per aiutare le persone in difficoltà".
Fondatore di Altum Investimento fedele, una società di consulenza finanziaria che segue i criteri del magistero della Chiesa cattolica in ogni sua decisione, Borja Barragán lavora per eliminare la dicotomia tra la redditività di un patrimonio e il vivere pienamente la fede.
Sposato e padre di sette figli che considera "il suo miglior investimento", Borja Barragán lavora da 19 anni nell'investment banking. Nel suo curriculum figurano multinazionali come Bank of America Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs e Julius Baer.

Ha approfondito la sua formazione in Business Administration and Management (ICADE) presso l'Università di Harvard (Boston) nel Sustainable Finance & Investments Program; ha inoltre completato il Master in Pastorale Familiare presso l'Istituto Giovanni Paolo II; ha studiato la Dottrina Sociale della Chiesa presso l'Angelicum (Roma); infine, ha approfondito la gestione delle dotazioni e dei fondi istituzionali presso lo IESE.
Nel 2017 ha fondato Altum Investimento fedele, una società di consulenza finanziaria che segue i criteri del magistero della Chiesa cattolica in ogni sua decisione. Cerca di fare in modo che, come dice lui stesso, un cristiano non debba scegliere tra la redditività dei suoi beni e il vivere appieno la sua fede.
Perché abbiamo paura di parlare di denaro e di metterlo in relazione con Dio e con la nostra fede nel suo amore?
- Credo che le ragioni siano due: da un lato, viviamo troppo legati ai beni materiali. La nostra sicurezza si basa sempre più sulle cose che possediamo, lasciando sempre meno spazio alla fiducia in Dio. Provvedere per il futuro, per i nostri figli, per quando "le cose vanno male" è sintomo di buona amministrazione, ma quando tutta la fiducia è riposta nell'"avere", è lì che Dio non trova posto ed è scomodo poter mettere in relazione il materiale con Dio.
D'altra parte, la società odierna separa il trascendentale dall'ordinario e il denaro tende a essere visto come qualcosa di tremendamente "ordinario" e lontano dallo spirituale. Ma questa separazione ha senso? Se per il cattolico "tutto è dono" e questo dono viene da Dio, il compito di amministrarlo correttamente si pone di fronte al dono ricevuto (che sia un dono materiale o spirituale). Non per imposizione, ma per reciprocità, volendo corrispondere all'amore ricevuto con i doni, anche con l'amore, attraverso un'amministrazione responsabile e coerente.
È cristiano risparmiare, quando tante persone sono nel bisogno? Non sarebbe meglio affidarsi alla Provvidenza?
- Riconosco che San Tommaso d'Aquino è uno degli autori che mi sfidano di più. Nella Summa Theologica afferma quanto segue a proposito della Provvidenza: "Dio ha disposto alcune cose secondo la sua Provvidenza per il sostentamento corporeo dell'uomo", in modo che "i beni sono soggetti all'uomo, affinché egli li usi per soddisfare le sue necessità".
Pertanto, partiamo dalla chiara premessa che l'uomo ha bisogno di beni materiali per coprire i suoi bisogni presenti e futuri, quindi provvedere al futuro attraverso il risparmio non dovrebbe essere un conflitto per il cristiano.
Il discernimento (e qui entra in gioco la libertà di ciascuno di decidere cosa è appropriato per ogni momento) entra in gioco nel momento in cui è necessario decidere tra ciò che è necessario e ciò che è superfluo. Se l'atto di risparmiare, di provvedere al futuro, è ordinato, secondo lo stato e la condizione di ciascuno, non dovrebbe essere un problema.
Se invece è disordinato, nel senso che il risparmio diventa ossessivo, accaparrandosi, cercando di prevenire tutte le possibili eventualità, lasciando da parte la Provvidenza, allora forse è il caso di rivedere questo modo di risparmiare.
La Chiesa può investire denaro con tanti bisogni urgenti nel mondo?
- Come abbiamo detto prima, investire in modo ordinato è perfettamente lecito per qualsiasi entità, sia essa la Chiesa o una famiglia. Nel caso specifico della Chiesa, ciò che abbiamo detto sul superfluo assume una maggiore rilevanza. Se la Chiesa investe, non è per accumulare o appropriarsi di beni, ma perché questi beni portino frutto e questo frutto possa essere utilizzato per le necessità degli altri.
Credo sia indubbio che l'investimento che la Chiesa può fare cercherà sempre un perfetto equilibrio tra i due aspetti insiti nel risparmio. Da un lato, avere un patrimonio che copra ciò che è necessario per il proprio sostentamento (non dimentichiamo che senza questo non ci sarebbe nulla - né per la Chiesa, né per le esigenze di culto, pastorali e di altro genere) e dall'altro combinare la copertura ciò che è necessario con l'aiuto di il superfluo per soddisfare le esigenze reciproche.
Penso che un buon esercizio pratico sarebbe quello di visitare il sito web di trasparenza della Conferenza episcopale capire come vengono spesi i soldi e l'equilibrio che si raggiunge per il sostegno della chiesa diocesana stessa, occupandosi allo stesso tempo di ogni tipo di attività pastorale e assistenziale.
Gli investimenti sono un buon modo per risparmiare?
- I beni non sono buoni in sé, ma per il bene che si può ottenere con essi. Destinare una parte dei risparmi che non saranno necessari a breve termine per generare un rendimento rientra nell'obiettivo di preservare il capitale per le esigenze future; è un sano esercizio di gestione responsabile.
In realtà, si tratta di un esercizio che ovviamente non si applica solo a una madre che gestisce i propri risparmi domestici, ma anche la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA) ha riesumato un termine usato nel diritto canonico, ovvero il concetto di patrimonio stabile. Molto brevemente, questo patrimonio stabile sarebbe il patrimonio minimo di cui un istituto religioso avrebbe bisogno per poter garantire e sostenere il proprio carisma e la propria missione.
Le ultime indicazioni della CIVCSVA prevedono la possibilità che parte di questa ricchezza possa essere investita (in beni mobili o immobili) non solo come forma di risparmio (per il futuro) ma anche come corretta gestione di questa ricchezza stabile.
Gli investimenti sono per i ricchi?
- Oggi la tecnologia consente a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, di investire. La domanda è se voglio che i miei investimenti siano coerenti con la mia fede o se voglio nascondere la testa sotto la sabbia per evitare domande scomode.
Da Altum abbiamo voluto fare la nostra parte creando l'App Altum. Si tratta di un'applicazione gratuita in cui gli utenti, indipendentemente dalla loro ricchezza, possono verificare prima di investire (o consumare) se le aziende a cui sono interessati sono in conflitto con la Dottrina sociale della Chiesa e per quale motivo.
Il primo è quello di evidenziare il fatto che il Investire con fedeltà è per tutti, indipendentemente dai propri risparmi.
Il secondo è quello di aiutare chiunque abbia una sensibilità cristiana a saper coniugare fede e coerenza negli investimenti (e nei consumi).
L'ultima è quella di incoraggiare i dirigenti e gli amministratori delegati a sapere come rispondere e adattare le loro politiche aziendali in modo che la dignità della persona (base della Dottrina sociale della Chiesa) sia sempre rispettata e che in nessun caso il fine giustifichi i mezzi.
Esistono investimenti buoni e cattivi o sono tutti uguali?
- Rispondo alla domanda comprendendo che come "buoni" poniamo l'accento sulla ricerca del bene e non sull'alta redditività. San Giovanni Paolo II lo ha detto molto chiaramente nella Centessimus Annus: "La scelta di investire in un luogo e non in un altro è sempre una scelta morale e culturale". Se nella vita ci sono atti buoni (aiutare i malati), atti cattivi (uccidere gli innocenti) e atti neutri (canticchiare una canzone), lo stesso vale per l'atto concreto di investire.
È curioso che per alcuni aspetti della nostra vita ci preoccupiamo molto di scoprire come spendiamo i nostri soldi (ad esempio, analizzando se le uova che compriamo al supermercato sono di allevamento all'aperto o se le noci sono biologiche) e che per l'atto di investire non ci fermiamo quasi mai a pensare se l'attività svolta da un'azienda è lecita o se le pratiche filantropiche sviluppate dall'azienda sono in contrasto con la Dottrina sociale della Chiesa (è impressionante quante entità sostengono costantemente l'aborto, per citare solo un esempio).
La ragion d'essere di Altum è proprio questa: accompagnare l'investitore cristiano affinché non debba scegliere tra integrità e rendimento adeguato.
Influenziamo le grandi aziende del mondo, è una questione di soldi o di persone?
- Non ho dubbi: le persone sono quelle realmente in grado di influenzare e cambiare il mondo. Ma non è facile, perché di solito si tratta di nuotare controcorrente.
Benedetto XVI ha fatto spesso riferimento alla minoranze creative, cioè piccoli gruppi di persone che sono in grado di apportare cambiamenti culturali, in molti casi contro le masse. Alcuni esempi: oggi una manciata di tweets può indurre una società quotata in borsa a ritirare una campagna pubblicitaria.
Le Piccole Sorelle dei Poveri negli Stati Uniti hanno ottenuto dalla Corte Suprema il riconoscimento della loro obiezione di coscienza a praticare aborti o a fornire contraccettivi nei loro ospedali. Un consorzio di congregazioni americane si è unito 50 anni fa per influenzare le decisioni delle aziende in cui erano investite - oggi influenzano più di 4 miliardi di dollari.
Pertanto, ribadisco la mia precedente affermazione: sono le persone che influenzano il mondo. Il denaro è solo un mezzo e non un fine. Sta a noi non scendere a patti con l'ordine costituito e avere il coraggio di allargare i nostri orizzonti. Nel nostro caso specifico, per poter fare un investimento coerente con la fede in Cristo.
Il Papa all'Angelus: "Approfittiamo delle vacanze per fermarci ad ascoltare Gesù".
Papa Francesco ha incoraggiato le persone a pregare e a leggere il Vangelo con più calma e attenzione durante le vacanze estive e ha chiesto di pregare per lo Sri Lanka, l'Ucraina e il prossimo viaggio in Canada.
Papa Francesco ha tenuto la tradizionale preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro questo pomeriggio a mezzogiorno. Nel pieno della stagione estiva, quando molte persone stanno già godendo delle loro vacanze, il Papa ha voluto ricordarci che questo è un buon momento per dedicare più tempo alla preghiera. Lo ha fatto prendendo spunto dal Vangelo di questa XVI domenica del Tempo Ordinario, che presenta "una vivace scena domestica", come l'ha definita il Papa, nella casa di Marta, Maria e Lazzaro.
Francesco ha voluto ricordarci che l'eccessiva occupazione, anche nelle cose buone, se non è fondata sulla preghiera "si riduce a stanchezza e agitazione per molte cose, si riduce a sterile attivismo".
Per questo, ha sottolineato il Papa, "Maria ha intuito che c'è una "parte buona" a cui dobbiamo dare il primo posto. Tutto il resto viene dopo, come un ruscello d'acqua che scorre dalla sorgente. E allora ci chiediamo: e qual è questa "parte buona"? È ascoltare le parole di Gesù".
Francesco ha voluto sottolineare che "la parola di Gesù non è astratta, è un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera dalle tenebre del male, soddisfa e infonde una gioia che non passa: la parola di Gesù è la parte buona, quella che Maria aveva scelto. È per questo che lo dà al primo posto: si ferma e ascolta. Il resto verrà dopo.
In linea con questo, il Papa ha sottolineato che una delle pratiche che l'estate, e il ritmo più lento del lavoro, possono favorire è quella di "fermarsi ad ascoltare Gesù". Oggi è sempre più difficile trovare momenti liberi per meditare. Per molte persone il ritmo di lavoro è frenetico ed estenuante. Il periodo estivo può essere prezioso anche per aprire il Vangelo e leggerlo lentamente, senza fretta, un brano al giorno, un piccolo brano del Vangelo".
Paesi in conflitto e preghiera per il Canada
Al termine della preghiera dell'Angelus, il Papa ha voluto, ancora una volta, ricordare il popolo dello Sri Lanka e ha implorato tutte "le parti a lavorare insieme per trovare una soluzione pacifica alla crisi attuale, a favore, in particolare, dei più poveri, nel rispetto dei diritti di tutti".
La crisi in Ucraina, che continua a soffrire per l'invasione russa, è stata anche oggetto dei saluti finali del Papa, che ha posto una domanda diretta: "Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontana i popoli, uccide la verità e il dialogo? Prego e spero che tutti gli attori internazionali si impegnino davvero per riprendere i negoziati, per non alimentare l'insensatezza della guerra".
Il Papa ha anche chiesto ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera nel suo prossimo viaggio in Canada, "un pellegrinaggio penitenziale" dove si recherà "in nome di Gesù per incontrare e abbracciare le popolazioni indigene". Purtroppo, in CanadaIn passato, molti cristiani, compresi alcuni membri di istituti religiosi, hanno contribuito a politiche di assimilazione culturale che, in modi diversi, hanno danneggiato gravemente le comunità native. Spero, con la grazia di Dio, di poter contribuire al percorso di guarigione e riconciliazione già intraprese".
Teresa FloresRead more : "L'America Latina ha un ambiente ostile alla libertà religiosa".
Il diritto alla libertà religiosa è riconosciuto nella maggior parte dei Paesi latinoamericani. Ma la libertà "non si limita alla sfera privata, ma trascende la sfera collettiva e pubblica, e ci sono impedimenti e minacce che minano il pieno esercizio di questo diritto", ha dichiarato a Omnes l'avvocato Teresa Flores, direttore dell'Osservatorio della libertà religiosa in America Latina (OLIRE).
"Nei Paesi con tendenze autoritarie, come in Nicaragua, la Chiesa è una delle poche, se non l'unica istituzione che gode di maggiore credibilità e, quindi, il suo livello di influenza tra la popolazione è visto come un pericolo per il controllo governativo", spiega in questa intervista l'avvocato Teresa Flores, direttore dell'Osservatorio per la libertà religiosa in America Latina (Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina).OLIRE), la cui missione è promuovere la libertà religiosa e rendere note le restrizioni a questo diritto nella regione.

In Nicaragua, "le violazioni della libertà religiosa per motivi politici si sono intensificate e il governo ha utilizzato diverse strategie per intimidire la voce dei leader religiosi, soprattutto cattolici.
L'espulsione delle Missionarie della Carità è solo un altro episodio di questa campagna di intimidazione e ritorsione", aggiunge.
A proposito, i missionari sono stati accolti in Costa Rica da mons. Salazar Mora, vescovo della diocesi di Tilarán-Liberia, ha dichiarato che è stato "un onore" riceverli.
Precisamente un mese e mezzo fa, IOPDAC Europe, il suo partner latinoamericano OLIRE e l'IIRF (Istituto Internazionale per la Libertà Religiosa) hanno presentato a Vienna un rapporto congiunto, basato su quattro studi condotti attraverso interviste personali a cristiani praticanti appartenenti a diversi settori della società, realizzate in due Paesi europei (Francia e Germania) e in due Paesi latinoamericani (Colombia e Messico). Alcune di queste idee sono già state discusse Martin Kugler in Omnes.
Ora, Omnes parla con Teresa FloresAvvocato dell'Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Perù), con un Master in Diritto Costituzionale e Diritti Umani dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perù) e un diploma in Studi Religiosi dell'Universidad Católica de Chile, ha lavorato anche a Mendoza (Argentina) ed è ricercatrice presso il Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas (CISAV) di Querétaro (Messico).
Può riassumere alcune delle conclusioni del rapporto, soprattutto per quanto riguarda i Paesi dell'America Latina? Sembra che l'intolleranza stia crescendo e minacci sempre più la libertà di espressione dei cristiani e dei cattolici.
- È importante ricordare che la ricerca è un approccio iniziale ed esplorativo al fenomeno dell'autocensura tra i cristiani (cattolici e non) in Colombia e Messico. Come si legge nel rapporto, nel gruppo di intervistati (circa 40 persone) è stata individuata una tendenza a trovare molto difficile esprimere opinioni basate sulla propria fede in spazi pubblici o privati, soprattutto quando si tratta di questioni legate alla vita, al matrimonio, alla famiglia, all'eutanasia, all'adozione da parte di persone dello stesso sesso e ad altri temi correlati, tanto che, a volte, optano per l'autocensura.
Questa difficoltà non risiede solo nel timore di essere sanzionati amministrativamente o penalmente in base alle leggi antidiscriminazione, ma anche di essere screditati socialmente. Vale la pena notare che il discredito sociale non si limita solo alla critica.
A volte l'ambiente sociale ostile porta con sé un peso che si traduce nell'esclusione da certi ambienti e quindi nell'isolamento sociale, che ha un impatto sul modo in cui la persona gestisce la vita quotidiana.
Le reazioni a un ambiente sociale ostile saranno diverse, non è vero?
- Naturalmente, il modo di affrontare eventuali sanzioni o ambienti ostili varia da persona a persona. Uno dei risultati della ricerca è proprio che, tra gli intervistati, da un lato c'è il gruppo di coloro che non si autocensurano e accettano le conseguenze di un ambiente ostile, sostenendo che la loro fede vale la pena e che devono assumerne le conseguenze.
D'altra parte, c'è chi si autocensura per paura di sanzioni legali e/o sociali. C'è anche chi, a causa della costante autocensura e del mancato o quasi inesistente accompagnamento nella fede da parte di una comunità religiosa e cristiana, perde gradualmente la propria fede o cessa di vedere le caratteristiche legate all'autocensura come un problema.
Tuttavia, i risultati di questa ricerca non devono essere intesi come un tentativo di vittimizzare i cristiani (cattolici e non). Se da un lato esiste una limitazione all'espressione di opinioni basate sulla fede da parte dei cristiani sia in Messico che in Colombia, dall'altro dobbiamo riconoscere la controparte, ovvero i cristiani intolleranti nei confronti di altre posizioni o credenze che, partendo dalla loro fede, finiscono per stigmatizzare o discriminare altri gruppi. Ma è importante ricordare che è sempre necessario valutare ogni caso specifico.
Ci parli di un caso proveniente dalla Colombia o dal Messico.
- Ad esempio, in Colombia e in Messico, gli studenti ci hanno raccontato di aver smesso di partecipare alle lezioni perché le loro opinioni basate sulla fede su questioni di sessualità o di genere contraddicevano il modo di pensare dell'insegnante o contrastavano con la linea istituzionale e rischiavano la disapprovazione o l'espulsione.
In Messico, i funzionari pubblici intervistati hanno dichiarato di dover pensare due volte a quali parole usare per evitare di essere inseriti in un "certo quadro" o di essere denunciati all'Ufficio dell'Ombudsman, al Congresso o alla Procura. Le dichiarazioni relative alla loro fede o alle loro opinioni basate sulla fede suscitano polemiche e il conseguente rifiuto da parte dei loro partiti o delle istituzioni in cui lavorano. Un consigliere colombiano ha sottolineato che la cautela permanente è un sacrificio dell'attività pubblica.
Riconoscere l'autocensura e l'effetto raggelante sui cristiani significa riconoscere che c'è una parte di credenti di dottrina cristiana che, trovandosi in un ambiente ostile, non si sente libera di condividere le proprie convinzioni di fede sui temi sensibili sopra menzionati.
Madeleine Enzlberger, direttrice esecutiva dell'OIDAC Europa, ha sottolineato che "una delle conclusioni più preoccupanti e tragiche di questo rapporto (di Vienna) è che se i costi sociali del seguire il proprio credo e dell'esprimerlo diventano troppo alti, le persone finiranno per abbandonare il proprio credo". Condividete questa opinione?
- Come ho accennato, la ricerca in Colombia e Messico ha individuato in alcuni intervistati la possibilità di non vedere più l'autocensura come un problema o come qualcosa che influisce sull'esperienza di fede.
Le conseguenze non sempre portano ad abbandonare del tutto la fede; tuttavia, identificare la propria fede o le opinioni basate sulle proprie convinzioni come dannose, come uno svantaggio o un peso che non permette di "avanzare" nell'ambiente sociale è una forma di pressione con la possibile conseguenza di smettere di coltivare la propria fede o di non avere interesse a condividerla. Anche chi non ha una solida formazione nella fede può arrivare ad adottare contenuti dottrinali più in linea con il politicamente corretto.
Su olire.org c'è un rapporto intitolato ".Dati Può fare una breve valutazione complessiva del riconoscimento di questo diritto fondamentale in America Latina?
- Il diritto alla libertà religiosa è riconosciuto nella maggior parte dei Paesi latinoamericani. I quadri normativi regolano questo diritto, anche se, a seconda del Paese o del contesto politico, alcuni possono essere più protettivi di altri. Ad esempio, la protezione della libertà religiosa non è la stessa in Nicaragua che in Colombia, El Salvador o Honduras.
Il fatto che la costituzione o le norme di un Paese tentino di garantire questo diritto è un buon punto di partenza, ma non è sufficiente. A volte, anche quando le leggi nel testo stabiliscono parametri di applicazione e protezione, nella pratica ci sono vari contesti che mettono a rischio l'esercizio di questo diritto nelle sue varie dimensioni.
Considerando che la libertà religiosa non è limitata alla sfera privata, ma trascende la sfera collettiva e pubblica, gli impedimenti ai servizi religiosi negli spazi pubblici, gli ostacoli al finanziamento delle organizzazioni confessionali, la criminalizzazione delle espressioni di fede, le minacce ai leader religiosi che svolgono attivismo politico o sociale, ecc. minano il pieno esercizio di questo diritto.
L'America Latina non è esente da questi fenomeni; in tutta la regione sono state individuate diverse dinamiche che limitano questo diritto. Queste includono l'ostilità all'espressione religiosa da parte di attori statali e non statali, l'ostilità alla conversione religiosa nelle comunità indigene, la regolamentazione della religione da parte della criminalità organizzata e le restrizioni religiose motivate dal controllo totalitario del governo o da un'ideologia politica legata al comunismo.
La piattaforma ad accesso libero dell'Osservatorio sulla libertà religiosa in America Latina Violento Database degli incidenti, che contiene informazioni su episodi di violazione del diritto alla libertà religiosa nella regione, identificati attraverso ricerche a tavolino, informazioni fornite dai partner che collaborano o come risultato di ricerche sul campo. In questo database è possibile esaminare i casi relativi alle dinamiche sopra menzionate.
Il Nicaragua ha espulso le Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta. Cosa sta succedendo in quel paese, secondo lei?
- Nei Paesi con tendenze autoritarie, come il Nicaragua, la Chiesa è una delle poche, se non l'unica istituzione che gode di maggiore credibilità e, pertanto, il suo livello di influenza tra la popolazione è visto come un pericolo per il controllo del governo. Nel Paese, le violazioni della libertà religiosa a sfondo politico si sono intensificate e sono state utilizzate diverse strategie dal governo per intimidire la voce dei leader religiosi, in particolare dei cattolici, quando il loro discorso è percepito come critico, per aver mostrato sostegno all'opposizione o quando denunciano gli sforzi per riportare lo Stato di diritto nel Paese.
L'espulsione delle Missionarie della Carità è solo un altro episodio di questa campagna di intimidazione e ritorsione da parte del governo. Le misure applicate contro il settore religioso cattolico percepito come opposizione vanno dalle restrizioni alla mobilità/viaggio con il trattenimento o la revoca dei visti, agli impedimenti all'ingresso nel Paese, alle molestie nei confronti dei leader religiosi e delle loro famiglie attraverso la sorveglianza di parrocchie, case, veicoli; alle campagne di diffamazione, alle minacce verbali, agli attacchi all'integrità fisica, agli arresti, alle minacce di arresto.
Leggi che criminalizzano ogni critica
D'altra parte, nel contesto del quadro giuridico, esistono leggi che criminalizzano qualsiasi critica e in base alle quali i leader religiosi possono essere sanzionati con l'arresto o, nel caso delle organizzazioni basate sulla fede, con la perdita dello status giuridico, per non parlare di altri ostacoli al funzionamento o alle operazioni delle organizzazioni basate sulla fede, nonché delle restrizioni al normale funzionamento o alle attività delle chiese legate all'assistenza umanitaria.
Anche la Corte interamericana dei diritti umani ha emesso misure cautelari a favore di un vescovo e di un diacono del Paese, in considerazione della grave e urgente situazione di rischio a cui sono esposti.
Queste strategie, oltre ai discorsi di odio delle autorità contro la Chiesa, hanno permeato la società e hanno promosso atti di intolleranza da parte di gruppi o gruppi simpatizzanti del governo che, oltre a monitorare le azioni o le dichiarazioni dei leader religiosi o delle congregazioni legate a questi leader, commettono anche atti di vandalismo o profanazione dei luoghi di culto. Gli attacchi sono particolarmente feroci nel caso delle chiese cattoliche.
D'altra parte, ci sono paesi con un processo costituzionale in corso: come vede questi processi in relazione al diritto alla libertà religiosa?
- Per quanto riguarda i processi costituzionali e il loro rapporto con il diritto alla libertà religiosa, direi che è abbastanza vicino. Le costituzioni politiche incarnano, tra l'altro, i principi fondamentali dello Stato, il tipo di governo e il modo in cui vengono intesi e tutelati i diritti umani dei cittadini di ciascun Paese, compreso il diritto alla libertà religiosa.
In questi processi si possono prendere in considerazione diversi aspetti. Da un lato, può portare a frizioni con le confessioni religiose minoritarie, se non è previsto lo stesso riconoscimento costituzionale delle religioni maggioritarie o tradizionali.
D'altra parte, può entrare in gioco un'intera discussione sul fatto che lo Stato debba o meno includere una specifica confessione religiosa, soprattutto tenendo conto del fatto che lo Stato si riconosca o meno come laico. E cosa si intende con il principio della separazione tra Chiesa e Stato.
Inoltre, in questi processi, le comunità religiose cercano non solo il riconoscimento della libertà religiosa in generale, ma anche la protezione di alcune figure giuridiche importanti per ogni dottrina religiosa, come il matrimonio e la famiglia.
Cuba, Cile, Nicaragua...
Nel caso cubano, l'ultima riforma costituzionale sottoposta a referendum includeva modifiche al concetto di matrimonio, che hanno portato al rifiuto della proposta da parte dei gruppi religiosi, i quali a loro volta hanno esercitato pressioni da parte delle autorità nei confronti dei leader religiosi e delle congregazioni che si rifiutavano di accettare le riforme costituzionali.
Nel recente caso cileno, uno dei temi di discussione della Convenzione costituzionale è anche il modo in cui verrà incorporato il diritto alla libertà religiosa. Poiché la Costituzione informa l'intero sistema giuridico di una nazione, l'incorporazione di questo diritto è un presupposto importante per la sua protezione e garanzia nel Paese.
In Nicaragua non c'è stato un processo costituente recente, ma ci sono state elezioni presidenziali nel novembre dello scorso anno, che sono state piuttosto irregolari. Per certi versi questo è anche strettamente legato al modo in cui viene tutelata la libertà religiosa, poiché il processo elettorale come meccanismo di partecipazione dei cittadini, se non è completamente libero e trasparente, non consolida la democrazia e anzi corrode il sistema di garanzia dei diritti, violando libertà fondamentali come il diritto alla libertà religiosa, soprattutto nella sua dimensione pubblica e collettiva.
Contesti di pressione in Messico
Una delle autrici del rapporto di Vienna, Friederike Boellmann, ha sottolineato che "il caso tedesco rivela che le università sono l'ambiente più ostile. E il più alto grado di autocensura che ho riscontrato nella mia ricerca in ambito accademico". Sta accadendo qualcosa di simile in America Latina?
Per quanto riguarda l'ambiente ostile nelle università, è stato soprattutto tra gli intervistati in Messico che sono emersi vari contesti di pressione contro insegnanti e studenti cristiani (cattolici e non).
In Messico, un professore universitario ha riferito che quando si è trasferito da Chihuahua a Città del Messico ha sentito una maggiore pressione per evitare di parlare della sua fede nell'ambiente accademico, e all'università è stato costretto a smettere di usare frasi come "Gracias a Dios", "Dios te bendiga", "Con el favor de Dios", ecc.
Lo stesso insegnante ha fatto notare che, finché non gli viene chiesto esplicitamente di trattare certi argomenti, preferisce non toccarli per paura di essere ignorato o non ascoltato. In questo senso, egli intende la sua situazione come autocensura didattica, per non perdere l'opportunità di continuare a "essere presente".
Un'altra insegnante messicana ha commentato che ha dovuto fare attenzione al vocabolario o alle espressioni che ha usato. Se gli studenti conoscevano la sua appartenenza religiosa, non importava se usava argomenti scientifici per affrontare certi temi, ma lei sentiva di essere respinta socialmente dai suoi studenti e di essere squalificata a priori solo perché accettava di avere delle convinzioni religiose. Anche i suoi articoli scientifici sono stati rifiutati dai comitati editoriali perché "di parte".
Nella stessa ottica, uno studente messicano, sottoposto a un procedimento disciplinare universitario con l'accusa di violenza contro le donne per il suo rifiuto dell'aborto, ha detto di conoscere un professore che era favorevole, ma non poteva sostenerlo apertamente perché avrebbe messo il professore nei guai con il direttore del dipartimento.
Ci sono leggi o progetti in preparazione, come nei Paesi europei, che impediscono l'espressione di un punto di vista cristiano o cattolico sulla sessualità o sul genere?
- Da quello che so, ci sono leggi e iniziative legislative che cercano di limitare l'espressione di opinioni basate sulla fede nella regione, anche se non riguardano solo il settore accademico, ma hanno una portata più ampia.
Esistono regolamenti o politiche che limitano l'esercizio della libertà religiosa, il diritto all'obiezione di coscienza o che incidono sull'autonomia e sull'immunità dalla coercizione delle istituzioni religiose quando manifestano o agiscono in base alle proprie convinzioni o all'ideologia istituzionale e ciò non è conforme alle politiche sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere di un determinato Paese.
Possiamo citare l'iniziativa presentata nel 2020, che mirava a riformare la sezione IV dell'articolo 29, corrispondente al capitolo sulle infrazioni e le sanzioni della Legge sulle associazioni religiose e il culto pubblico in Messico.
La proposta mirava a sanzionare gli atti di discriminazione sulla base dell'identità sessuale o dell'espressione di genere da parte di organizzazioni religiose e dei loro agenti nei confronti della popolazione appartenente a minoranze sessuali. L'iniziativa non ha avuto successo, ma è un esempio dei tentativi di limitare la libertà di espressione dei leader religiosi su questioni legate alla sessualità e al genere.
Ci sono altri casi?
- In Argentina, c'è stato anche il caso di un'indagine dell'Istituto nazionale contro la discriminazione, la xenofobia e il razzismo sui contenuti educativi della rete educativa della Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA). Le autorità hanno ritenuto che gli insegnamenti in linea con l'ideologia cristiana del gruppo avessero connotazioni omofobe e di odio nei confronti delle minoranze sessuali e del movimento femminista.
In Colombia, un giudice si è rifiutato di sposare una coppia di donne perché ciò sarebbe andato contro la sua morale e le sue convinzioni cristiane. La comunità LGTBI ha trovato l'atteggiamento del giudice offensivo e discriminatorio. Il giudice è stato denunciato per prevaricazione.
Nell'aprile di quest'anno, la Corte interamericana dei diritti umani ha dichiarato lo Stato cileno responsabile della violazione dei diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione, alla libertà personale, alla privacy e al lavoro di Sandra Pavez Pavez, per l'evidente trattamento discriminatorio di cui è stata vittima quando è stata rimossa dal suo incarico di insegnante di religione cattolica in una scuola pubblica, dopo che il Vicariato per l'Educazione del Vescovado di San Bernardo le ha revocato il certificato di idoneità sulla base del suo orientamento sessuale. Questo nonostante il fatto che, secondo la normativa cilena, l'autorità nazionale conferisca all'autorità religiosa il potere di rilasciare la certificazione di idoneità per gli insegnanti che insegneranno la loro dottrina e i loro principi.
Per citarne solo alcuni.
Ringraziamo Teresa Flores per le sue risposte. Il diritto alla libertà religiosa sembra avere un semaforo rosso in alcuni Paesi dell'America Latina, cioè gravi problemi, e sicuramente ambra in diversi di essi, a seconda delle questioni, soprattutto vita, sessualità, famiglia e genere. L'Osservatorio che egli dirige (OLIRE) può essere una buona torre di guardia per il suo monitoraggio.
Frate Pascual SaturioGli abitanti di Cadice "non lasciano mai la Vergine".
Oggi si celebra la festa di Nostra Signora del Monte Carmelo, patrona della gente di mare e della Stella maris. Ma c'è un'altra Vergine, quella di Cadice, la Vergine del Rosario, che per più di 150 anni è stata imbarcata ogni anno con la flotta armata che preservava la marina mercantile. È la piccola Galeona, che solca il mare mentre il Santo Patrono a grandezza naturale rimane nel santuario di Cadice. Padre Pascual Saturio parla della Vergine a Omnes.
Fray Pascual Saturio è arrivato a Cadice nel 1988, già sacerdote domenicano, e sembra che non ci siano molte persone che conoscano così bene l'intenso rapporto della capitale di Cadice con la Vergine come quest'uomo pieno di vitalità.
La presenza della Vergine del Rosario tra gli uomini di mare risale alla vittoria navale di Lepanto (1571) ed è profondamente radicata a Cadice. Fray Pascual parla a Omnes dal santuario di Nostra Signora del Rosario. Nostra Signora del Rosarionel tempio di Santo Domingoanche se popolarmente la si chiama Santo Domingo, proprio perché il Rosario, la devozione al Rosario e la presenza dei monaci qui è dovuta alle circostanze degli schiavi neri".
Infatti, "gli schiavi neri che non sono stati portati in America sono rimasti qui in città. Venivano dall'Angola e dal Mozambico, una parte dell'Africa evangelizzata dai frati domenicani. E furono loro a creare la confraternita [della Vergine] che era un rifugio, una specie di assicurazione privata, perché tutti potessero avere medicine, un medico, una piccola pensione alla fine... E la misero sotto il rifugio della Vergine del Rosario".
Chiesero un frate, che arrivò da Sanlúcar, P. G., che era un frate di nome e di fatto. Luis CastendaPascual, intorno al 1620-1622, che venne con loro come cappellano, spiega p. Pascual, e iniziarono la piccola cappella della Vergine.
"Nel complesso, fu tra la presenza dei neri e del Rosario a Cadice e la vittoria di Lepanto che la Vergine ottenne il patronato sulla città di Cadice e divenne patrona della città. E nello stesso santuario si trovano le due immagini, quella della Vergine del Rosario, a grandezza naturale, e quella della Vergine del Rosario, a grandezza naturale. Galeona".
Abbiamo chiesto a Fray Pascual innanzitutto le date storiche e il suo arrivo a Cadice.
Da quando la Vergine del Rosario è la patrona di Cadice?
- La Vergine del Rosario è la patrona di Cadice da 150 anni. La nomina pontificia della Vergine risale a 152 o 153 anni fa, e noi la celebriamo. Ma è provato che già più di trecento anni fa il popolo e il consiglio comunale la consideravano la patrona di Cadice, anche se la nomina fu fatta più tardi.
E tu, da quanti anni sei lì, nel convento di Santo Domingo?
- Sono arrivata nel 1988 e da allora fino ad oggi, 2022, sono qui in convento e sono ancora una conventuale. La vita passa velocemente.
E da allora è stato priore? Rettore?
- Quando avevamo una comunità e c'era un gruppo più numeroso di domenicani, svolgevo i servizi che la comunità mi chiedeva di fare. Tra questi, il servizio del priore un paio di volte. E poi, quando sono iniziati i lavori di adattamento della casa, perché volevamo costruire un'infermeria provinciale, non si è potuto fare e abbiamo dovuto lasciarne una parte per una foresteria.
Per tutto questo tempo sono stata qui da sola, e sono stata la principale responsabile del santuario della Vergine e delle cose che erano sotto la cura del convento. E in questo momento, ora che i lavori della casa sono finiti, sono ancora il responsabile del santuario, il responsabile. Beh, rettore, sì, che è l'ufficio e l'occupazione principale della casa ora. E trattandosi di un solo frate, non c'è un priorato.
Un'ultima domanda su di lei, e poi passiamo a parlare della Madonna. Quando è entrato nei Domenicani ed è diventato sacerdote, fra Pascual?
- Sono entrato nell'Ordine nel 1978. E poi il cardinale Amigo Vallejo, che riposi in pace, mi ha ordinato sacerdote nel 1984. Così sono entrato nell'Ordine dei Predicatori, della Parola e al servizio della Parola, nel 78, e un anno dopo ho professato come domenicano, come ci chiama la gente comune.
Andiamo dalla Vergine. La festa del Santo Patrono è in ottobre, ma poiché tutte le feste della Vergine sono belle, la facciamo ora.
- Naturalmente.
Come vede la devozione a Nostra Signora a Cadice, e gli abitanti di Cadice si recano lì per pregare la loro patrona?
- Guarda, succede con il Santo Patrono esattamente come succede con le madri di tutti gli spagnoli. Forse non siamo molto eloquenti, né diciamo tutto il giorno Ti amoNon la baciamo tutto il giorno, ma comunque, nel cuore di ognuno di noi, la persona di vostra madre occupa più della metà del nostro cuore. Così è per la Madonna del Rosario.
Questo santuario qui a Cadice non è un santuario come gli altri grandi santuari... Tuttavia, in tutti gli abitanti di Cadice il patrocinio della Vergine e l'affetto per la Vergine del Rosario come loro Madre e famiglia è profondamente radicato nei loro cuori e nelle loro coscienze. Questo è vero.
Questa è una città dove ci sono molte chiese e molte immagini, e durante l'anno ci sono molte circostanze religiose da celebrare. Tuttavia, nell'interno di ogni cuore, hanno posto il loro altare e non lasciano mai la Vergine.
Avete una fratellanza, vero?
- Sì. L'Arciconfraternita del Santissimo Rosario. Appartiene a tutto l'Ordine ed è universale. È il gruppo dei fedeli. Qui ce ne sono circa tre o trecentocinquanta. È un gruppo di fedeli che si impegna, almeno una volta alla settimana, a recitare una parte del Rosario, per poi partecipare alla vita del santuario, al culto della Vergine, in collaborazione con i frati. E non cessano di far parte della famiglia domenicana e dell'Ordine in questo senso.
Qui, per anni, un'area del convento è stata utilizzata come studio di trasmissione, e ogni giorno il Rosario veniva trasmesso dal convento. Quando questa trasmissione è andata perduta, bisogna ricordare che la Conferenza Episcopale Spagnola, e anche l'Ordine, volevano acquistare spazio sufficiente per trasmettere il Rosario ogni giorno su tutte le stazioni radio necessarie. Ma questo non si è realizzato.
E ora si sottolinea ancora una volta il valore dei mezzi di diffusione di cui disponete. Guardate il canale televisivo, con Radio Maria, e con quegli elementi che sono stati messi in funzione anche in alcune diocesi, il successo che stanno avendo. Perché molte persone, non solo anziani e malati, mentre fanno le loro cose a casa, possono allo stesso tempo pregare e quindi partecipare alla preghiera della Chiesa.
Ci parli del Santo Patrono della città, e della Galeona. Chi non conosce bene la storia può confonderli.
- Sono due immagini diverse. Una è la Santa Patrona di Cadice, l'immagine a grandezza naturale della Santa Patrona, e si trova sempre nel suo altare, nel suo santuario. Tra l'altro, la devozione alla prima immagine, quella della Virgen del Carmen, è nata qui, nel convento, ed è nata qui perché noi domenicani siamo arrivati a Cadice prima dei Carmelitani Scalzi e, quando sono arrivati, abbiamo portato la Vergine nel suo tempio.
Ebbene, qui a Cadice, ogni anno c'erano tre spedizioni militari che dovevano preservare la marina mercantile in mezzo al mare, proprio a causa della pirateria degli inglesi, dei portoghesi e di coloro che si dedicavano ai furti in mare. Questa flotta armata, che conservava la marina mercantile, era chiamata galeone. E uno dei capitani della flotta che ogni anno andava da Cadice a Cartagena de Indias, in Colombia, ebbe l'idea: "Perché non imbarchiamo l'immagine che abbiamo nella nostra cappella".
Avevano la cappella della terraferma qui nel convento, per seppellire gli ammiragli e i più importanti che sono morti. Perché non portiamo con noi l'immagine che abbiamo nella nostra cappella? Mentre siamo in mare, va e viene con noi. E poi durante il nostro periodo di riposo, qui a Cadice, è in convento".
Ed è così che la Beata Vergine è stata imbarcata ogni anno per più di 150 anni in quella flotta. Si tratta della seconda immagine della Vergine del Rosario, un'incisione di 70-75 centimetri. Quando il transito commerciale scomparve e il commercio cominciò a svolgersi con altri mezzi, aerei, ecc. l'immagine rimase qui nel convento.
Ma poi imbarcarono la Galeona e questa iniziò a navigare intorno al mondo...
- Sì, è stato quando è arrivata la nave scuola. Juan Sebastián Elcanoche è la nave dell'Armada spagnola, dove i marinai fanno i loro ultimi corsi. Gli uomini dell'Armada, con il sindaco e il priore dell'epoca, ebbero l'idea che quando l'Elcano farà il giro del mondo, perché non imbarcare la Galeona? Viene con noi e la rendiamo presente in tutto il mondo, ricordando la presenza della Vergine del Rosario tra gli uomini di mare fin dai tempi di Lepanto, dalla vittoria navale di Lepanto. E così è stato fatto.
E ora, ultimamente, ha fatto il giro del mondo per sei volte. E ogni anno andiamo con lei, facciamo una piccola processione, noi e i marinai, all'addio di Elcano, che è ancora al molo di Cadice.
L'immagine a grandezza naturale della Vergine del Rosario, la Santa Patrona, quella che si trova nel santuario, con un paramento, non è stata imbarcata. È stata imbarcata a volte, sporadicamente, quando l'abbiamo portata in visita alle parrocchie o per un'azione marina in banchina, ma molto sporadicamente. Quella che viene sempre presa in considerazione è la seconda immagine della Vergine del Rosario, che abbiamo anche qui in convento.

Fuori microfono, un'ultima domanda, che riprenderemo anche alla fine. Si racconta che il Papa indossi il bianco a causa dei Domenicani. E fr. Pascual lo commenta.
- È così. Il Papa si vestì come un cardinale fino a diventare Papa Pio V. Era molto affezionato al suo abito domenicano, e fu eletto Pontefice, e fu lui a dire, beh, va bene così. Ma non cambierò il mio modo abituale di vestire, le mie abitudini, per svolgere il compito che mi avete affidato.
E se guardate il nostro abito, l'abito del Papa è lo stesso, l'unica cosa è che hanno aggiunto la fascia su cui porta il suo stemma, e poi hanno tolto il picco sul retro del cappuccio, che è il segno dei mendicanti. Noi frati che abbiamo un cappuccio, e il cappuccio finisce in un becco, è perché viviamo lavorando in mezzo agli altri. Il Papa, poiché il suo lavoro è diverso, si è fatto arrotondare il cappuccio, togliendo l'apice della mendicità, ma l'abito è esattamente lo stesso. E il Papa è ancora quello che veste di bianco nella Chiesa.
Frate Pascual conclude dicendo, di sua iniziativa e senza alcun dubbio: "In questo momento, in Europa occidentale, questo stile di vita che stiamo conducendo ha molte lacune e molte difficoltà. Penso che sia necessario invertire la rotta. È successo ai tempi dei Romani, e anche allora erano così sicuri: l'Impero Romano sarebbe caduto. Beh, è caduto. Le stesse difficoltà che incontrano le famiglie e l'ordine sociale, e il modo in cui abbiamo vissuto, stanno colpendo gli ordini religiosi e la Chiesa. Perché siamo parte di tutti, e nel mondo siamo con voi".
Oggi, e questo è il nostro, ci rivolgiamo alla Vergine, la Vergine del Monte Carmelo, la Vergine del Rosario, e alle invocazioni di ciascuno di noi: chi non ha un carmelitano in famiglia, vicino o lontano, e un Rosario vicino!
Perché la visita del Papa in Canada è importante
Il prossimo viaggio del Papa in Canada è più di una visita: è un momento di riconciliazione per gli indigeni con un Gesù Cristo inculturato, un Cristo che gli indigeni vorrebbero rifiutare.
 Canada: andare verso le periferie. Al Polo Nord e nel deserto laicista
Canada: andare verso le periferie. Al Polo Nord e nel deserto laicista "Camminiamo insieme, arrivederci in Canada". Le storiche scuse del Papa agli indigeni canadesi.
"Camminiamo insieme, arrivederci in Canada". Le storiche scuse del Papa agli indigeni canadesi. Le persone "scomparse" del Canada
Le persone "scomparse" del CanadaLeggo ogni giorno Le Devoirun giornale nazionalista e laico di Montreal. Per questo mezzo, che un secolo fa era nazionalista e clericale, la visita del Papa in Québec Nel giro di pochi giorni non sembra essere una novità. Probabilmente cambierà idea...
Ogni viaggio papale è importante, ma mi sembra che la viaggio di fine mese in Canada Lo è in modo particolare. La rivoluzione antireligiosa occidentale della seconda metà degli anni Sessanta ha colpito duramente la minoranza cattolica proattiva del Canada. Sei decenni dopo, il cristianesimo non esiste più qui, nel senso datogli dalla filosofa francese Chantal Delsol.
Delsol, che ha recentemente parlato a Montréal, ha pubblicato nel 2021 il saggio La fine della Chrétienté. Lì afferma che il millennio e mezzo cristiano che si sta concludendo in Occidente era basato sul dominio. Il cristianesimo, che non muore mai, deve inventare una nuova modalità di esistenza: la testimonianza.
Questo, a mio avviso, è l'obiettivo del testimone Francisco. Viaggio in questa periferia esistenziale di essere un testimone del perdono e della comprensione. Viene su richiesta dei novanta vescovi canadesi. Questi vescovi hanno subito pressioni da parte di gruppi indigeni e indigenisti, che hanno chiesto che il Papa richiedesse personalmente perdono in Canada dal colonialismo cristiano. Non sarà la prima volta che Francesco si esprimerà in nome della Chiesa, in quanto poverello del XXI secolo.
Il numero relativamente basso di indigeni e Métis canadesi (meno di due milioni) dimostra che per la Chiesa - Francesco - Cristo - gli esseri umani contano in sé. Non importa quanto siano pochi. Il Papa verrà a trovarli, anche se dovrà farlo su una sedia a rotelle. Dal 24 al 29 luglio si recherà nelle province di Alberta e Quebec e nel territorio di Nunavut. Viene per ascoltare, per stare con loro.
San Giovanni Paolo II ha fatto qualcosa del genere durante il suo lungo tour nel settembre 1984 (incontrando ad esempio gli indigeni in Ontario); e poi il 20 settembre 1987. Quel giorno il Papa polacco visitò Fort Simpson nel Territorio del Nord-Ovest. Ha rivolto un messaggio alle popolazioni aborigene, ha incontrato i leader di quattro organizzazioni indigene nazionali e ha celebrato la Messa domenicale. È stato il compimento di una promessa fatta tre anni prima, quando la nebbia aveva impedito al suo aereo di atterrare a Fort Simpson.
Ora Francesco sta viaggiando anche in America. Iqaluit, la capitale del Nunavut, ha solo ottomila abitanti. Se questo territorio Inuit, che si estende fino al Polo Nord, fosse un Paese, sarebbe il 15° più grande del mondo.
I rischi della visita in Canada
Francisco è un temerario. A 85 anni riesce a malapena a camminare, ma vuole farlo. Camminare insieme con gli indigeni (questo è il motto della visita). Scommette anche che gli indigeni si riconcilieranno con un Gesù Cristo inculturato, un Cristo a cui gli indigeni sono allergici. La percentuale di cattolici canadesi indigeni è probabilmente superiore al 40 % (che è circa la percentuale di cattolici canadesi battezzati). Fattore chiave: il tasso di natalità degli indigeni (circa 2,5 per donna) è superiore all'anemico tasso canadese, pari a 1,4.
Francesco scommette che la sua strategia (per ispirazione divina, senza dubbio) di andare nelle periferie geografiche (nominando gli elettori del futuro papa in luoghi lontani dai grandi titoli dei giornali e sconosciuti alle borse) - che questo ricentrerà il sistema di posizionamento globale ecclesiale.
La sua strategia consiste nell'allontanarsi dall'autoreferenzialità. Dal narcisismo, dalla malattia tipica della Chiesa egocentrica, ripiegata su se stessa come la donna del Vangelo, che porta alla mondanità spirituale e al clericalismo, e che ci impedisce di sperimentare "la dolce e confortante gioia di evangelizzare" (cfr. "Evangelii gaudium", citando San Paolo VI). Francesco vuole uscire dalle sacrestie, calcio i viali della metropoli e i sentieri alpini, asiatici, amazzonici e africani.
Francesco forse scommette sul fatto che i suoi critici - ne ha nel Canada anglofono, influenzato da un certo conservatorismo clericale nordamericano - si rendano conto che egli è contemporaneamente progressista e conservatore. O che sia, come dice Juan Vicente Boo in Il Papa della gioiaun "conservatore intelligente".
Per tutti questi motivi e altri ancora, questo viaggio è importante. Vediamo come va. Rimanere sullo schermo.
Mons. Raymond PoissonRead more : "La presenza del Santo Padre in Canada ci guiderà nella direzione in cui dobbiamo andare".
L'arcivescovo Raymond Poisson, presidente della Conferenza canadese dei vescovi cattolici, ha rilasciato un'intervista a Omnes in vista della prossima visita di Papa Francesco in Canada per incoraggiare il processo di riconciliazione e guarigione dei cattolici canadesi con le comunità indigene.
 "Camminiamo insieme, arrivederci in Canada". Le storiche scuse del Papa agli indigeni canadesi.
"Camminiamo insieme, arrivederci in Canada". Le storiche scuse del Papa agli indigeni canadesi. Il Papa si recherà in Canada per incontrare le popolazioni indigene
Il Papa si recherà in Canada per incontrare le popolazioni indigene Le persone "scomparse" del Canada
Le persone "scomparse" del CanadaÈ una visita storica per molti motivi. Papa Francesco visiterà il Canada nel mese di luglio in un viaggio molto speciale. Oltre ad ascoltare e dialogare con le popolazioni indigene, ad esprimere la sua vicinanza e ad affrontare il coinvolgimento della Chiesa cattolica nella gestione delle scuole residenziali in Canada, la visita papale sarà un'occasione per incontrare la più ampia comunità cattolica canadese.
Una comunità che da anni è immersa in un processo di accettazione, perdono, ma soprattutto di costruzione di un futuro, come ha sottolineato in questa intervista per Omnes, Raymond Poisson, presidente della Conferenza canadese dei vescovi cattolici.
In questa conversazione, mons. Poisson, che è vescovo della diocesi di Saint-Jérôme-Mont-Laurier, nella provincia del Québec, osserva che "la parola, i gesti, la presenza del Santo Padre ci guideranno nella direzione da prendere" in questo difficile ma necessario cammino.
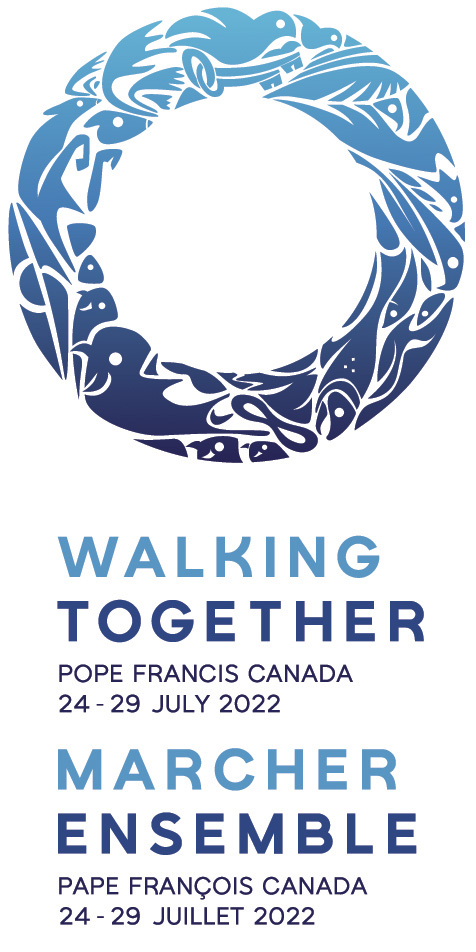
Come si sta preparando la Chiesa canadese a questa visita?
- Si tratta di un grande lavoro di squadra con diversi partner, a livello nazionale e locale, che deve essere svolto in tempi record.
Da più di tre anni, un gruppo di quattro vescovi accompagna regolarmente le iniziative dei vescovi del Canada in vista di azioni e gesti concreti di riconciliazione con i nostri fratelli e sorelle indigeni. Come membro di questo gruppo, posso testimoniare il percorso che ci ha portato a organizzare questo incontro a Roma di 3 delegazioni - First Nations, Inuit e Métis - con Papa Francesco (marzo-aprile 2022).
Questi incontri sono culminati in un'udienza di oltre 150 delegati indigeni con il Santo Padre, durante la quale Papa Francesco si è unito alle scuse presentate dai vescovi del Canada nel settembre 2021. Per dare seguito a queste delegazioni a Roma, Papa Francesco ha accettato l'invito dei suoi fratelli vescovi. di venire in Canada a partire dal luglio 2022.
Le organizzazioni nazionali dei popoli indigeni sono coinvolte nella pianificazione della visita papale in Canada. Gli scambi sono iniziati con i delegati che si preparavano a recarsi in Vaticano nel marzo/aprile 2022 e sono proseguiti durante gli incontri privati con Papa Francesco e con un gruppo di lavoro di vescovi canadesi in un dialogo continuo.
I fratelli e le sorelle indigeni hanno anche partecipato a visite preliminari ai potenziali luoghi della visita papale. La programmazione è stata messa a punto in stretta collaborazione con loro per garantire che la prossima visita di Papa Francesco sia un passo importante sulla via della guarigione e della riconciliazione.
Preghiamo per la salute del Santo Padre mentre ci imbarchiamo in un'intensa pianificazione di questa storica visita.
La preparazione di questo viaggio è stata, come lei sottolinea, molto rapida. A parte i preparativi "ufficiali", come vengono coinvolti i fedeli nei preparativi?
- Ci sono molti modi in cui i fedeli sono coinvolti nei preparativi per la visita del Santo Padre, per gioire dell'amore di Dio e per mostrare come ci uniamo al Papa nel suo impegno per la guarigione e la riconciliazione.
Alcuni gruppi parrocchiali pregano insieme, altri fanno volontariato, altri ancora viaggiano per partecipare a uno degli eventi pubblici, ecc.
Questo problema riguarda i sopravvissuti alle scuole residenziali, ma anche tutti coloro che hanno subito dolori o traumi per mano di membri della Chiesa cattolica.
Mons. Raymond Poisson. Presidente della Conferenza canadese dei vescovi cattolici
La visita del Papa è segnata da notizie di comportamenti poco edificanti di alcune istituzioni ecclesiastiche nei confronti della popolazione indigena. Pensa che questa visita segnerà una svolta nella storia della Chiesa canadese?
- Durante le delegazioni a Roma, abbiamo sentito le parole di Papa Francesco, che ha parlato in termini di scuse ai suoi fratelli vescovi per i comportamenti di alcuni membri della Chiesa nelle scuole residenziali. Sappiamo che la sua visita sarà un ulteriore passo verso la guarigione e la riconciliazione.
Questo problema riguarda i sopravvissuti delle scuole residenziali, ma anche tutti coloro che hanno subito dolori o traumi per mano di membri della Chiesa cattolica. Ma questa visita tocca soprattutto la volontà della Chiesa di vivere con i nostri fratelli e sorelle indigeni nuovi progetti di riconciliazione. Non solo scuse.
La visita del Papa può anche avere un certo effetto liberatorio, consentendo un passo verso la guarigione per un gran numero di vittime di diversi tipi di abuso, così come per le loro famiglie di ex studenti, che sperimentano l'impatto multigenerazionale.
Ovviamente, non tutte le vittime saranno placate, ma per molti sarà un'occasione per ascoltare e vedere Papa Francesco commosso dalle testimonianze ascoltate.
Gli aborigeni attribuiscono grande importanza alla relazione, alla presenza. Da qui l'importanza di avere un evento in territorio canadese e di far partecipare il maggior numero possibile di aborigeni.
Questa visita tocca soprattutto la volontà della Chiesa di vivere con i nostri fratelli e sorelle indigeni nuovi progetti di riconciliazione. Non solo scuse.
Mons. Raymond Poisson. Presidente della Conferenza canadese dei vescovi cattolici
In questo senso, come vivono questo viaggio le popolazioni indigene, compresi i non cattolici?
- In generale, dopo due anni di pandemia: come sarà bello rivedersi in grandi gruppi, essere felici di stare insieme!
È necessario ricostruire e consolidare i legami, conoscersi e rispettarsi meglio, comprendere meglio le spiritualità e le tradizioni aborigene, approfondire la comprensione delle verità, chiarire i nostri modi di vedere noi stessi.
Ci sono pregiudizi e stereotipi tra di noi, quindi camminare insieme, cattolici e altre confessioni religiose con tutta la popolazione, ci aiuterà a creare un futuro più unito. L'idea è quella di trasformare il modo in cui ci guardiamo l'un l'altro. Questa visita è un'opportunità unica offerta a tutta la società canadese.

Il motto della visita è "Camminare insieme", come parte del processo di riconciliazione avviato anni fa dai vescovi del Canada. Come procede questo processo?
- La delegazione che si è recata a Roma lo scorso aprile fa seguito a più di tre anni di dialogo tra i vescovi cattolici canadesi e i loro partner indigeni, tra cui l'Assemblea delle Prime Nazioni (AFN), il Consiglio Nazionale Métis (MNC) e l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), con l'obiettivo di imparare e discernere il modo migliore per sostenerli nel cammino di guarigione e riconciliazione.
Mentre questo dialogo continua, abbiamo preso diverse fasi importantiper sostenere un futuro più luminoso, tra cui l'annuncio di $30 milioni di euro a sostegno di iniziative di guarigione e riconciliazione, il nostro impegno a garantire che i documenti relativi alle scuole residenziali siano messi a disposizione dei sopravvissuti e la continuazione dei nostri sforzi per educare il nostro clero, i consacrati e i laici alle culture e alla spiritualità indigene.
Esiste un chiaro consenso tra i vescovi canadesi sulla necessità di fare di più per alleviare le sofferenze storiche e attuali causate dal sistema delle scuole residenziali.
Il viaggio del Santo Padre in Canada ci permetterà di stare insieme, di camminare insieme, membri di comunità indigene e non indigene. Vivere insieme eventi forti che parlano per noi, pensiamo, sarà benefico.
Le parole, i gesti, la presenza del Santo Padre ci guideranno nella direzione che dobbiamo prendere, ci apriranno strade per continuare a camminare insieme verso la riconciliazione, verso la guarigione, verso una visione del futuro.
Camminare insieme, cattolici e altre confessioni religiose con tutta la popolazione, ci aiuterà a creare un futuro più unito. L'idea è quella di trasformare il modo in cui ci guardiamo l'un l'altro.
Mons. Raymond Poisson. Presidente della Conferenza canadese dei vescovi cattolici
Il Canada, come il resto dell'Occidente, ha subito un grandissimo processo di secolarizzazione. Com'è oggi la Chiesa in Canada? Come ha vissuto e sta vivendo questo processo di purificazione che a volte può risultare quasi incomprensibile?
- La Chiesa come istituzione personalizza un intero popolo in movimento; è una forza d'azione. C'è anche un pericolo: la Chiesa non deve essere limitata ai membri consacrati o chierici, ma a tutti i battezzati.
Attraverso sfide e controversie, gioie e progetti, la Chiesa cerca di dare centralità a Cristo, al Vangelo e ai valori evangelici. È composta da esseri umani e quindi non è perfetta.
Nella società cresce l'importanza dell'autenticità della testimonianza che questa Chiesa, con i suoi pastori e tutta la sua struttura, deve servire al cuore della società. È anche questa autenticità, la "fedeltà alla missione", che viene spesso rimproverata ai membri della Chiesa nel caso dei collegi.
Grazie alla mia appartenenza e partecipazione alla Conferenza dei vescovi cattolici canadesi, sono ispirato da meravigliosi esempi di impegno e santità nel cammino missionario del popolo di Dio in Canada. Il mondo moderno è pieno di complessità, ma ci sono anche momenti in cui la Parola di Dio può mettere radici nella società.
Come vescovi, contiamo su tutti i membri del popolo di Dio, compresi il clero, i laici e le persone consacrate, tutti i battezzati, per dare una buona testimonianza del Vangelo nella vita quotidiana.
La Dottrina sociale della Chiesa: guida e base per la vita delle Confraternite
I valori fondamentali della vita sociale - verità, libertà, giustizia e carità - devono essere promossi e vissuti in modo speciale nelle confraternite; questa è la loro missione. Per questo motivo, la Dottrina sociale della Chiesa sembra particolarmente adatta a essere messa in pratica nella vita della fraternità.
L'uomo raggiunge la sua pienezza solo nella società. La natura umana è l'unica che ha bisogno di relazioni sociali per realizzarsi. Questo è spiegato nel Libro della Genesi, all'inizio della Bibbia: "Non è bene che l'uomo sia solo" (Gen. 2.18), ha bisogno di vivere in società, di relazionarsi con gli altri per raggiungere il suo pieno sviluppo come persona. Creata a immagine e somiglianza di Dio (Gen. 1, 26-27), la persona umana è chiamata fin dall'inizio alla vita sociale.
La stessa conclusione è stata raggiunta da Platone a partire dalla ragione (La Repubblica) e Aristotele (La politica). Riprese secoli dopo rispettivamente da Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino e arricchite dalla Rivelazione, sono alla base del senso della vita e delle convinzioni morali dell'Occidente, della cultura europea.
La continuità di questa linea di pensiero non è stata pacifica. Autori, forse sopravvalutati, come Hobbes (XVII secolo) o Rousseau (XVIII secolo), hanno messo in discussione questa qualità differenziale della persona, la sua necessaria socievolezza. I loro approcci non sono stati molto coerenti, ma hanno aperto la strada ad altri modelli di pensiero, a partire dall'Illuminismo (XVIII secolo), che ha basato gli ideali della vita personale sulla natura e sulla ragione, sintetizzati nella scienza. La religione, la Rivelazione, è rimasta al di fuori della sfera sociale, racchiusa nella coscienza di ogni singolo individuo e senza legittimità di proporre la sua visione dell'uomo e della società.
Da questo punto in poi inizia una dinamica vertiginosa. Si parte dal contributo non mirato della scienza moderna, che mette in discussione la dignità e la libertà delle persone, per arrivare alla postmodernità, categoria che racchiude vari totalitarismi di un segno o dell'altro, che tentano di riscrivere la natura umana e la sua dignità e impongono l'annullamento civile di chi osa pensare in libertà senza farsi carico della storia ufficiale, che è poi quella della cultura. svegliato.
La Chiesa non è rimasta indifferente a queste correnti controculturali che riducono la dignità della persona. La prima enciclica papale a correggere la deriva politica e filosofica dei tempi moderni è stata quella di Gregorio XVI, Mirari vos (1832)A questa seguirà l'enciclica Quanta cura (1864) di Pio IX, su alcune forme di liberalismo, e la Pascendi (1907) di Pio Xcontro il modernismo.
Da questo punto in poi, la produzione dottrinale pontificia è continua. Tutto questo materiale, sotto forma di encicliche, allocuzioni, lettere, esortazioni apostoliche, discorsi e altri interventi, ha gradualmente formato un sistema di grande coerenza interna. All'inizio di questo secolo (2004), su impulso di Giovanni Paolo II, tutta questa dottrina, sistematizzata e ordinata per epigrafi, è stata raccolta nella Compendio della Dottrina sociale della Chiesa (DSI), un manuale che non appartiene al campo delle ideologie, ma a quello della teologia morale, per guidare la condotta di individui e organizzazioni di persone in tutti gli aspetti della vita sociale.
Se il Dottrina sociale della Chiesa è destinato a guidare il comportamento delle persone verso il loro pieno sviluppo, ogni associazione o gruppo sociale dovrebbe sentirsi interessato da esso, soprattutto le confraternite. In esse devono essere forniti i mezzi affinché l'uomo possa essere introdotto da Cristo nella vita trinitaria di Dio e partecipare alla sua comunione di vita e di amore, insieme agli altri uomini e donne nella comunione dei santi. "Che tutti siano una cosa sola come io e te siamo una cosa sola" (Gv 17, 1-22).
Nelle confraternite, i valori fondamentali della vita sociale - verità, libertà, giustizia e carità - devono essere promossi e vissuti in modo speciale; questa è la loro missione. Se una confraternita dovesse tagliare le radici interne del suo socialitasSe vivesse al di fuori della comunione con Dio nella Trinità, la sua strutturazione come gruppo sociale si snaturerebbe e si sgretolerebbe. Non sarebbe più un gruppo sociale, uno spazio di umanizzazione, ma un ambiente di dipendenza che si risolve nella dialettica potere-opposizione; che proclama la libertà, ma in cui l'egoismo ha la precedenza sul bene comune; che si concentra sull'attivismo a breve termine. Senza il ricorso a un vero Dio che garantisca l'individualità e la socievolezza, la fratellanza oscillerebbe tra il vuoto della solitudine individualistica e le false identità.
In ciascuna delle sue sezioni, il Dottrina sociale della Chiesa sembra essere stato progettato appositamente per la vita della fratellanza. Vale la pena conoscerlo, viverlo e diffonderlo.
Dottorato di ricerca in Amministrazione aziendale. Direttore dell'Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme. Fratello maggiore (2017-2020) della Confraternita di Soledad de San Lorenzo, a Siviglia. Ha pubblicato diversi libri, monografie e articoli sulle confraternite.
Maria Lia Zervino: "La WUCWO è un mosaico di donne unite da un comune amore per la Chiesa".
È una delle tre donne che, dal 13 luglio 2022, fa parte del Dicastero per i Vescovi e l'unica laica. Maria Lia Zervino, presidente dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, parla a Omnes di questa istituzione che rappresenta più di otto milioni di donne in tutto il mondo.
 "Le donne sono state guardate con una luce miope".
"Le donne sono state guardate con una luce miope". Nadia CoppaDobbiamo riflettere sul nuovo modo di presentare la vita consacrata delle donne".
Nadia CoppaDobbiamo riflettere sul nuovo modo di presentare la vita consacrata delle donne". Antonio Hernández DeusLe donne africane si distinguono per la loro speranza e il loro ottimismo".
Antonio Hernández DeusLe donne africane si distinguono per la loro speranza e il loro ottimismo".L'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche (UWCWO), fondata nel 1910, è oggi diffusa in tutti i continenti e conta più di otto milioni di donne aderenti, il cui scopo è sostenere programmi e progetti volti principalmente alla difesa e alla dignità della donna.
Da oltre 100 anni, l'organizzazione promuove e difende le donne in tutto il mondo, nei contesti sociali, politici ed economici più diversi. Maria Lia Zervino, presidente dell'organizzazione, che nel 2006 è stata riconosciuta dalla Santa Sede come Associazione Pubblica Internazionale dei Fedeli, spiega che è anche un motivo di orgoglio e di vanto per tutta la Chiesa.
"Fin dall'inizio, le donne fondatrici visionarie sono state presenti a livello internazionale. Nel 1928, queste donne lavoravano già nella Società delle Nazioni, nelle commissioni per la tratta delle donne e la protezione dei bambini. Il loro impatto e il loro prestigio, sia per la propagazione della fede che per la protezione della famiglia, erano tali che durante la seconda guerra mondiale dovettero bruciare i loro archivi per evitare le persecuzioni; purtroppo il loro Assistente Ecclesiastico morì a causa delle torture", sottolinea Zervino.
Un'azione ecclesiale fruttuosa che portò Paolo VI a "nominare presidente dell'organismo la spagnola Pilar Bellosillo, presente nel primo gruppo di uditrici del Concilio Vaticano II e di cui è in corso la causa di beatificazione", ricorda María Lía Zervino.
Quali sono gli obiettivi dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche e come è strutturata l'organizzazione per raggiungerli?
- La WUCWO si concentra sulla dignità delle donne. Il suo obiettivo è promuovere la presenza, la partecipazione e la corresponsabilità delle donne cattoliche nella società e nella Chiesa, affinché siano protagoniste, accanto agli uomini, dell'evangelizzazione e dello sviluppo umano integrale. Per questo motivo associa organizzazioni cattoliche (miste o esclusivamente femminili) che sono sempre rappresentate da una donna. Praticamente tutti i membri sono donne laiche, anche se molte religiose fanno parte delle loro organizzazioni, e riunisce anche associazioni di donne consacrate.
Chi fa parte di questa organizzazione?
- I delegati delle organizzazioni partecipano all'Assemblea generale ogni 4 anni ed eleggono democraticamente i membri del Consiglio. Questo organo collegiale vota i membri del Comitato esecutivo: i vicepresidenti di ogni regione e infine il presidente, che siede alla base della piramide. Gli organi direttivi che fanno parte della piramide rovesciata sono al servizio delle organizzazioni membri della WUCWO.
Anche il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è coinvolto in questo processo, in quanto può porre il veto su un candidato alla presidenza, ma non può scegliere chi ricoprirà tale carica.
La WUCWO è un osservatorio esistenziale delle donne nel mondo e un riflesso di ciò che accade nella Chiesa intera. La crescita maggiore della WUCWO si registra in Africa, mentre si nota un certo calo in alcuni Paesi europei, come avviene a livello di Chiesa globale. Le organizzazioni con il maggior numero di giovani donne si trovano nel continente africano e in alcuni Paesi dell'Asia-Pacifico e dell'America Latina.
Nella regione nordamericana, la situazione non è cambiata in modo significativo negli ultimi anni. Si può dire che la WUCWO sia un mosaico di culture di donne molto diverse tra loro, unite dal comune amore per la Chiesa e dal desiderio di applicare e contribuire ai suoi insegnamenti. Alle iniziative ecumeniche, dal 2019 si è aggiunto un percorso di dialogo con donne di altre fedi - che sono anche leader nelle rispettive comunità - e insieme celebrano ogni anno la Giornata internazionale della donna.
Quali sono gli obiettivi per il prossimo futuro?
- Gli obiettivi per il prossimo futuro sono tre: crescere nella sinodalità, creare sinergie con le donne dei Paesi in cui non è possibile associarsi e dare visibilità a quelle donne che sembrano invisibili.
Per quanto riguarda la sinodalità, l'obiettivo è duplice: da un lato, contribuire al Sinodo sulla sinodalità in ogni fase diocesana, continentale e universale e, dall'altro, incarnarlo all'interno dell'OMU.
Tra i compiti centrali da svolgere in stile sinodale c'è la preparazione dell'Incontro mondiale delle donne dell'UWC con Papa Francesco il 13 maggio 2023, che sarà la soglia da cui illuminare l'Assemblea generale che seguirà ad Assisi.
Per creare una sinergia con le donne cattoliche di alcuni Paesi, solitamente musulmani, i cui governi non permettono loro di associarsi, nell'ottobre di quest'anno terremo ad Atene il 3° Incontro con le donne del Medio Oriente e del Mediterraneo, un processo iniziato ad Amman (2013) e proseguito a Bari (2016). "Donne costruttrici di pace in una Chiesa all'uscita"sarà prioritario l'ascolto delle donne, oltre alla condivisione dell'aggiornamento della Amoris laetitia e sognare insieme lo scenario del dopo Covid 19, nel quadro di una cultura di pace.
Per dare visibilità alle donne in diverse parti del mondo, che di solito sembrano invisibili a molti a causa di quella che il Papa chiama la globalizzazione dell'indifferenza, la WUCWO ha creato l'Osservatorio mondiale delle donne nel 2021.

L'Osservatorio Globale delle Donne è stato recentemente lanciato: cos'è e quali sono i suoi obiettivi?
- Si tratta di un progetto nuovo e destinato a breve e lungo termine. Il motto dell'Osservatorio mondiale delle donne (WWO) è "Ascoltare per trasformare le vite".
Consiste proprio nell'ascoltare le donne di diverse regioni del mondo su un tema particolare, offrendo loro la possibilità di esprimersi e far sentire la propria voce. Raccogliere le loro esperienze di sofferenza e privazione, così come i loro punti di forza e le buone pratiche, per sistematizzarle in un formato con rigore accademico che permetta di diffonderle in un linguaggio accessibile.
La seconda fase del lavoro di ogni Osservatorio è la diffusione e la sensibilizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, al fine di ispirare e generare strategie pastorali da parte della Chiesa, sinergie da parte delle ONG della società civile, politiche pubbliche da parte degli Stati e contributi all'agenda internazionale che favoriscano lo sviluppo umano integrale delle donne e delle loro famiglie, comunità e popoli.
Il WWO vuole essere il punto di riferimento internazionale da cui rendere visibili e valutare le alternative di trasformazione in ambito femminile in diverse parti del mondo. La sua visione è integrale e universale, ossia si identifica con il magistero della Chiesa, in particolare con Laudato si' e con Fratelli tutti. È al servizio di tutte le strutture della Chiesa e di altre organizzazioni, comprese quelle non confessionali.
Questo Osservatorio, come primo atto, ha presentato un'indagine per conoscere l'impatto di Covid 19 sulle donne nel mondo. Quali sono stati i risultati?
- Il WWO ha svolto il suo primo lavoro Impatto della Covid-19 sulle donne in America Latina e nei Caraibi. Secondo gli studi raccolti, gli esperti consultati sul campo e le migliaia di indagini condotte, l'effetto principale della pandemia sulla situazione delle donne nella regione è stato l'approfondimento e l'aggravamento delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali strutturali preesistenti, come l'aumento della violenza di genere, il deterioramento dell'autonomia economica, l'aggravarsi della femminilizzazione della povertà, il deterioramento della salute fisica e mentale, l'aumento dei compiti di cura, le difficoltà di istruzione aggravate dalle differenze sociali, l'aumento del traffico di esseri umani e della criminalità organizzata, tra gli altri indicatori.
Sono emersi anche i loro punti di forza e di resilienza, come la reinvenzione di metodi di sussistenza per le loro famiglie e di commercializzazione dei loro prodotti, la creazione di reti di solidarietà per assistere gli anziani o i più bisognosi durante la pandemia, nuove forme di preghiera e di accompagnamento spirituale.
È emersa una serie di proposte creative, tra cui la formazione per la leadership femminile in tutti i settori, la rappresentanza delle donne negli spazi pubblici - puntando sulla collaborazione piuttosto che sulla competizione -, la ricerca e la divulgazione sulla violenza strutturale e simbolica, una strategia per la prevenzione della violenza, il lavoro fin dall'infanzia per la parità di diritti tra uomini e donne, il miglioramento dell'istruzione, compresa quella digitale, e la riforma dei sistemi di accesso alla giustizia per le donne più vulnerabili.
Come può l'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche aiutare le donne a trovare spazio e visibilità anche nel contesto ecclesiale?
- La WUCWO contribuisce alla formazione delle donne affinché possano trovare il loro posto e fornire un servizio di qualità nei vari settori della Chiesa. A tal fine, ha utilizzato intensamente i due anni della pandemia per formare le sue donne e i suoi collaboratori in inglese, spagnolo e francese sui principali temi del magistero attuale. Si è affidata all'insegnamento e all'accompagnamento di specialisti in ciascuno dei temi rilevanti per le sue risoluzioni del periodo attuale: la responsabilità verso l'ecologia integrale, la protezione della famiglia e in particolare dei suoi membri più vulnerabili, la violenza e la discriminazione contro le donne, l'educazione al cammino di santità.
"La parte bella che rende bella la vita". 16a domenica del Tempo Ordinario
Andrea Mardegan commenta le letture della XVI domenica del Tempo Ordinario e Luis Herrera propone una breve omelia video.
Gesù è grato per l'ospitalità di Marta, che lo accoglie nella sua casa e fa tutto il possibile perché lui, con i suoi discepoli, possa riposare e recuperare le forze. Gesù conosce bene Marta e Maria. Le due sorelle hanno con lui un rapporto semplice e diretto che vorremmo imitare. Si nota che hanno un carattere diverso: Marta è estroversa e sfrenata, Maria silenziosa e riflessiva.
Nel suo lavoro, a Marta accade qualcosa che può accadere a chiunque. Se siamo pressati dalle urgenze, dalle scadenze, dalla paura di non essere all'altezza del compito, dal desiderio di non sfigurare, dal non saper dare priorità a due richieste simultanee, possiamo perdere la pazienza, e allo stesso tempo perdere la giusta prospettiva delle cose e il senso del perché le facciamo.
Così ci mettiamo al centro della scena e cominciamo a protestare, anche se solo interiormente, con le persone da cui ci aspettiamo un aiuto che non arriva. Tutto è trascinato dall'impazienza: i fratelli, le sorelle, persino Dio che ci ha messo in questa situazione e non risponde alla preghiera come vorremmo, secondo il nostro comando.
Se poi ci capita, come è successo a Marta, che quando guardiamo la persona che dovrebbe capirci e aiutarci, scopriamo che si sta godendo la vita, facendo quello che noi vorremmo fare ma non possiamo, siamo sopraffatti dal vittimismo, esacerbato da un'invidia nascosta. Anche Marta avrebbe voluto sedersi ad ascoltare Gesù, ma pensa di non poterlo fare: ci sono troppe cose da fare.
Gesù ripete il suo nome due volte: "Marta, Marta"Lo stesso fa nel Vangelo di Luca con Simone, quando gli dice di aver pregato per lui prima di annunciare il suo rinnegamento, e con Gerusalemme, quando rivela alla città amata che avrebbe voluto radunare i suoi figli come una gallina raduna i suoi pulcini. È un modo per dirle con tenerezza che la ama così com'è.
Ama il suo carattere impetuoso, come ama il carattere mite di Maria.
Ama il suo lavoro di servizio, ma proprio per questo desidera per lui una felicità maggiore e più duratura, e così gli dà il rimedio: deve parlargli, come fa Maria, ascoltarlo, non perderlo di vista quando lavora per lui, amarlo come lui desidera essere amato.
Apprezza il suo cibo, ma gode di più della sua compagnia serena e del suo amore liberato dal suo ego prepotente: per tre volte ha parlato di sé in poche parole: "Mia sorella mi ha lasciato solo, dille di aiutarmi"..
La parte che Maria ha scelto può essere meglio tradotta dal greco come "la parte buona", senza confronto. È stare con Gesù, amarlo, prima del lavoro e durante il lavoro. Una parte che non si perde mai e che è capace di rendere buona ogni azione, ogni giorno, ogni lavoro, ogni servizio, ogni apostolato, ogni vita.
L'omelia sulle letture della domenica 16
Il sacerdote Luis Herrera Campo offre il suo nanomiliauna breve riflessione di un minuto per queste letture.
Tre prime donne nel Dicastero per i Vescovi
Suor Raffaella Petrini, suor Yvonne Reungoat e Maria Lia Zervino sono le prime tre donne ad entrare a far parte di questo Dicastero che, finora, aveva tra i suoi membri solo cardinali e vescovi, mentre tra i consultori c'erano solo prelati e sacerdoti.
Lo ha annunciato in un'intervista alla Reuters la scorsa settimana. Papa Francesco ha nominato oggi tre donne come membri del Dicastero per i Vescovi. Si tratta di suor Raffaella Petrini, segretaria generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, suor Yvonne Reungoat, ex superiora generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e Maria Lia Zervino, presidente dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche.
Due religiose e una laica parteciperanno quindi al processo di elezione dei nuovi pastori diocesani. Un sogno che si realizza per Maria Lia Zervino, quello di "una Chiesa con donne adeguate". Lei stessa ha scritto in una lettera pubblicata in traduzione inglese sulla rivista americana dei gesuiti: "Sogno una Chiesa che abbia donne adatte come giudici in tutti i tribunali in cui si trattano casi di matrimonio, nelle équipe di formazione di tutti i seminari e per l'esercizio di ministeri come l'ascolto, la direzione spirituale, la pastorale della salute, la cura del pianeta, la difesa dei diritti umani, ecc. Per i quali, per nostra natura, le donne sono ugualmente o talvolta più preparate degli uomini. Non solo le donne consacrate, ma tutte le donne laiche di tutte le regioni del mondo che sono pronte a servire. Rivolgendosi a Francesco, Zervino ha aggiunto: "E sogno che, durante il suo pontificato, inauguri, accanto ai sinodi dei vescovi, un altro sinodo: il sinodo del popolo di Dio, con una rappresentanza proporzionale di clero, consacrati, laici e donne. Non ci rallegreremo più solo perché una donna vota per la prima volta, ma perché molte donne laiche preparate, in comunione con tutti gli altri membri di questo sinodo, avranno dato il loro contributo e il loro voto si aggiungerà alle conclusioni che saranno poste nelle vostre mani. Probabilmente, Santo Padre, Lei ha già questa "carta nel suo mazzo" per mettere in pratica la sinodalità e sta solo aspettando il momento giusto per giocarla.
In occasione della citata intervista alla Reuters, in risposta a una domanda sulla presenza delle donne in Vaticano, alla luce della nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, il Pontefice aveva preannunciato la nomina di laici a capo di dicasteri come "quello dei laici, della famiglia e della vita, quello della cultura e dell'educazione, o la Biblioteca, che è quasi un dicastero".
Prima delle nomine odierne, il Dicastero per i Vescovi annoverava tra i suoi membri solo cardinali e vescovi, mentre i consultori comprendevano solo prelati e sacerdoti.
La scelta odierna di Francesco, quindi, va nella direzione di un rinnovamento delle istituzioni della Chiesa e della promozione di un modello più giusto e più vicino alle legittime aspirazioni di coloro che rappresentano la fonte della vita per eccellenza.
Tra le donne che occupano posizioni di rilievo nella Santa Sede c'erano la spagnola Carmen Ros Nortes, sottosegretario del Dicastero per i Religiosi, la francese Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, e la salesiana Suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Tra le donne laiche erano presenti Francesca Di Giovanni, sottosegretario per il settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, la professoressa argentina Emilce Cuda, segretaria della Pontificia Commissione per l'America Latina, Linda Ghisoni e Gabriella Gambino, entrambe sottosegretarie del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: e poi Barbara Jatta, prima donna direttrice dei Musei Vaticani; la slovena Nataša Govekar, responsabile della direzione teologico-pastorale del Dicastero per la Comunicazione; e la brasiliana Cristiane Murray, vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede. La professoressa tedesca Charlotte Kreuter-Kirchof è anche vice coordinatrice del Consiglio economico.
Pietro Angelo MuroniLa liturgia rivela il mistero e ci apre alla presenza di Cristo".
In questa intervista per Omnes, il professor Pietro Angelo Muroni, decano di teologia presso la Pontificia Università Urbaniana, delinea i punti chiave della Desiderio Desideravi, il documento sulla formazione liturgica di tutti i fedeli.
 La liturgia è un vero incontro con Cristo. Le idee centrali di "Desiderio desideravi".
La liturgia è un vero incontro con Cristo. Le idee centrali di "Desiderio desideravi". Liturgia al suono dei tamburi: il rito Zairé e l'Amazzonia
Liturgia al suono dei tamburi: il rito Zairé e l'AmazzoniaHo appena letto la recente lettera di Papa Francesco al popolo di Dio sulla liturgia, intitolata "Desiderio desideravi, Il professor Pietro Angelo Muroni, decano di teologia alla Pontificia Università Urbaniana, autore di numerosi libri di fede e spiritualità e sacerdote della diocesi di Sassari, è certo che l'importanza di questo documento risieda nel fatto che non è rivolto solo alla gerarchia ecclesiastica: "Riguarda - dice - tutto il popolo di Dio, perché la formazione liturgica deve riguardare tutti, deve coinvolgere tutti. Lo dice il Papa: la liturgia è la dimensione fondamentale per la vita della Chiesa". Tanto che, spiega don Muroni, la lettera "non vuole essere un trattato di teologia liturgica, non vuole avere un taglio accademico. Il Papa vuole invece che sia un elemento di riflessione per contemplare la bellezza e la verità della celebrazione cristiana".
Professore, quindi il Papa sta chiamando il popolo di Dio a tornare alla vera essenza della liturgia?
- Infatti. Il Papa invita il popolo di Dio a tornare allo spirito della liturgia, come lo definirebbe il teologo Romano Guardini. Non molto tempo fa, il Papa ha ricevuto in udienza i membri del Pontificio Istituto Liturgico in occasione del 60° anniversario della sua fondazione e ha detto loro: attenzione quando la liturgia diventa un campo di battaglia per questioni non essenziali o addirittura obsolete. Per questo motivo, il Pontefice, di fronte al pericolo della mondanità spirituale, di cui si è occupato anche nella sua prima esortazione apostolica Evangelii GaudiumIl Parlamento europeo vuole esortare tutti noi a considerare l'integrità di ciò che celebriamo.
Quali sono gli altri elementi importanti di questo documento?
- In primo luogo, si sottolinea che la liturgia è l'Opera di Dio, in cui Dio coinvolge l'uomo. Il punto 7 del Sacrosanctum Concilium Dice: in questa grande opera, in cui Dio, attraverso il rito, raggiunge l'uomo per salvarlo, Cristo unisce la sua Chiesa, la sua sposa. Pertanto, è Dio che ci raggiunge ma, allo stesso tempo, Dio coinvolge la Chiesa. Un altro elemento importante del documento è proprio l'invito a riscoprire la bellezza della liturgia. In questo senso, già nel Evangelii GaudiumPapa Francesco aveva sottolineato il fatto che la Chiesa evangelizza - ed evangelizza se stessa - attraverso la bellezza della liturgia.
Cosa intende il documento quando parla di bellezza?
- Una bellezza, spiega il Papa nella lettera, che non è la ricerca dell'estetismo, delle belle forme. Anche se, indubbiamente, il liturgia deve essere bello, non deve essere trascurato. La continua riscoperta della bellezza della liturgia significa la riscoperta della bellezza del mistero di Cristo celebrato nella liturgia. Dobbiamo arrivare a commuoverci per la liturgia, il che significa andare oltre la mera osservanza di regole e norme.
L'incarnazione è un altro elemento importante?
- Sì, perché l'incarnazione è il fondamento teologico della fede cristiana, ma anche di tutta la liturgia. Cioè, la liturgia non è disincarnata; la liturgia si esprime attraverso l'umanità dell'uomo e si esprime anche attraverso gesti, atteggiamenti, segni e simboli che fanno parte della vita dell'uomo.
È bello ciò che il Sacrosanctum Concilium al n. 83: Cristo, assumendo la natura umana, ha portato in questa terra d'esilio quel canto che è eternamente intonato nei luoghi celesti. L'incarnazione di Cristo diventa il vincolo con cui ci uniamo a Lui per unirci al Padre e alla Chiesa celeste.
Il documento approfondisce anche la riscoperta del significato del mistero?
- In effetti è così. Il Papa ci chiede di fare attenzione alla fumosa espressione "senso del mistero". A volte, sottolinea il Pontefice, la riforma liturgica del Concilio Vaticano II viene accusata di aver eliminato il senso del mistero nella celebrazione. Ma qual è, per noi, il mistero? La letteratura paolina ci spiega che il mistero di Dio è Cristo, Cristo stesso che ha rivelato il Padre.
È quindi ovvio che il liturgia per noi rimane trascendente, l'uomo non potrà mai penetrare a fondo in ciò che viene celebrato nella liturgia. Ma Cristo è venuto anche attraverso la liturgia, attraverso i sacramenti, per rivelarsi, non per nascondersi. La liturgia rivela il mistero e ci apre alla presenza di Cristo nella sua Parola, nelle specie eucaristiche, nel sacerdote, nel popolo di Dio.
La Carta parla anche di formazione: perché è importante?
- Se non c'è formazione liturgica, non si può capire con il cuore ciò che si sta celebrando. Se non capisco cosa sto facendo nella liturgia, mi è difficile rispettarla. La formazione è essenziale, soprattutto nei seminari. Temo che certe derive, come il pelagianesimo e lo gnosticismo, che si insinuano nella liturgia dipendano anche da una mancanza di formazione. Se educhiamo bene i futuri sacerdoti al vero significato della liturgia, avremo, di conseguenza, laici formati al vero significato della liturgia. Al contrario, avremo sacerdoti che vivono la liturgia come qualcosa da fare. Come dice il Papa in questa lettera, dobbiamo essere formati per la liturgia, ma anche essere formati con la liturgia.
Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica ucraina
L'arcivescovo Sviatoslav Shevchuk celebra una Divina Liturgia con i membri del Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica ucraina nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Przemysl, in Polonia, il 7 luglio 2022.
Il Papa potrebbe recarsi in Ucraina quest'estate?
 Il Papa invita a una formazione liturgica "seria e dinamica
Il Papa invita a una formazione liturgica "seria e dinamica Assisi e Matera ospiteranno Papa Francesco
Assisi e Matera ospiteranno Papa FrancescoSebbene il Vaticano non abbia rilasciato una dichiarazione ufficiale, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher ha affermato che il Vaticano sta valutando un possibile viaggio del Papa in Ucraina. Se così fosse, seguirebbe la sua visita in Canada alla fine di luglio.
Il desiderio del Papa è quello di recarsi nella zona invasa, anche se lo stesso Francesco ha detto che dovrebbe prima visitare Mosca.
AhOra potete usufruire di uno sconto di 20% sull'abbonamento a Rapporti di Roma Premiuml'agenzia di stampa internazionale specializzata nelle attività del Papa e del Vaticano.
Semplicità nella verità, il tratto distintivo di Papa Luciani
La vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, Stefania Falasca, ricorda con il sorriso la figura e l'opera del Papa, a pochi mesi dalla beatificazione del 4 settembre.
Traduzione dell'articolo in italiano
"La vicinanza, l'umiltà, la semplicità, la povertà e l'insistenza sulla misericordia e la tenerezza di Gesù: queste sono le caratteristiche più salienti del suo magistero, che hanno attratto più di 40 anni fa e sono più attuali che mai". Stefania Falasca, vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, ricorda la figura e l'opera del Il Papa del sorrisoLa beatificazione del Papa è prevista per il prossimo 4 settembre.
L'occasione è stata fornita dal consueto incontro che l'Associazione ISCOM promuove con vaticanisti e professionisti dell'informazione interessati all'attualità della Chiesa cattolica: una colazione di lavoro a cui hanno partecipato questa mattina una trentina di giornalisti dei media in una sede a due passi da San Pietro a Roma.
Falasca, vaticanista e scrittore, lavora dal 2006, quando si è conclusa l'indagine diocesana, come vicepostulatore per la causa di beatificazione di Giovanni Paolo IPasquale Liberatore e monsignor Enrico Dal Covolo, e poi il cardinale Beniamino Stella, che si sono succeduti nella carica fino ad oggi. Un lungo e impegnativo studio delle fonti documentarie su Albino Luciani, che l'ha portata a sottolineare, durante l'incontro dell'ISCOM, innanzitutto la "semplicità evangelica" del Papa, e la sua capacità di comunicare "la sostanza del Vangelo" a tutti, "nell'assoluta coincidenza tra ciò che ha insegnato e ciò che ha vissuto".
Un percorso di ben 15 anni, con ricerche che hanno coinvolto più di 70 archivi in luoghi diversi, di profondo significato storico e storiografico.
Subito dopo la sua morte", osserva Falasca, "fu il professor Vittore Branca, che fu vicino a Luciani negli anni del suo patriarcato a Venezia, a mettere a fuoco l'atteggiamento pastorale del Papa: una grande semplicità. Un Papa fedele alla dottrina di San Francesco di Sales, un santo che gli è stato molto caro fin dall'adolescenza, quando era solito leggere il libro di San Francesco di Sales. Filotea e il trattato sull'amore di Dio. Luciani è stato il pastore nutrito di sapienza umana, che ha vissuto tutte le virtù evangeliche. Un pastore che precede e vive nel gregge con l'esempio, senza alcuna separazione tra la vita spirituale e l'esercizio del governo".
Sul ruolo della Chiesa al servizio dell'umanità, vale la pena ricordare le parole dello stesso Luciani nell'omelia di inizio pontificato (3 settembre 1978): "La Chiesa, umile messaggera del Vangelo presso tutti i popoli della terra, contribuisca a creare un clima di giustizia, di fraternità, di solidarietà e di speranza, senza il quale il mondo non potrebbe vivere".
Più vicina al dolore della gente, "una Chiesa", conclude Falasca, "non autoreferenziale, che affonda le sue radici in quel tesoro mai dimenticato di una Chiesa antica, senza trionfi mondani, che vive della luce riflessa di Cristo". Vicino all'insegnamento dei grandi Padri e al quale il Concilio era tornato".
L'eredità del Concilio Vaticano II è dunque l'ispirazione e il segno di un pontificato di breve durata - un infarto pose fine alla vita di Luciani, secondo la ricostruzione della storia e della documentazione clinica, nonché delle deposizioni acquisite durante il processo - e al tempo stesso di rigorosa attualità. Ciò è testimoniato in modo eloquente dai sei "vogliamo" del messaggio radiofonico Urbi et orbi pronunciata in latino da Giovanni Paolo I all'indomani della sua elezione, il 27 agosto 1978.
Falasca li ricorda nel dettaglio: "Vogliamo continuare nella continuità dell'eredità del Concilio Vaticano II (...) l'impulso di rinnovamento e di vita"; "Vogliamo mantenere intatta la grande disciplina della Chiesa (...) sia nell'esercizio delle virtù evangeliche che nel servizio ai poveri, agli umili, agli indifesi (...). Vogliamo ricordare a tutta la Chiesa che il suo primo dovere è l'evangelizzazione (...). Vogliamo continuare l'impegno ecumenico con attenzione a tutto ciò che può favorire l'unione (...). Vogliamo continuare con pazienza e fermezza in quel dialogo sereno e costruttivo che Paolo VI ha posto come fondamento e programma della sua azione pastorale [...]. Infine, vogliamo incoraggiare tutte le iniziative che possono salvaguardare e aumentare la pace in un mondo tormentato".
Priorità che hanno alimentato i trentaquattro giorni di un trono pontificio dedicato alla collegialità episcopale, al servizio della povertà ecclesiale, alla ricerca dell'unità dei cristiani, al dialogo interreligioso e al confronto con il mondo contemporaneo, a favore della giustizia e della pace.
Prospettive che oggi risuonano chiaramente, secondo il parere del Vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I: "Queste sei vogliamo contribuiscono a mettere in evidenza un Papa come punto di riferimento nella storia della Chiesa universale. Alla luce delle carte degli archivi privati, dei testi e degli interventi del pontificato, è ora più facile approfondire le linee maestre del magistero di Albino Luciani per una Chiesa conciliare vicina alla gente e alla sua sete di carità".
Il giorno in cui nostro figlio ci ha detto: "Voglio diventare sacerdote".
Nel 2020 (ultimi dati offerti dalla CEE) sono stati ordinati in Spagna 125 sacerdoti. 125 storie di ragazzi che si donano a Dio per sempre. 125 storie di ragazzi che si donano a Dio per sempre... e 125 famiglie in cui anche padri, madri, fratelli, amici, fanno parte del cammino. Come vivono le famiglie la chiamata di un figlio? Cosa temono? Come accettano la volontà di Dio?
 "Nell'esercito, un sacerdote dà una ragione alla vita che è disposto a dare".
"Nell'esercito, un sacerdote dà una ragione alla vita che è disposto a dare". Papa Francesco spiega il ruolo del sacerdote in un importante congresso a Roma
Papa Francesco spiega il ruolo del sacerdote in un importante congresso a Roma Il sacerdote che amava la vita su ruote
Il sacerdote che amava la vita su ruoteMaría Luisa, Manuel, María José, Antonio, Julia... sono le madri e i padri che hanno visto come Dio è diventato corpo e sangue attraverso le parole pronunciate dai loro figli durante la Consacrazione del Santissimo Sacramento. Santa Messa. Famiglie normali e diverse, di aree rurali e urbane, con storie molto diverse, con più o meno figli, con più o meno vita ecclesiale... Ma unite dalla chiamata a cui i loro figli hanno risposto e a cui partecipano.
Uniti all'altare
Manuel e María José hanno due figli, uno dei quali, Antonio Jesús, è sacerdote presso l'Università di Roma. diocesi di Cádiz e Ceuta. Nel suo caso, c'è una particolarità: Manuel è un diacono permanente, condivide parte del ministero con suo figlio, cosa che vive con grande gioia.
La sua storia vocazionale è legata a una data: quel 24 giugno quando "dopo l'Eucaristia a cui partecipò tutta la famiglia, fummo presentati dal nostro parroco al nostro vescovo, monsignor Ceballos, per chiedere che Antonio Jesús entrasse in seminario e che io fossi ammesso a iniziare il cammino verso il diaconato".
Manuel e Antonio Jesús si incontrano come padre e figlio fisicamente, ma anche spiritualmente, soprattutto nelle celebrazioni in cui il diacono permanente assiste il sacerdote.
"Il giorno della sua prima Messa", ricorda Manuel, "è stato un momento pieno di significato e di sentimenti. Come diacono, ho chiesto la sua benedizione prima di leggere il Vangelo, come stabiliscono le norme liturgiche: "Padre, benedicimi", a mio figlio. Un momento che non dimenticherò mai e che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia si ripete e acquista lo stesso valore".
Quando Dio chiede il 100% di bambini
La famiglia Navarro Carmona, originaria di Cordoba, ha due figli maschi, entrambi sacerdoti diocesani. L'ingresso in seminario di Antonio, il maggiore, non li ha colti di sorpresa: "abbiamo visto il suo iter e l'abbiamo visto desideroso di andare avanti nel suo percorso; e il percorso non è stato facile, diremmo molto duro. Tuttavia, ha visto il lato positivo, ha riaffermato se stesso e la sua vocazione è cresciuta di fronte alle battute d'arresto".
La decisione di Juan Carlos, tuttavia, è stata un po' più lunga: "Abbiamo pensato che potesse fare qualcos'altro. Gli abbiamo offerto molte opzioni. Ricordo", racconta la madre, Julia, "che abbiamo parlato della vocazione di un medico, di guarire, di salvare vite... quando abbiamo finito di parlare, ha detto: 'Vuoi che faccia questa carriera? Lo farò io. Allora continuerò con quello che mi piace: voglio dedicarmi a curare le anime e a salvarle".
Siamo stati entusiasti di rispondere: "La vostra vocazione è forte, andate avanti". Suo marito, Antonio, sottolinea che la chiamata del loro secondo figlio sembrava, in effetti, "troppo per la nostra famiglia".
Tuttavia, non si sono opposti violentemente alla chiamata dei loro figli: "Crediamo nella libertà e nel diritto dei bambini di scegliere la loro vita. Non siamo d'accordo con nessuna imposizione, noi genitori non abbiamo il diritto di negare la decisione di Dio.
Forse per questo impegno a favore della libertà e della responsabilità personale dei giovani, alla domanda su cosa dire a chi si oppone all'ingresso dei figli in seminario, Antonio e Giulia sono chiari: "Il nostro consiglio è di ascoltare i vostri figli".
Con un futuro promettente come architetto, l'ingresso di Antonio Jesús in seminario fu accompagnato da molte incomprensioni. Come ricorda il padre, "ci sono stati alcuni commenti in famiglia, ci hanno chiesto perché lo abbiamo lasciato andare in seminario con quello che valeva... dopo che è diventato sacerdote, la maggior parte della famiglia è felice". Nella sua scuola, un suo compagno di classe, uno dei suoi insegnanti, mi disse che si rammaricava che lo avessimo lasciato andare in seminario con il valore accademico che aveva".
Reazioni normali da parte di chi non condivide o non capisce l'importanza della chiamata, e a cui questi genitori hanno risposto con una chiara analogia: "Quanti genitori, pur non essendo d'accordo con la scelta fatta dai loro figli, li difendono dicendo: 'se è felice, questo è l'importante'. Ebbene, allo stesso modo si può rispondere: non solo è felice, ma con la sua dedizione e testimonianza può rendere felici molte persone".
Ci sono anche incomprensioni più tenere, ricorda la coppia di Cadice, come la reazione della signora che si è occupata di lui fin da bambino mentre i genitori lavoravano. Quando le disse che aveva deciso di entrare in seminario perché si sentiva la chiamata, Gli chiesi: "Antonio, mio bellissimo, ma dimmi, chi è quello che ti chiama?
Un esercito di preghiere
In una lettera indirizzata alle madri dei sacerdoti quando era Prefetto della Congregazione per il Clero, il cardinale Mauro Picenza, ha sottolineato che "Ogni madre di un sacerdote è misteriosamente "figlia di suo figlio". Verso di lui può anche esercitare una nuova "maternità", nella vicinanza discreta, ma efficacissima e preziosa, della preghiera e nell'offerta della propria esistenza per il ministero del figlio. Sono un vero e proprio "esercito" che, dalla terra, innalza preghiere e offerte al Cielo e che, ancora più numeroso, dal Cielo intercede affinché ogni grazia si riversi sulla vita dei sacri pastori". Parole che potrebbero essere applicate al gruppo di madri di sacerdoti che, ogni mese a Madrid, si riuniscono per pregare per le vocazioni sacerdotali.
Un'iniziativa di Maria Luisa Bermejo, nata a seguito dell'ordinazione di suo figlio Yago, della Prelatura dell'Opus Dei. In quel periodo, Maria Luisa si è messa in contatto con altre madri di sacerdoti e ha avviato un gruppo di preghiera per le vocazioni sacerdotali: "Ho parlato con una mia amica che ha un figlio sacerdote diocesano. Insieme abbiamo pensato che potevamo fare "qualcosa di più" per i sacerdoti ed è nata l'idea di riunirci un giorno per pregare il Rosario per le vocazioni sacerdotali. Abbiamo condiviso l'idea con alcuni seminaristi diocesani che ci hanno messo in contatto con le loro madri ed è iniziata", quando le riunioni si sono riempite di nuovi membri.
"Abbiamo parlato con un sacerdote che ci ha suggerito di incontrarci in una chiesa per poter pregare meglio. Poi il rettore della Chiesa dello Spirito Santo di Madrid, D. Javier Cremades, ci ha dato tutto quello che poteva. Non solo ci ha permesso di venire una volta al mese a pregare il Rosario, ma ha anche iniziato a dire la Messa per noi e a guidarci nella preghiera.
Quel piccolo gruppo di madri di sacerdoti è cresciuto a poco a poco: "Eravamo quasi 70", ricorda María Luisa, che sottolinea che "ora siamo di meno, ma continuiamo con questo incontro". Ogni mese il figlio di uno dei sacerdoti viene a celebrare la Messa per noi e ci guida nella preghiera. Non solo preghiamo per i sacerdoti, ma abbiamo anche creato un'impressionante rete di amicizia tra di noi".
Le madri di questi sacerdoti hanno deciso di dare un nome alle loro preghiere: "Abbiamo deciso di fare una sorta di "amico invisibile di preghiera"", racconta María Luisa, "abbiamo scritto i nomi dei sacerdoti e delle loro madri su foglietti di carta, ognuna ha preso uno o due foglietti - non poteva essere suo figlio - e ha promesso di pregare per questi sacerdoti ogni giorno. Ne ho due, molto belli", conclude.

Questi padri e madri pregano per i loro figli, con "la gratitudine che la loro preghiera liturgica è una preghiera a 'due voci'", come sottolinea Manuel, ma pregano anche per coloro che nel loro ambiente trovano difficoltà a rispondere alla chiamata di Dio, per la loro fedeltà, per la loro perseveranza.
Paure e gioie
In una società in cui la figura del sacerdote è più che mai sotto i riflettori, questi genitori condividono i timori di chi ha un figlio che ricopre una carica pubblica. Come sottolinea Julia, "sono sempre sotto i riflettori: le loro decisioni, le loro azioni e i loro atti vengono esaminati" e c'è sempre il timore di un'interpretazione errata, o addirittura di un giudizio pubblico ingiusto... ma "le gioie sono immense e in abbondanza, perché questi bambini sono molto divertenti". Sappiamo che sono sempre lì a sostenerci con le loro preghiere e la loro presenza".
Maria José e Manuel si esprimono in modo molto simile quando sottolineano che "nella società di oggi, il solo fatto di dire che si è credenti garantisce critiche e disprezzo..... Tanto più se vostro figlio non solo dice di essere credente, ma anche, con la sua vita e il suo modo di vestire, proclama di essere un sacerdote. Non è raro vedere sguardi e commenti al suo passaggio, ma bisogna anche dire che altre persone si avvicinano a lui e gli chiedono confessione, consiglio, benedizione...".
Ma quella stessa manifestazione porta con sé molti aneddoti di "incontri casuali" con la Chiesa, come quando "in uno dei suoi viaggi da Madrid - dove studiava Teologia Morale - a Cadice, il treno si fermò in mezzo alla campagna e alcuni passeggeri si rivolsero a lui chiedendo "padre, preghi per noi per uscire da questa situazione".
Papa Francesco Chiediamo a Dio di farci vedere e di avere compassione".
Il Papa ha ricordato ancora una volta la necessità di toccare e guardare negli occhi i più poveri tra i poveri in questa XV Domenica del Tempo Ordinario, in cui la parabola del Buon Samaritano è stata al centro del Vangelo e delle parole del Papa all'Angelus.
"Il samaritano, pur avendo i suoi progetti e dirigendosi verso una meta lontana, non cerca scuse" per non aver curato lo straniero ferito sulla strada. Così il Santo Padre ha iniziato il commento all'Angelus di domenica 10 luglio 2022. Un invito a tutti i cristiani a vivere con gli occhi "puntati sulla meta finale, ma allo stesso tempo attenti ai passi da compiere, qui e ora, per raggiungerla".
La parabola del Buon Samaritano narrata oggi nel Vangelo della XV Domenica del Tempo Ordinario ha dato a Francesco l'opportunità di ricordare che uno dei soprannomi dei primi cristiani era "il Buon Samaritano". "discepoli della Viano". Infatti", ha affermato il Papa, "il credente è molto simile al Samaritano: come lui, è in cammino (...) Segue il Signore, che non è sedentario ma sempre in cammino: sulla strada incontra la gente, guarisce i malati, visita villaggi e città. Così ha agito il Signore, sempre in cammino".
L'esempio di Cristo, il Buon Samaritano, è quello da seguire per i cristiani che "camminando sulle orme di Cristo, diventano viandanti e imparano - come il Samaritano - a vedere e a avere compassione. Vedere e sentire la compassione. Innanzitutto, vai aCi apre gli occhi sulla realtà. Il Vangelo ci insegna a vedere: guida ciascuno di noi a comprendere correttamente la realtà, superando giorno dopo giorno idee preconcette e dogmatismi", ha sottolineato il Papa.
La compassione è un dono
Francesco ha sottolineato che "di fronte a questa parabola evangelica, può accadere che ci si incolpi o ci si colpevolizzi, che si punti il dito contro gli altri, paragonandoli al sacerdote e al levita: 'Questo e quello passano, non si fermano'; oppure che ci si colpevolizzi elencando le proprie mancanze nel prendersi cura del prossimo".
Due atteggiamenti che, seppur naturali, il Papa ci ha incoraggiato a superare con un altro esercizio: riconoscere i nostri errori e, soprattutto, chiedere al Signore "che ci renda vedere e avere compassione. Questa è una grazia, dobbiamo chiederla al Signore".
In questo senso, il Papa ha sottolineato ancora una volta che dobbiamo guardare negli occhi il nostro prossimo, soprattutto i più poveri e vulnerabili: "Toccate la mano della persona a cui date la moneta? -No, no, lo lascio cadere". -E guardate quella persona negli occhi? -No, non ci penso. Se fate l'elemosina senza toccare la realtà, senza guardare negli occhi la persona bisognosa, quell'elemosina è per voi, non per lui. Pensate a questo: "Tocco le miserie, anche quelle che aiuto? Guardo negli occhi le persone che soffrono, le persone che aiuto? Vi lascio con questo pensiero: vedere e avere compassione.
Ricordo la Libia, lo Sri Lanka e l'Ucraina.
Le instabilità e i problemi che affliggono le nazioni dello Sri Lanka e della Libia sono stati ricordati dal Papa nelle sue parole dopo l'Angelus, in cui ha avuto parole anche per la popolazione dell'Ucraina "tormentata quotidianamente da attacchi brutali le cui conseguenze sono pagate dalla gente comune". Prego per tutte le famiglie, soprattutto per le vittime".
Il Papa ha concluso con un ricordo dei lavoratori e dei cappellani del mare la Domenica del Mare e ha ricordato "tutti i marittimi con stima e gratitudine per il loro prezioso lavoro, così come i cappellani e i volontari di "Stella Maris". Affido alla Madonna i marittimi che sono bloccati nelle zone di guerra, affinché possano tornare a casa".
José M. BarrioAprire spazi di dialogo, un'urgenza universitaria".
In un'intervista a Omnes, José María Barrio Maestre, professore all'Università Complutense di Madrid e dottore di ricerca in Filosofia, afferma che "ripristinare il prestigio della verità e renderla di nuovo una cosa molto importante per gli esseri umani", in altre parole, "aprire spazi di dialogo vero, rispettoso e con argomenti", è "la principale urgenza dell'Università".
 Recuperare l'essenza del dialogo all'Università
Recuperare l'essenza del dialogo all'Università Santiago Leyra-CuriáRead more : "Le nuove generazioni vogliono essere educate per non essere manipolate".
Santiago Leyra-CuriáRead more : "Le nuove generazioni vogliono essere educate per non essere manipolate". José María TorralbaUn cristianesimo con una mentalità borghese è problematico".
José María TorralbaUn cristianesimo con una mentalità borghese è problematico".Un rapporto pubblicato a Vienna da IOPDAC Europa, il vostro partner latinoamericano OLIRE e il IIRF (Istituto Internazionale per la Libertà Religiosa), sull'autocensura tra i cristiani, ha mostrato un grado avanzato di pressione sociale guidata dall'intolleranza. Una delle autrici, Friederike Boellmann, ha sottolineato che "il caso tedesco rivela che le università sono l'ambiente più ostile. E il più alto grado di autocensura che ho trovato nella mia ricerca in ambito accademico.
Quasi parallelamente agli studi contenuti nel rapporto citato, José María Barrio, professore all'Università Complutense di Madrid, ha scritto un'ampia articolocon questo titolo significativo: La verità è ancora molto importante, anche all'Università".. A suo avviso, "la società ha il diritto di aspettarsi dall'Università un'offerta di persone che sappiano discutere in modo rispettoso, con argomentazioni, e che prendano sul serio i loro interlocutori, anche quando questi esprimono argomenti contrari ai propri". In questo settore, l'Università ha un ruolo difficilmente sostituibile.
C'è "un virus che sta corrodendo l'università fin da Bologna", dice. Ha scoraggiato "la discussione razionale, che è proprio uno dei compiti principali per cui l'Università è stata fondata, sulla scia dell'Accademia che Platone fondò ad Atene e sulla cui scia si sono registrati alcuni dei più importanti progressi della cultura occidentale".
In conversazione con José María Barrio, emergono temi di attualità e nomi come Millán-Puelles, Juan Arana e Alejandro Llano, ma anche Deresiewicz, Derrick e Jürgen Habermas.
Professore, cosa ha motivato la sua riflessione sulla verità nell'ambiente universitario?
Ho l'impressione che in molti ambiti universitari la razionalità dialettica rischi di scomparire a favore di una razionalità meramente strumentale e tecnocratica. Se una caratteristica può identificare ciò che l'università si è prefissata nel corso della sua storia e ciò che costituisce il suo obiettivo, allora è possibile che la sua storia sia stata un'altra. natura- almeno quello che è "nato" per essere - è la pretesa di essere uno spazio adatto alla discussione con ragioni, con argomenti logicamente ben articolati e retoricamente ben presentati. Ma le pressioni esterne all'Università introducono l'"anti-logica" della "escrache", della cancellazione di certi discorsi, dovuta a interessi ideologici del tutto estranei all'interesse per la verità.
Ci sono questioni di importanza teorica, antropologica, politica o sociale di cui è sempre più difficile parlare, e ci sono agenzie che si arrogano l'autorità di decidere di cosa si deve e cosa non si deve parlare nell'università e, di ciò che si parla, cosa si deve dire e cosa si deve tacere. Queste restrizioni mentali sono anti-accademiche, anti-universitarie e anti-intellettuali. Il veto alla discrepanza da parte di chi distribuisce tessere democratiche o omofobe, come se fossero tori e anatemi, non solo è incongruo in un'università pubblica, ma è anche culturalmente scadente e mentalmente insalubre. È tirannico. Ed è la campana a morto dell'università.
Lei ha parlato della menzogna come arma rivoluzionaria e ha scritto che la verità non conta più, che è stata sostituita dalla post-verità. Anche nel Processo di Bologna il termine verità è scomparso.
Naturalmente non sto dicendo questo. Deploro piuttosto che qualcuno dica questo sapendo cosa sta dicendo. Lenin ha inventato la menzogna come arma rivoluzionaria, ed è stata rivitalizzata da alcuni che cercano di emularlo, come Pablo Iglesias in Spagna.
Il fatto che nei documenti di Bologna non si parli di verità, o che il dizionario Oxonian abbia autorizzato quella parola infettiva, "post-verità", è senza dubbio un sintomo che qualcosa non va nell'Università. Ma finché gli esseri umani rimarranno animale razionale La verità continuerà ad essere importante per lui, perché la ragione non si limita a contare i voti, i soldi o le piace. È anche una facoltà di conoscenza, e conoscere è riconoscere ciò che le cose sono realmente; altrimenti si dovrebbe parlare piuttosto di ignoranza, non di scienza ma di nescienza.
Come professore di filosofia, non si fa scrupolo di prendere di mira le prestigiose università americane e la loro visione antropologica.
Non sono l'unico ad aver sottolineato questo punto dolente. Credo che sia stato sottolineato in modo molto più competente dal professore americano di letteratura inglese William Deresiewicz nel suo recente libro Il gregge è eccellente, che consiglio vivamente a chiunque sia interessato a questo processo che sta trasformando l'università in una fabbrica di anime di paglia.
Lei parla di un processo di demolizione dell'università. Cosa pensa della visione dell'università e delle sfide che i professori universitari devono affrontare, così come sono state esposte da professori come Millán-Puelles e Juan Arana?
Tra i tanti, citerei anche Alejandro Llano, anch'egli professore in pensione. Temo che, a meno che lo stato attuale delle cose non subisca una svolta molto radicale, l'università dovrà essere ricostruita al di fuori degli attuali campus. Esistono, tuttavia, eccezioni eclatanti. Consiglio la lettura del libro di Christopher Derrick intitolato Rifuggire dallo scetticismo: l'educazione liberale come se la verità contasse qualcosa. Racconta un'esperienza vissuta, durante un periodo sabbatico, in un campus americano in un momento in cui era assalito da uno scoraggiamento che colpisce molte persone oggi.
Da parte mia, conosco università in Sud America dove si coltiva ancora una genuina sensibilità universitaria. Una caratteristica che li identifica è che non si preoccupano solo che i loro laureati "abbiano successo" nella sfera lavorativa e socio-economica. Naturalmente non sono insensibili a tutto ciò. Ma soprattutto aspirano a poter nutrire la fondata speranza di non essere mai coinvolti in pratiche fraudolente o corrotte.
Ascoltiamo una breve riflessione sugli inizi delle università e della teologia.
Le prime università sono state fondate per raccogliere l'eredità e continuare la stirpe dell'Accademia fondata da Platone ad Atene, e il loro embrione originale è stato quello delle scuole cattedrali nell'alto Medioevo in Europa. Proprio l'alto potenziale autocritico della teologia cristiana è stato il catalizzatore iniziale delle più importanti ricerche e riflessioni accademiche e, naturalmente, l'ha spinta ad aprirsi a nuovi orizzonti e prospettive umanistiche, scientifiche, sociali e artistiche, e persino all'orizzonte della tecnologia.
Il giornalismo viene difeso come elemento di controllo del potere, attraverso la verità, e poi arriva la delusione di percepire, secondo altri, che è piuttosto intossicato dal potere. Come vede questo problema?
̶ Quella parola infelice, post-verità, è stato originariamente coniato per indicare una realtà socio-culturale che si è fatta strada soprattutto nel mondo della comunicazione e, soprattutto, con la nascita dei social network.
Il fenomeno, in fondo, è l'impressione diffusa che nei processi di formazione dell'opinione pubblica non contino più i dati oggettivi quanto le narrazioni, le "storie" e soprattutto gli elementi emotivi che sono in grado di suscitare nel pubblico. Qualcosa di simile sta accadendo con i social network: sembra che l'importante sia farsi sentire, e ciò che è meno importante è verificare la validità di ciò che si dice. Molte reti sono diventate - forse lo erano fin dall'inizio - dei meri aggregatori di persone che hanno gli stessi pregiudizi e che non sembrano affatto voler uscire da questi e trasformarli in giudizi.
Che gli esseri umani non siano pura ragione con le gambe, ma siano piuttosto impressionabili - una canna scossa dal vento, come diceva Pascal - non è stato scoperto l'altro ieri. Ma ciò che trovo più patetico in questo caso non sono gli ingredienti ideologici o l'ornamento emotivo delle storie - probabilmente non c'è sempre una maliziosa intenzione di ingannare - ma la poca attenzione, la frivolezza, la superficialità e la totale assenza di contrasto critico con cui vengono liquidate molte informazioni che meriterebbero una certa serietà.

Secondo lei, qual è, e quale dovrebbe essere, il vero contributo dell'università alla società? Lei sottolinea che il ripristino del prestigio della verità è la priorità principale dell'università, giusto?
Giusto. Ripristinare il prestigio della verità, in breve, ripristinarla come qualcosa di molto importante per gli esseri umani, significa aprire spazi per il vero dialogo, che è qualcosa che rischia seriamente di estinguersi tra noi. Si discute molto ma si discute poco. La discussione ha senso solo se c'è una o più verità e se c'è la possibilità, nei limiti di tutto ciò che è umano, di avvicinarsi ad esse. Al contrario, se la verità non esiste, o è completamente inaccessibile alla ragione, che senso ha la discussione? Come ha detto Jürgen Habermas in più di un'occasione, la discussione è una prassi significativa solo come ricerca cooperativa della verità. (kooperativen Wahrheitssuche), spesso della soluzione reale a un problema pratico.
La società ha il diritto di aspettarsi dall'università un'offerta di persone che sappiano discutere in modo rispettoso, con argomenti, e che prendano sul serio i loro interlocutori, anche quando questi esprimono argomenti contrari ai loro. Nello spazio civile e socio-politico c'è bisogno di persone disposte a contribuire al bene comune in ambienti cooperativi e di discussione seria. In questo settore, l'università ha un ruolo difficilmente sostituibile.
Se la sfida dell'istruzione universitaria fosse la pura formazione professionale, finalizzata alla formazione di manager efficaci che applicano i protocolli, potremmo raggiungere questo obiettivo in modo molto più efficace e rapido, risparmiandoci un'istituzione molto costosa. Ciò che non si improvvisa è che le persone siano in grado di pensare in profondità e con rigore, e che sappiano affrontare problemi complessi e sfaccettati, con molte sfaccettature, anche umane, che non possono essere affrontati solo premendo pulsanti, con la burocrazia o con le prescrizioni.
Confondiamo la leadership con una mediocre tecnocrazia. Sono i mediocri che riescono a prosperare che finiscono per comandare, non i migliori o i più intelligenti. Questo è il virus che sta corrodendo l'Università da Bologna in poi.
Concludiamo. Il professor Barrio cerca di mostrare nella sua esposizione "alcuni elementi tossici dell'atmosfera socio-culturale che hanno un'influenza negativa sul lavoro dell'Università, e che portano a perdere il riferimento del valore che la verità ha per l'essere umano". Per chi volesse saperne di più, è possibile leggere e scaricare gratuitamente il suo testo al link Vista di La verità è ancora molto importante, anche all'Università (usal.es) Il riferimento tecnico è Teoria dell'educazione. Rivista interuniversitaria, 34(2), 63-85. https://doi.org/10.14201/teri.27524.