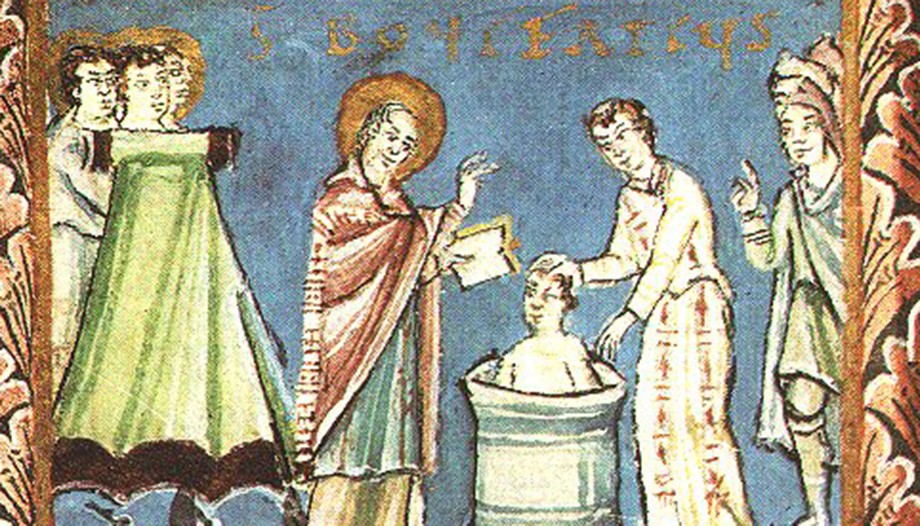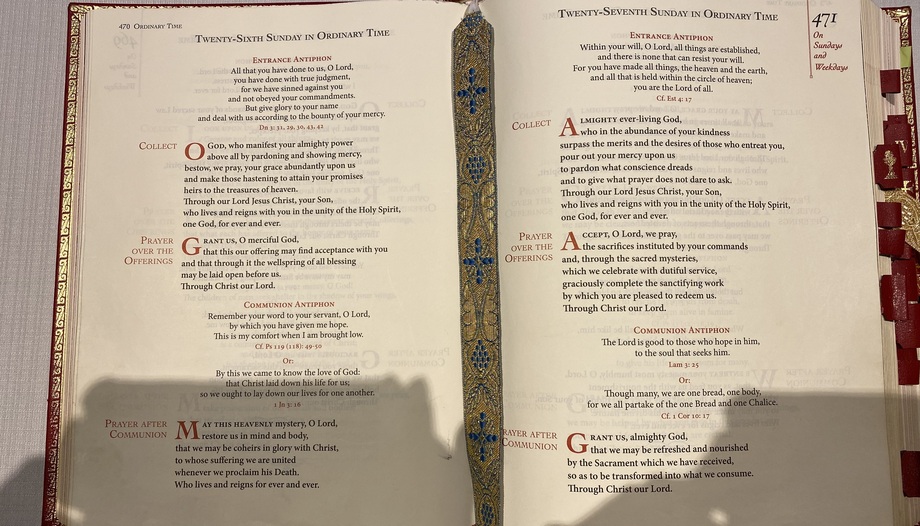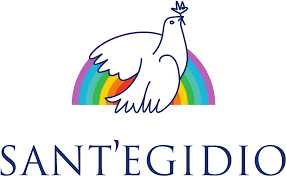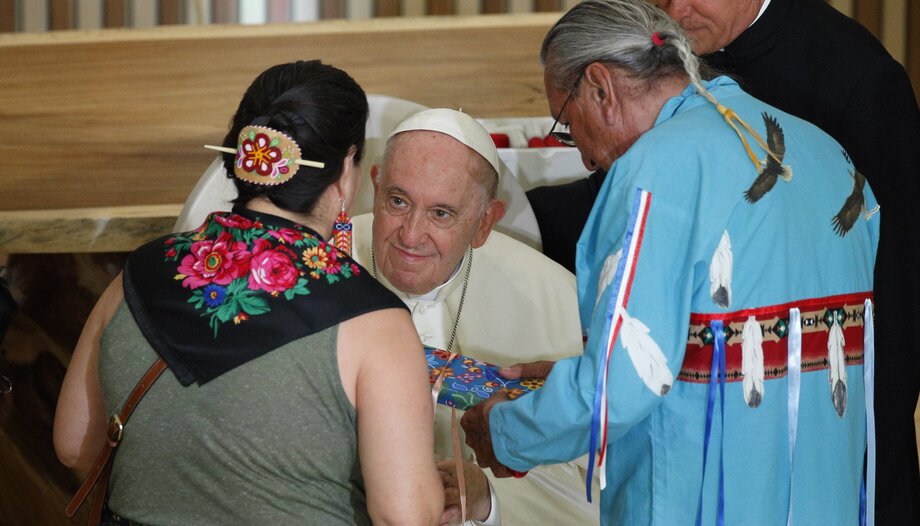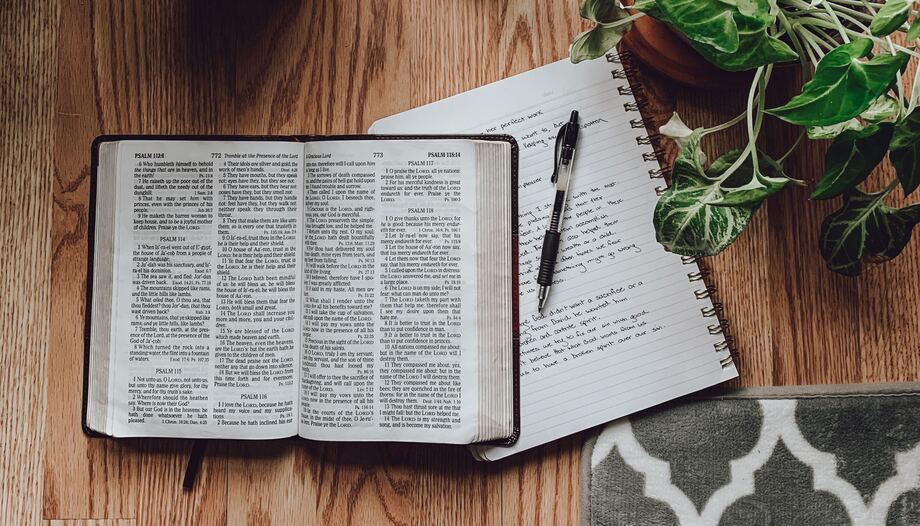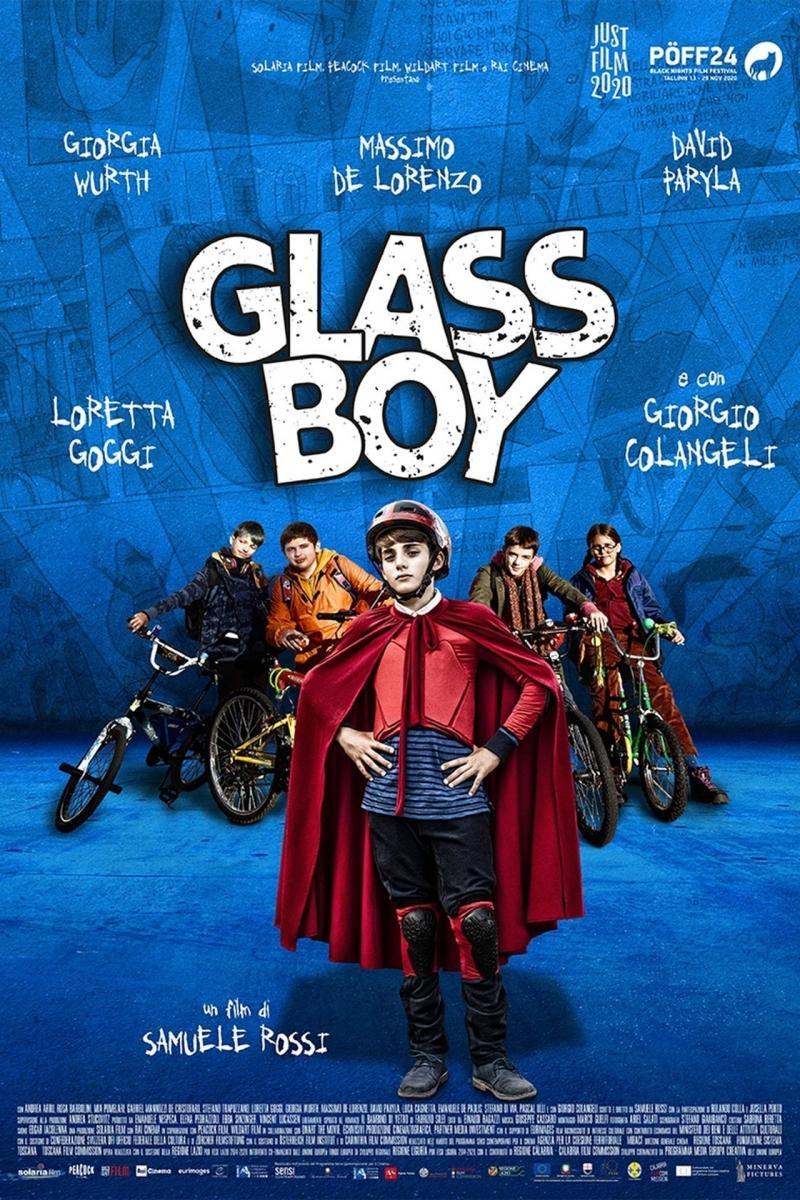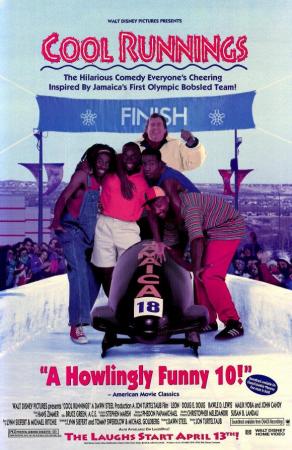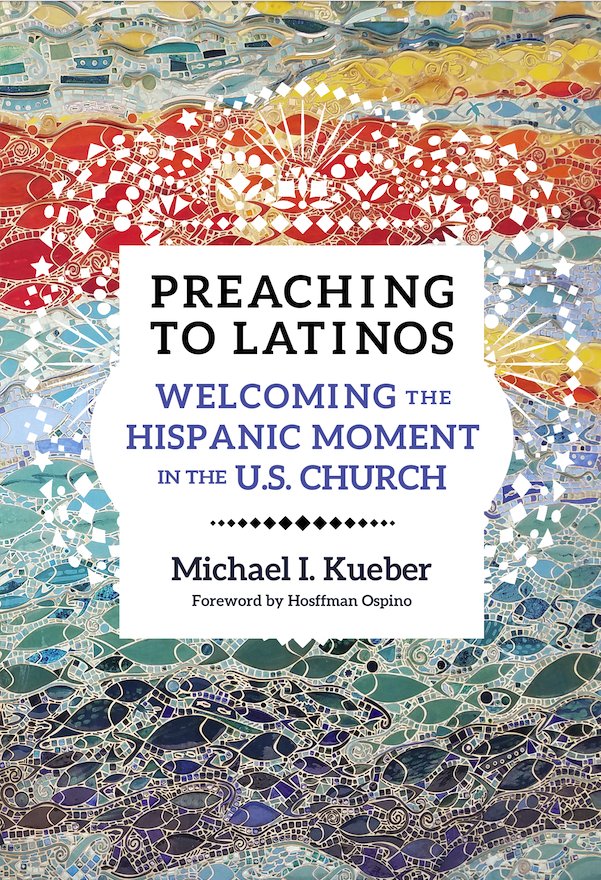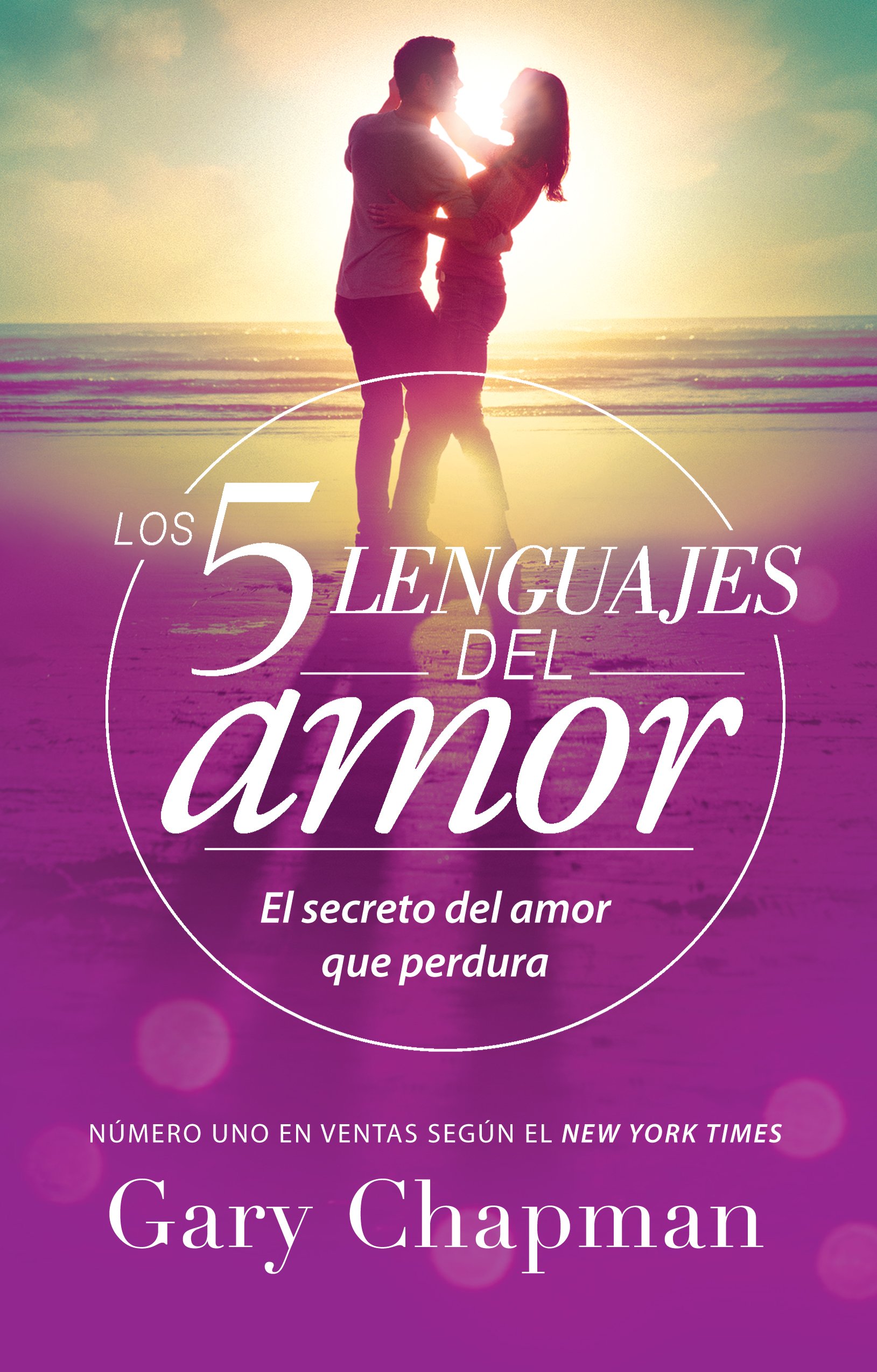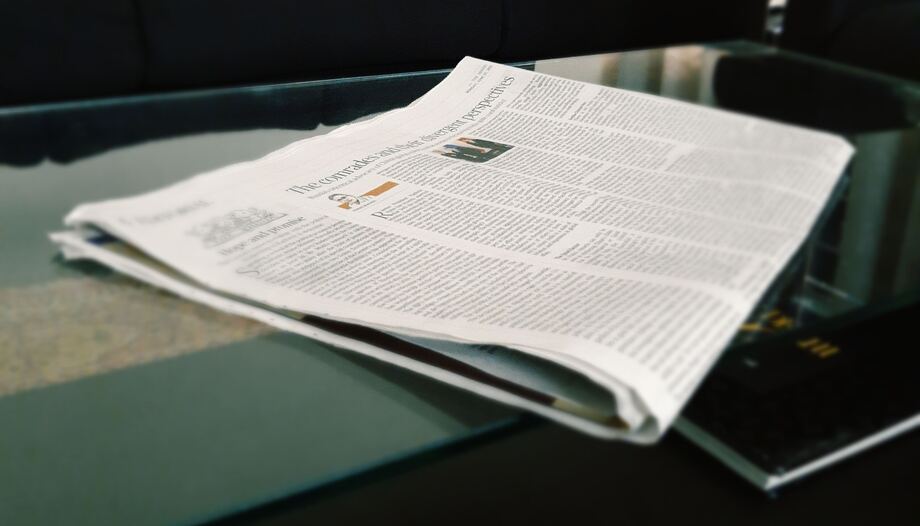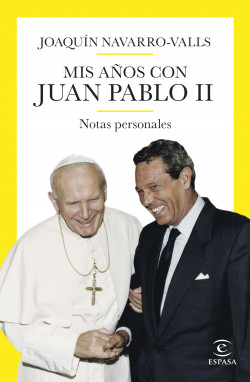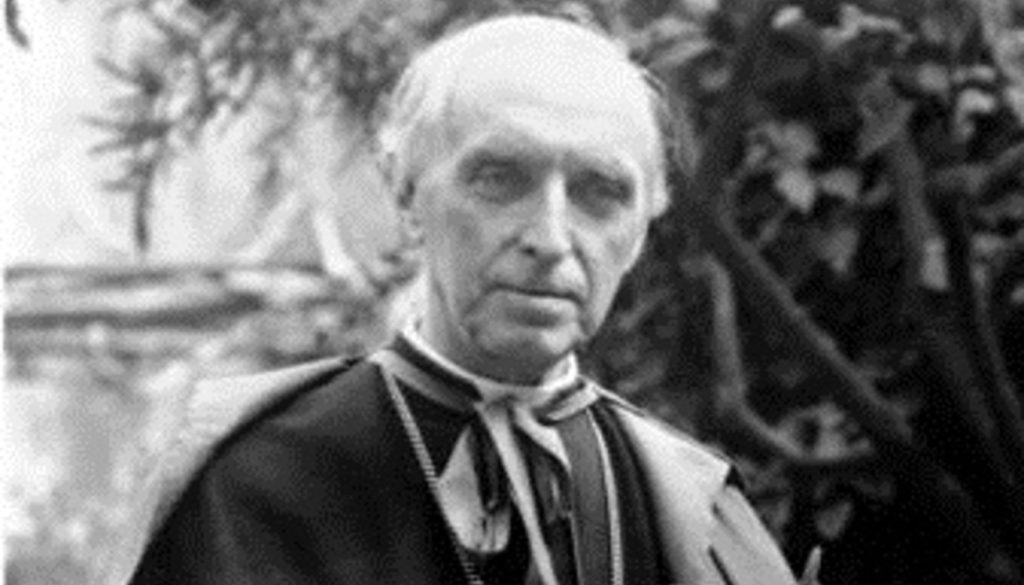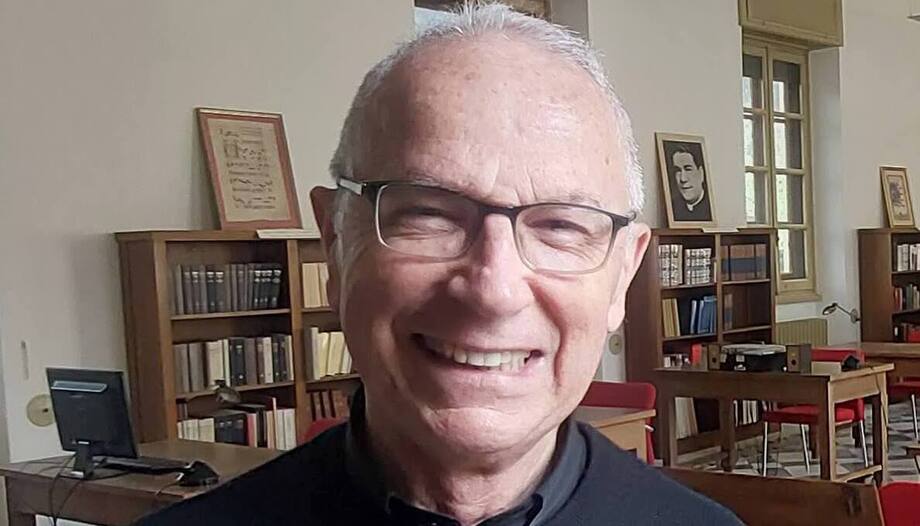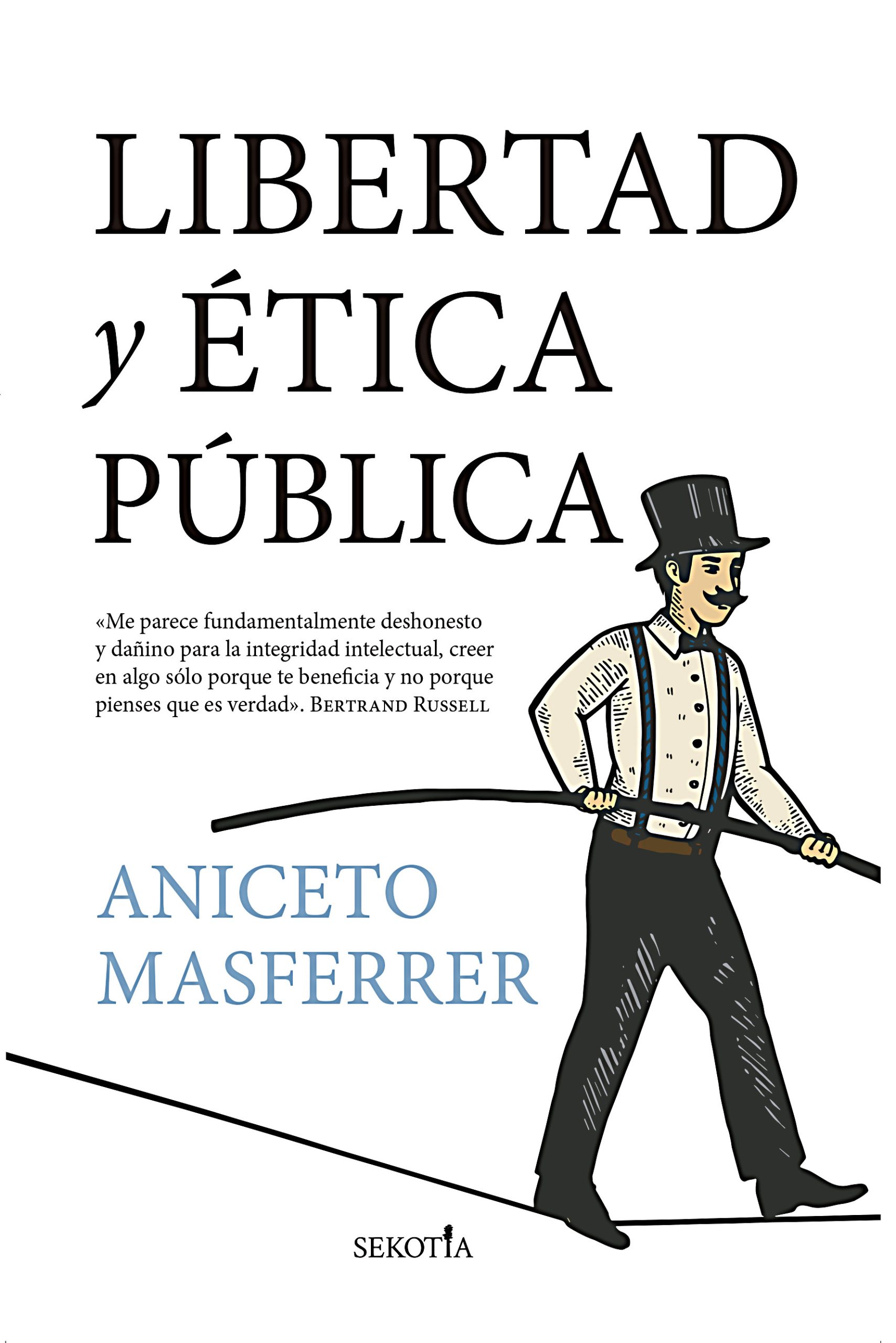"La stragrande maggioranza preferisce non dover vincere la pigrizia o la paura di pensare con la propria testa, né assumersi i rischi che comporta, come la possibilità di sbagliare, di essere smascherati e di dover rettificare", afferma il professor Aniceto Masferrer (Girona, Spagna, 1971), docente di Storia del Diritto e delle Istituzioni all'Università di Valencia, nel suo recente libro, Libertà ed etica pubblica.
Parlare con Aniceto Masferrer richiede onestà intellettuale. E anche leggerlo, perché sostiene che "una società è più matura e democratica quando i suoi individui sono capaci di rafforzare i legami di amicizia anche con chi non la pensa come loro, di vedere chi non è d'accordo con le loro idee come qualcuno che li aiuta e li arricchisce, e non come un fastidio o un ostacolo alla loro realizzazione personale".
Nell'intervista, l'intellettuale fa riferimento a iniziative di giovani che promuovono la creazione di spazi per la libera espressione delle idee, il dialogo e le relazioni interpersonali. (@FreeThinkers.fu, È tempo di pensare, Siamo cercatoritra gli altri).
Di questi e di altri temi, come la guerra in Ucraina, abbiamo parlato con Aniceto Masferrer, ricercatore e Professore presso università europee, americane e dell'Oceania e autore prolifico.
La libertà è il tema centrale del suo recente libro "Libertà ed etica pubblica".
-Penso che una vita non sarebbe veramente umana se rinunciasse ad amare in libertà, non sarebbe veramente libera se ignorasse la verità e non potrebbe accedere alla verità se non pensasse con la propria testa. La libertà è una caratteristica fondamentale dell'essere umano. Una vita umana senza libertà non è affatto una vita.
Secondo il mito postmoderno della libertà, ciò che si vuole è buono e ciò che non si vuole è cattivo. Non si accetta che qualcosa che si vuole veramente possa essere cattivo, né che qualcosa che non si vuole veramente possa essere buono. Ed è un "mito" perché la realtà stessa smentisce questo approccio. Come diceva Ortega y Gasset, "ogni realtà ignorata prepara la sua vendetta".
E il suo discepolo Julián Marías Egli ha sottolineato che "si può essere 'in buona fede' nella convinzione che 2 e 2 facciano 5. Il brutto è che quando si agisce secondo questa convinzione, si inciampa nella realtà, perché essa non tollera le falsità e si vendica sempre su di esse. È da qui che nasce il fallimento della vita.
È vero che, come osservato da T. S. Eliot, che "la razza umana non può sopportare molta realtà", ma alcuni sembrano essere incapaci di sopportare qualsiasi realtà o verità che non coincida con i loro desideri e interessi personali, un atteggiamento criticato da Bertrand RussellTrovo fondamentalmente disonesto e dannoso per l'integrità intellettuale credere a qualcosa solo perché ci fa comodo e non perché pensiamo che sia vero.
Nella presentazione lei ha fatto riferimento alla necessità di stimolare il pensiero critico: perché questa convinzione?
-La stragrande maggioranza preferisce non dover vincere la pigrizia o la paura di dover pensare con la propria testa, o di assumersi i rischi che comporta, come la possibilità di sbagliare, di essere smascherati e di dover rettificare. Una parte importante dei cittadini preferisce far parte di quella massa amorfa di cui parlava Ortega y Gasset (La ribellione delle masse), privo di personalità, che non pensa da solo ma ha bisogno di essere pensato da un'altra persona o da un collettivo - a volte vittimizzato -, limitandosi a imitare e riprodurre ciò che vede negli altri.
Chi non pensa con la propria testa rinuncia a essere se stesso e cede la propria libertà, sentendosi protetto da una comunità anonima dalla quale non osa più dissentire. Diventa un cadavere vivente perché non è più se stessa, non è nemmeno in grado di pensare di essere la persona che vorrebbe davvero diventare. È la nuova cittadinanza che, credendo di godere di una libertà che corre ai margini della realtà, genera disillusione, vuoto, ansia e frustrazione.
Libertà ed etica pubblica
AutoreAniceto Masferrer
Editoriale: Sekotia
Pagine: 272
Anno: 2022
Si riferisce anche alla promozione del dialogo, in particolare con chi la pensa diversamente. D'altra parte, l'escalation della guerra in Ucraina continua.
-Gli esseri umani hanno una tendenza al settarismo, che li porta a pensare di sapere tutto. di altri, o che l'appartenenza a un gruppo vi renda migliori degli altri. Ci risulta difficile accettare che la verità, la bellezza e la giustizia non sono patrimonio esclusivo di nessuno. Nessuno possiede tutta la verità, ma solo parti di essa. Forse sarebbe ancora più corretto dire che è la verità a possedere qualcuno. Ma non può possedere chi non dialoga, chi non è capace di prendere sul serio le ragioni di chi non la pensa come lui.
Ci sono tre modi per accedere alla conoscenza della realtà: l'osservazione, la riflessione e il dialogo. Senza dialogo non c'è conoscenza della realtà, né possibilità di progredire o avanzare come società. Da qui l'importanza di incoraggiare il pensiero critico e l'espressione delle proprie idee in un clima di rispetto per tutti, e in particolare per chi la pensa diversamente. Altrimenti, il dialogo non è possibile. E senza dialogo non può esistere una convivenza pacifica a tutti i livelli (familiare, sociale, nazionale o tra nazioni). Quando non c'è dialogo, le differenze si risolvono con la semplice somma dei voti o con la violenza. E il risultato è spesso l'irragionevolezza e la morte - sia civile che naturale - delle persone, come sta accadendo a Ucraina e in tanti altri paesi del mondo.
Nel suo libro sottolinea che la libertà di espressione, compreso il dissenso, e una cultura del dialogo sono fondamentali per salvaguardare la democrazia...
-Il disaccordo è necessario per una ragione di educazione elementare e per un'altra di buon senso nella coesistenza con persone con opinioni diverse nel quadro di una democrazia plurale. Ma c'è un'altra ragione, ancora più importante: solo il disaccordo ci permette di raggiungere una visione più ampia e completa della realtà, che non è mai semplice, piatta e uniforme, ma ricca, complessa e sfaccettata. Lo scienziato Karl R. Popper ha affermato che "l'aumento della conoscenza dipende interamente dall'esistenza del disaccordo".. È stato anche detto, e a ragione, che "la capacità di ascoltare persone intelligenti che non sono d'accordo con te è un talento difficile da trovare" (Ken Follet). In effetti, è più facile coccolare chi ci piace, come fanno i bambini, perché, come diceva Kant, "è così comodo essere un minore!
Tuttavia, una società è più matura e democratica quando i suoi individui sono capaci di rafforzare i legami di amicizia anche con chi non la pensa come loro, di vedere chi non è d'accordo con le loro idee come qualcuno che li aiuta e li arricchisce, e non come un fastidio o un ostacolo alla loro realizzazione personale. Essere amici solo di chi ci piace e condivide le nostre idee significa rimanere immaturi, rinunciare a una pienezza che implica il riconoscimento di non avere tutta la verità e di potersi avvicinare ad essa solo ascoltando e comprendendo il punto di vista degli altri..
Perché la ragione è stata sostituita dall'ideologia?
-Hannah Arendt mostra, in Le origini del totalitarismoIl rapporto tra totalitarismo e ideologia, e sottolinea che "il dominio totalitario (...) mira all'abolizione della libertà, persino all'abolizione della spontaneità umana in generale". In realtà, la libertà umana e la ragione sono i grandi nemici dell'ideologia.
Tuttavia, è sbagliato pensare che questa minaccia esista solo nei regimi politici totalitari (sia di destra che di sinistra), che in molti Paesi occidentali questo pericolo sia stato superato e appartenga ormai al passato. Questo era il pensiero all'inizio del secolo scorso, come descritto da Stefan Zweig nel suo romanzo Castellio contro Calvino. Coscienza contro violenza (1936).
Si percepisce una certa apatia sociale. Tutto è delegato ai governi o allo Stato e noi ci accontentiamo.
-Benjamin ConstantNella sua famosa conferenza ("Sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni"), tenuta all'Ateneo di Parigi nel febbraio 1819, aveva già avvertito che l'intervento eccessivo delle autorità pubbliche "è sempre un fastidio e un ostacolo". E aggiungeva: "Ogni volta che il potere collettivo vuole immischiarsi in operazioni particolari, danneggia gli interessati. Ogni volta che i governi cercano di fare i nostri affari, li fanno peggio e più costosi di noi".
Constant esortava la società a esercitare "una vigilanza attiva e costante sui suoi rappresentanti, e a riservarsi, a periodi non troppo lunghi, il diritto di rimuoverli se hanno sbagliato, e di revocare loro i poteri di cui hanno abusato".
In relazione a quanto sopra, in Occidente stiamo assistendo al ruolo degli Stati e dei governi come agenti plasmatori dei valori fondamentali che sono alla base della convivenza? O questa percezione è eccessiva?
-È sintomatico che i politici siano comprensivi della mancanza di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, limitata solo - nella migliore delle ipotesi - al voto nelle urne di tanto in tanto. La stragrande maggioranza della classe politica odierna sembra ragionare in modo molto simile a come Constant la metteva due secoli fa: "... il diritto del cittadino a partecipare alla vita pubblica del Paese è una questione di scelta del cittadino stesso".Sono disposti a risparmiarci qualsiasi preoccupazione, tranne quella di obbedire e pagare! Ci diranno: qual è il fine ultimo del vostro sforzo, del vostro lavoro, di tutte le vostre speranze, non è forse la felicità? Bene, lasciateci fare e vi daremo questa felicità. No, signori, non lasciamoglielo fare, per quanto possa essere toccante, preghiamo l'autorità di rimanere nei suoi limiti, di limitarsi a essere giusta. Faremo in modo di essere felici.".
Una questione che i cittadini non dovrebbero mai delegare a nessun potere - nemmeno a quello politico - è quella della formazione dell'etica pubblica della società, perché ciò che è proprio di una vera democrazia liberale è che i cittadini siano i principali agenti nella formazione dell'etica pubblica.
Credo che in una democrazia libera e plurale lo Stato non debba essere il principale artefice della formazione dei valori fondamentali alla base della convivenza sociale. Né dovrebbero farlo i grandi gruppi imprenditoriali, mediatici e finanziari. Altrimenti, la democrazia si corrompe e si trasforma in demagogia, portando facilmente a un regime autoritario o totalitario.
Questo processo di corruzione della democrazia si evita quando la libertà politica di una comunità si basa sulla somma delle libertà individuali, non in astratto, ma nel loro concreto e libero esercizio. È quindi essenziale che ogni cittadino pensi con la propria testa, che esprima pubblicamente il proprio pensiero in un clima di libertà - a prescindere da ciò che pensa - e che contribuisca, al meglio delle proprie possibilità, a plasmare l'etica pubblica della società in cui gli tocca vivere.
Lei nota che nelle argomentazioni che vengono offerte quando si presentano riforme giuridiche, si parla di richieste sociali che poi sono quasi inesistenti..., e allora il giuridico viene percepito come morale....
-Indeed, si sta perdendo la distinzione tra la sfera del giuridico e quella del morale, così importante nel pensiero e nella cultura giuridica occidentale. Questa è in realtà una conseguenza della mancanza di pensiero critico. Chi non pensa con la propria testa tende a credere che tutto ciò che è legale sia moralmente lecito e non si rende conto che alcune leggi approvate dalle autorità politiche possono essere ingiuste perché non tutelano la dignità e i diritti di tutti, in particolare dei più vulnerabili.
La storia dei diritti umani dimostra questa realtà. Il riconoscimento di alcuni diritti è stato spesso la risposta a situazioni sociali moralmente insostenibili.
Le condizioni della maggioranza dei lavoratori erano insostenibili, così come il trattamento indegno di donne, bambini e disoccupati, malati e disabili (XIX e XX secolo); le teorie filosofico-politiche che hanno portato - o addirittura giustificato - le due guerre mondiali (XX secolo) erano insostenibili).
Insostenibile è il dualismo globale che esiste oggi, dove alcuni vivono nella più completa opulenza a scapito di molti altri che non hanno l'essenziale per vivere con un minimo di dignità (acqua potabile, cibo, casa, istruzione, comunicazione, ecc.), mentre il resto contempla - con una certa complicità e impotenza - la ricchezza di alcuni e l'indigenza di tanti altri.È insostenibile che una parte del mondo conduca una vita consumistica ed edonistica, giustificando il calpestamento dei diritti degli indifesi, degli esseri più vulnerabili, di coloro che non possono provvedere a se stessi o di coloro che, quando arriveranno, non potranno più godere del mondo e dell'ambiente di cui godiamo oggi.
Cosa proporrebbe per rafforzare la società civile? Lei conosce la storia e ha viaggiato per mezzo mondo...
-La chiave è tornare alla realtà, vivere in essa, non fuori di essa. Lo illustrerò con un aneddoto di questa settimana. Quando ho detto a un'assistente amministrativa della mia università che di lì a pochi giorni avrei partecipato a una conferenza con una relazione sulla libertà sessuale nel diritto penale moderno, mi ha interrotto e mi ha chiesto: "Libertà sessuale o perversione del sessuale? Risposi dicendole che non mi sembrava il modo migliore per sollevare la questione in un congresso internazionale a Parigi, la città che ha vissuto la rivoluzione del maggio '68. Mi disse: "Oggi c'è più perversione che libertà sessuale". E ha aggiunto: "C'è molta ignoranza. Quando si perde il contatto con la realtà, è molto facile gonfiare le cose a dismisura e perdere il buon senso. Questo è ciò che è successo con il sesso nella società di oggi".
Non è necessario avere una grande formazione culturale per discernere tra ciò che è vero e ciò che è falso, tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, tra ciò che ci umanizza e ciò che ci disumanizza; né è necessario avere il tempo libero che non abbiamo. È necessario, invece, trovare un ritmo vitale che ci permetta di osservare la realtà con più attenzione, di riflettere più criticamente su ciò che accade nel mondo - nella nostra vita e in quella degli altri -, di avere - di trovare o di creare - spazi che favoriscano la libera espressione delle proprie idee e il dialogo con tutti - anche con chi la pensa diversamente - e di promuovere le relazioni interpersonali, e promuovere relazioni interpersonali autentiche - faccia a faccia, non virtuali - che ci permettano di rafforzare i legami di amicizia e di collaborazione reciproca nella ricerca dell'autentico, del buono e del bello per la società nel suo complesso. È un bisogno umano, un'inclinazione verso ciò che è autenticamente umano.
Su questa linea, negli ultimi mesi sono sorte in Spagna diverse iniziative - da parte di giovani - che promuovono la creazione di spazi per la libera espressione delle idee, il dialogo e le relazioni interpersonali (Liberi pensatori, È tempo di pensare, Siamo cercatorie così via). Le persone hanno bisogno di spazi di libertà dove poter pensare con la propria testa, esprimere le proprie idee e dialogare, attività difficili o rischiose da svolgere in politica, nelle università e in altri ambiti professionali e culturali.
Nel suo libro parla di disumanizzazione e politicizzazione del diritto. Entrambi.
-La legge disumanizza ogni volta che non riesce a proteggere i diseredati, coloro che non hanno voce o non riescono a farsi sentire in una società stordita dal frastuono di un ritmo di vita faticoso e dal tentativo di alleviare questa tensione con il divertimento e il piacere, con il pericolo - oggi vero e diffuso - di cadere nelle dipendenze (social network, pornografia, alcol, droga). Non di rado, queste leggi disumanizzanti vengono presentate come conquiste nel campo dei diritti, a volte i diritti di alcuni a scapito della vita, della dignità e dei diritti di altri.
È innegabile che oggi la legge dipenda eccessivamente dalla politica, la classe politica dai media e i media a loro volta dai media. lobby e gruppi di pressione che difendono determinati interessi estranei al bene comune. A volte, con il pretesto di "proteggere" una minoranza, l'interesse generale viene seriamente compromesso, a scapito dei diritti della maggioranza.
In questa ben nota struttura gerarchica di interessi intrecciati - che a qualcuno potrebbe far pensare alla società europea feudale - le libertà fondamentali di cui la civiltà occidentale si vanta e di cui va tanto orgogliosa sono non di rado assenti o prive di una tutela chiara e coerente.
Secondo lei, sta crescendo l'intolleranza e persino la discriminazione nei confronti dei cristiani che pensano in un certo modo?
-A volte ci aggrappiamo così tanto alle nostre idee e concezioni di vita che consideriamo qualsiasi espressione di dissenso come un affronto. Siamo così radicati nell'idea che la realizzazione personale dipenda dalla nostra autonomia di volontà, cioè che possiamo essere felici solo se ci viene permesso di soddisfare i nostri desideri o le nostre scelte, che consideriamo un attacco personale se qualcuno ci dice che ci sono opzioni migliori e che la nostra non è la migliore per la società nel suo complesso (o forse per noi). E lo prendiamo come qualcosa di offensivo. Non riusciamo a distinguere tra la critica alle nostre opinioni e il rispetto per noi stessi. E pensiamo che tale discrepanza implichi necessariamente disprezzo e squalifica.
Per questo motivo, molti interpretano come offensivo il fatto che i cristiani possano difendere la vita umana (dal concepimento alla morte naturale), il matrimonio come impegno a vita tra un uomo e una donna, ecc. e pensano di non dover imporre le loro opinioni al resto della società.
A parte il fatto che dare la propria opinione non significa imporsi (e non dovrebbero esistere cittadini di serie B a cui è vietato esprimere la propria opinione), molte persone sembrano non essere in grado di distinguere tra la comprensione di se stessi e delle proprie idee; quindi concepiscono ogni discrepanza con le loro idee come un attacco diretto a loro.
È ora di finire. Lei parla di paura...
-L'antonimo dell'amore non è solo l'odio, ma anche la paura o il timore, così diffusi nella società di oggi. Molte persone vivono nella paura: di sbagliare - o di fallire -, di deludere, di fare brutta figura - e di essere ridicolizzati o rifiutati -. E la paura è incompatibile con l'amore, così come con il vivere in libertà. Ci si sente insicuri, si percepisce la propria mancanza di conoscenza e si sceglie di rinunciare al compito di pensare ed esprimere le proprie idee (che in realtà non sono proprie) agli altri.
La paura è paralizzante e impedisce il libero sviluppo della propria personalità, confinando la vittima nel regno di una massa anonima e amorfa, i cui membri non pensano, non parlano e non agiscono da soli, ma secondo i dettami di un pensiero debole ma (iper)protetto dalla forza.potestasno auctoritas- che le conferisce il carattere - presumibilmente - maggioritario, nonché l'egemonia mediatica, politica e culturale.
Direi che la paura è il principale ostacolo a vivere autenticamente in libertà, a essere se stessi e a vivere pienamente, raggiungendo la felicità che ogni essere umano desidera. Controllare la paura - perché non si tratta di farla sparire o di ignorarla completamente - è la chiave per una vita piena e felice. Agostino d'Ippona ha detto che ci sono due modi per commettere errori nella vita: uno è quello di scegliere la strada che non ci porta alla nostra destinazione. L'altro è quello di non scegliere alcuna strada perché abbiamo paura di sbagliare.
Soccombere alla paura, lasciarsi condizionare da essa, scegliere di non perseguire ciò che vi entusiasma e vi fa stare meglio per paura dell'errore, del fallimento o della fatica che potrebbe comportare, è probabilmente l'errore più grande che possiate commettere nella vostra vita.
La democrazia liberale ha bisogno, oggi più che mai, di una società civile attiva che, esprimendo con rispetto le proprie idee e impegnandosi in un dialogo sereno, contribuisca a plasmare una società più libera, giusta e umana.
L'autoreFrancisco Otamendi  "È l'anno per rivalutare la bellezza del matrimonio e della famiglia cristiana".
"È l'anno per rivalutare la bellezza del matrimonio e della famiglia cristiana". Incontro virtuale su antropologia, affettività e sessualità
Incontro virtuale su antropologia, affettività e sessualità