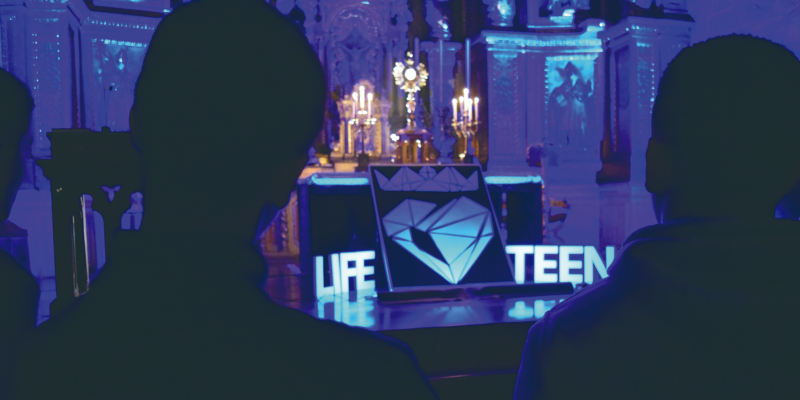Sono passati 50 anni dall'enciclica Humanae Vitae, pubblicata dal beato Paolo VI il 25 luglio 1968. Il Papa ha affrontato il tema dell'amore e della sessualità nel matrimonio, annunciando con visione profetica le conseguenze che si sarebbero avute se l'amore coniugale fosse stato distorto separando la dimensione unitiva da quella procreativa.
Testo - Stéphane Seminckx, Bruxelles
Dottore in medicina presso l'Università di Lovanio e Dottore in teologia morale presso l'Università della Santa Croce.
Tutti sogniamo un grande amore. Tutti aspiriamo all'ideale di fondare una famiglia unita (o di rispondere alla chiamata di Dio con il dono totale del celibato). Tutti pensiamo che questa sia la chiave della felicità. Ma, come dice Papa Francesco in Amoris laetitia, "la parola "amore", una delle parole più usate, è spesso sfigurata" (89). Molte persone parlano di amore senza sapere bene cosa sia. Per questo è fondamentale farsi un'idea vera dell'amore, attraverso l'esperienza e anche la preghiera e la riflessione.
L'enciclica Humanae Vitae, pubblicata nel 1968 da Papa Paolo VI, non diceva di meno quando affermava al n. 9 che "è della massima importanza avere un'idea precisa dell'amore coniugale". Non possiamo rovinare la nostra vita - o ipotecare il futuro delle persone che ci sono affidate - sbagliando sul vero amore: "Ingannarsi in amore è la cosa più terribile che possa capitare, è una perdita eterna, per la quale non si è compensati né nel tempo né nell'eternità" (Sören Kierkegaard).
Messaggio attuale
Per questo motivo, cinquant'anni dopo, il messaggio dell'Humanae Vitae è ancora molto attuale. Questa enciclica non riguarda semplicemente la contraccezione; è soprattutto l'occasione per affermare in modo decisivo la sublime grandezza dell'amore umano, immagine e somiglianza dell'Amore divino. Al momento della sua comparsa, questo documento ha dato luogo a una lunga serie di dibattiti e a numerose tensioni. Molti cristiani erano perplessi e incompresi. Alcuni hanno poi rotto con la Chiesa, o perché hanno esplicitamente rifiutato il suo insegnamento, o perché hanno abbandonato la pratica religiosa, o perché hanno cercato di vivere la loro fede dando le spalle alla Chiesa.
Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti. Gli animi si sono calmati, spesso al prezzo dell'indifferenza. Oggi la questione può essere esaminata con maggiore serenità e, a mio avviso, abbiamo il dovere di farlo: è in gioco la coerenza della nostra vocazione umana e cristiana.
Papa Francesco ci invita a farlo quando parla di "riscoprire il messaggio dell'enciclica Humanae Vitae di Paolo VI" (Amoris laetitia, 82 e 222). San Giovanni Paolo II aveva già incoraggiato i teologi a "... riscoprire il messaggio di Paolo VI" (Amoris laetitia, 82 e 222).approfondire le ragioni di questo insegnamento [dell'Humanae Vitae], che è uno dei compiti più urgenti di chiunque sia impegnato nell'insegnamento dell'etica o nella pastorale della famiglia. Infatti, non basta proporre questo insegnamento fedelmente e nella sua interezza, ma è necessario anche mostrarne le ragioni più profonde." (Discorso del 17-09-1983).
Questo è particolarmente necessario perché l'ideologia del sesso libero, nata negli anni '60, non sembra aver liberato la sessualità. Un numero crescente di donne è stanco della pillola e dei suoi numerosi effetti collaterali sul corpo e sulla psiche. Vedono sempre più spesso la contraccezione come un'imposizione del mondo maschile.
Contro-concezione
A livello di relazioni internazionali, il controllo delle nascite è diventato un'arma nelle mani dei Paesi ricchi, che lo impongono alle nazioni svantaggiate in cambio di aiuti economici. Allo stesso tempo, in questi stessi Paesi sviluppati, profondamente segnati dalla mentalità contraccettiva, la demografia sta vivendo un drammatico declino, che pone immense sfide all'Occidente. Infine, molti moralisti ritengono che il "linguaggio contraccettivo" distorca la comunicazione tra i coniugi al punto da favorire un'esplosione del numero di divorzi.
Parallelamente a questo sviluppo, dal 1968 molti filosofi e teologi hanno lavorato per una migliore comprensione della dottrina dell'Humanae Vitae. Inoltre, il magistero di San Giovanni Paolo II ha dato un contributo essenziale a questa riflessione, così come Benedetto XVI e Francesco.
Perché queste reazioni così vivaci?
La ricezione attenuata dell'Humanae Vitae si spiega in parte con il contesto storico in cui l'enciclica è apparsa. La Chiesa era allora all'inizio del cosiddetto periodo post-conciliare. La società civile stava vivendo la rivolta del maggio '68 e il mondo viveva nella psicosi della sovrappopolazione.
Il documento era atteso da tempo. Le sue raccomandazioni sfidavano le conclusioni di un gruppo di rinomati specialisti (il cosiddetto gruppo "di maggioranza", che si staccò dal resto della Pontificia Commissione per i problemi della famiglia, della natalità e della popolazione, istituita da San Giovanni XXIII nel 1962), il cui rapporto fu divulgato da molti giornali nell'aprile del 1967.
Ma questo contesto non spiega tutto. Sono soprattutto le questioni affrontate dall'Humanae Vitae ad essere in gioco. Si tratta infatti di questioni fondamentali che riguardano tutti: l'amore umano, il significato della sessualità, il significato della libertà e della morale, il matrimonio.
Nella Chiesa, la contraccezione è stata riprovata fin dai primi secoli del cristianesimo (nell'enciclica Casti Connubii del 1930, Pio XI parla di "una dottrina cristiana tramandata fin dall'inizio e mai interrotta"). Tuttavia, fino alla fine degli anni '50, è sempre stata identificata - in modo più o meno confuso - con l'onanismo (coito interrotto) o con mezzi meccanici che impediscono il normale svolgimento dell'atto sessuale (preservativi, diaframmi, ecc.). I progestinici, scoperti nel 1956, rendono le donne sterili senza interferire - almeno apparentemente - con lo sviluppo dell'atto sessuale. Visto dall'esterno, un atto sessuale compiuto con o senza la pillola è esattamente lo stesso.
La domanda precisa posta nel 1968 era la seguente: la pillola merita di essere chiamata "contraccezione"? Per un certo numero di teologi, la risposta era e rimane negativa, perché la pillola non disturba l'atto coniugale nel suo sviluppo "naturale". Inoltre, vedono nella contraccezione ormonale una conferma della dignità dell'uomo, che è chiamato a sfruttare le leggi della "natura" con la sua intelligenza. Ma cosa significano "naturale" e "natura" quando si parla di persona umana?
Cosa è cambiato dal 1968?
Il Beato Paolo VI ha scritto un'enciclica piuttosto breve, il cui contenuto è incentrato su una sorta di assioma, che poggia su un semplice fatto: per sua natura, per volontà del Creatore, l'atto coniugale possiede una dimensione unitiva e una dimensione procreativa, che non possono essere separate. Come tutti gli assiomi, anche questo non è soggetto a dimostrazione. Le argomentazioni a sostegno arriveranno più tardi, essenzialmente durante il pontificato di San Giovanni Paolo II.
Si è spesso detto che l'Humanae Vitae è stato un documento profetico, a causa del numero 17, dove Papa Paolo VI annuncia le possibili conseguenze del rifiuto della visione dell'amore proclamata dalla Chiesa. È impressionante rileggere oggi questo numero 17: l'annuncio dell'aumento dell'infedeltà coniugale, del declino generale della moralità, del crescente dominio dell'uomo sulla donna, delle pressioni dei Paesi ricchi sui Paesi poveri in termini di tassi di natalità... Tutto questo si è avverato.
Profetico
Ma l'Humanae Vitae è profetica, a mio avviso, soprattutto per l'assioma che l'enciclica ha posto a fondamento di tutta la sua riflessione: le dimensioni unitiva e procreativa dell'atto coniugale non possono essere separate senza snaturare l'amore tra i coniugi. Questo principio era già stato evocato da Pio XI, ma fu Paolo VI a metterlo alla base della sua visione dell'amore coniugale.
Il pensiero di Karol Wojtyla/Giovanni Paolo II ha fatto molto per spiegare e arricchire questa visione. Dal 1960, con il suo famoso libro Amore e responsabilità, ha incentrato il dibattito sulla persona umana e sulla sua dignità, in particolare sulla sua vocazione a fare di sé un dono disinteressato. La "legge del dono" è per il Papa polacco l'intero fondamento dell'etica del matrimonio, della sua unità, della sua indissolubilità, dell'esigenza di fedeltà e della necessaria verità di ogni atto coniugale.
Karol Wojtyla, come padre conciliare, ha contribuito alla stesura della Costituzione pastorale Gaudium et Spes, in particolare alla parte riguardante il matrimonio. Con un gruppo di teologi polacchi, inviò un memorandum sulla questione del controllo delle nascite a Papa Paolo VI nel febbraio 1968, pochi mesi prima della pubblicazione dell'enciclica.
Tra il settembre 1979 e il novembre 1984, quando divenne Papa, dedicò 129 catechesi del mercoledì a quella che è stata definita la "teologia del corpo", un insieme di "teologie del corpo".riflessioni che [...] intendono costituire un ampio commento alla dottrina contenuta [...] nell'enciclica Humanae Vitae" (San Giovanni Paolo II, Udienza del 28-02-1984).
Ha inoltre preso l'iniziativa di numerosi documenti che trattano ampiamente o fanno importanti riferimenti alla morale coniugale e alla difesa della vita: l'esortazione apostolica Familiaris Consortio (1981), l'istruzione Donum Vitae (1987) sul rispetto della vita umana nascente e della dignità della procreazione, il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992), l'enciclica Veritatis splendor (1993) sulla morale fondamentale, la Lettera alle famiglie (1994), l'enciclica Evangelium Vitae (1995), ecc.
La castità è libertà
Questo magistero di Giovanni Paolo II ha contribuito a chiarire alcuni punti essenziali nel dibattito sull'Humanae Vitae.
Innanzitutto, si può fare riferimento alla nozione di persona come "insieme unificato" (Familiaris Consortio, 11): non si può comprendere la visione cristiana del matrimonio con una visione dualistica dell'uomo, dove lo spirito rappresenterebbe la persona mentre il corpo non sarebbe altro che un'appendice, uno "strumento" al servizio dello spirito. Siamo un unico corpo e il matrimonio è la vocazione a dare il "tutto unificato" che siamo, in modo che si formi "una sola carne".
Si può poi indicare la nozione di castità, intesa come integrazione della sessualità nella persona, come integrità della persona in vista dell'integrità del dono (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2337): l'atto coniugale non è moralmente buono solo perché conforme a certe caratteristiche fisiologiche della donna; è buono quando è virtuoso, quando la ragione ordina la tendenza sessuale al servizio dell'amore. La castità è libertà, padronanza di sé, padronanza della propria personalità in vista del dono di sé, con la ricchezza delle sue dimensioni fisiologiche, psicologiche e affettive.
Il ruolo di Veritatis Splendor
Il contributo dell'enciclica Veritatis Splendor di San Giovanni Paolo II, che Benedetto XVI ha considerato uno dei documenti più importanti del Papa polacco, non può essere sottolineato a sufficienza.
Veritatis Splendor ci ricorda che la coscienza non è il creatore della norma, il che porterebbe all'arbitrarietà e al soggettivismo, al postulato dell'"autonomia", che prevale nella maggior parte dei dibattiti bioetici di oggi, dove il semplice fatto di desiderare qualcosa è sufficiente a giustificarla. Veritatis Splendor ci ricorda che la coscienza è un araldo, cioè proclama una legge, pienamente assunta, anche se proviene da un Altro. La vera libertà consiste nell'andare verso il bene per se stesso, un bene che la coscienza ci indica, così come una bussola indica il nord. La coscienza è come una partecipazione libera e responsabile alla visione di Dio del bene e del male.
L'atto coniugale: dono totale
La questione dell'oggetto dell'atto è altrettanto fondamentale per comprendere cosa sia l'atto coniugale. Non si tratta di un semplice atto sessuale, perché in questo senso anche l'adulterio e la fornicazione sono atti sessuali, così come l'atto sessuale contraccettivo. Se il linguaggio usa termini diversi per un atto apparentemente identico, è perché, dal punto di vista morale, un atto può avere un significato diverso, un "oggetto" diverso, e questo oggetto è il primo elemento da considerare per giudicare la bontà di quell'atto.
L'atto coniugale è definito dalla volontà di significare, consumare o celebrare il dono totale di una persona all'altra. L'atto sessuale contraccettivo è la negazione di questa definizione, perché la persona, non dando la sua potenzialità procreativa, non si dona interamente. Questo punto è essenziale per comprendere la dottrina dell'Humanae Vitae.
Ed è inoltre legata alle nozioni di natura umana e di legge naturale, che sono al centro dei grandi dibattiti filosofici di oggi. Molti dei nostri contemporanei rifiutano l'idea stessa di "natura" in nome dell'autonomia e di una certa concezione della libertà. Giovanni Paolo II ha parlato del rifiuto di "della nozione di ciò che più profondamente ci costituisce come esseri umani, cioè la nozione di "natura umana" come "dato reale", e al suo posto è stato messo un "prodotto del pensiero" liberamente formato e liberamente modificabile a seconda delle circostanze."(Memoria e identità). La teoria del genere è una manifestazione estrema di questo rifiuto.
Rispettare la natura dell'uomo
Benedetto XVI si è chiesto: perché chiedere il rispetto della natura ecologica e allo stesso tempo rifiutare la natura più intima dell'uomo? La risposta: "L'importanza dell'ecologia oggi è indiscutibile. Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondere ad esso in modo coerente. Tuttavia, vorrei affrontare seriamente un punto che mi sembra sia stato dimenticato oggi come ieri: esiste anche un'ecologia umana. Anche l'uomo ha una natura che deve rispettare e che non può manipolare a suo piacimento. L'uomo non è solo una libertà che si crea da sé. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma anche natura, e la sua volontà è giusta quando rispetta la natura, la ascolta e quando si accetta per quello che è, ammettendo di non aver creato se stesso. In questo modo, e solo in questo modo, si realizza la vera libertà umana." (Discorso al Bundestag, 22-9-11).
Siamo creature
La "vera libertà umana" è una libertà creata, ricevuta incarnata, finita, inscritta in un essere configurato da una natura, un progetto, delle tendenze: "...".Non cadiamo nel peccato di pretendere di sostituirci al Creatore. Siamo creature, non siamo onnipotenti. Ciò che è stato creato ci precede e deve essere ricevuto come un dono." (Amoris laetitia, 56). Essere liberi non consisterà mai nel volersi liberare dalla propria natura, ma piuttosto nell'assumere personalmente, consapevolmente e volontariamente, le tendenze in essa inscritte. Una libertà diretta contro la nostra natura".si ridurrebbe allo sforzo di liberarsi" (Albert Chapelle).
Dietro questa obiezione, possiamo intravedere la messa in discussione della nostra origine. Il rifiuto della nostra natura sarebbe comprensibile se ognuno di noi fosse la conseguenza di un semplice concorso di circostanze, di una collisione casuale di molecole, di una mutazione o di un destino cieco, perché allora la nostra esistenza sarebbe assurda, senza progetto né destino. Ci sarebbero motivi per ribellarsi, per voler ignorare o trasformare questa natura, invece di riceverla come un dono.
Ma la realtà è ben diversa. All'origine della nostra vita c'è un Amore creatore, quello di un Dio che, da tutta l'eternità, ci ha concepiti e fatti nascere in un determinato momento della storia umana. Siamo un frutto dell'Amore, siamo un dono della sovrabbondanza di Amore infinito di un Dio che, per così dire, crea gli esseri al solo scopo di riversare in essi il suo Amore. "In lui (Cristo) egli (Dio Padre) ci ha scelti (Dio Padre) prima della creazione del mondo per essere santi e irreprensibili al suo cospetto, per amore di Dio." (Ef 1, 4).
Riscoprire la libertà
Si tratta di riscoprire la vera libertà. Il giusto atto di libertà è l'amore. Ma se, di fronte all'amore, il primo atto della nostra libertà consiste nel rifiutare il dono della nostra natura, nel rifiutare ciò che siamo, come possiamo possedere questo "io" che rifiutiamo di assumere? E se non possediamo noi stessi, come potremo donarci? E se non siamo capaci di donarci, dov'è l'amore coniugale?
La conversione dell'intelletto presuppone la conversione del cuore: per imparare ad amare, bisogna accettare l'Amore. Alcune reazioni all'Humanae Vitae ricordano passaggi del Vangelo in cui il discorso di Gesù sull'amore si scontra con la mancanza di comprensione della gente. Quando Gesù parla dell'indissolubilità del matrimonio, i suoi discepoli reagiscono duramente: "Se questa è la condizione del rapporto dell'uomo con la moglie, non ha senso sposarsi" (Mt 19,10).
"Dio ci mette sempre al primo posto".
In questi due passi evangelici, Gesù parla del matrimonio indissolubile e del dono del suo Corpo nell'Eucaristia; l'Humanae Vitae si riferisce all'integrità del dono nell'alleanza coniugale. Tutti e tre i temi corrispondono a caratteristiche fondamentali dell'amore dell'alleanza che Dio ci rivela. E questa rivelazione ci lascia perplessi. Ci supera. Ci sorprende persino perché, al di là delle esigenze, la nostra miopia a volte ci rende difficile vedere i doni di Dio.
Dio ci ha amati per primo. Come dice Papa Francesco, "Dio ci mette sempre al primo posto". E questo amore dà la grazia di vivere il dono di sé, la fedeltà, l'apertura generosa alla vita; è misericordia e dà la comprensione di Dio, la sua pazienza e il suo perdono di fronte alle nostre debolezze e ai nostri errori. Solo Cristo porta alla sfida dell'amore la risposta decisiva dell'"amore di Dio".speranza (che) non inganna, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato." (Rm 5,5). n





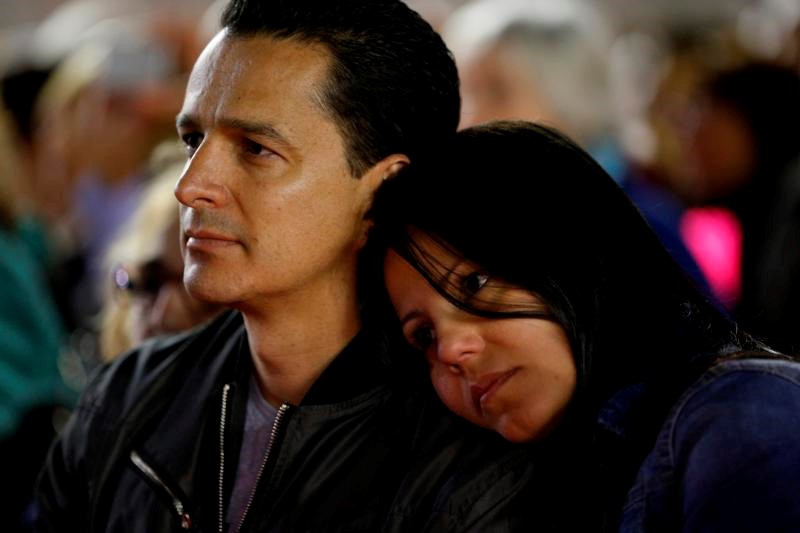
















 Il mistero di Paolo VI
Il mistero di Paolo VI