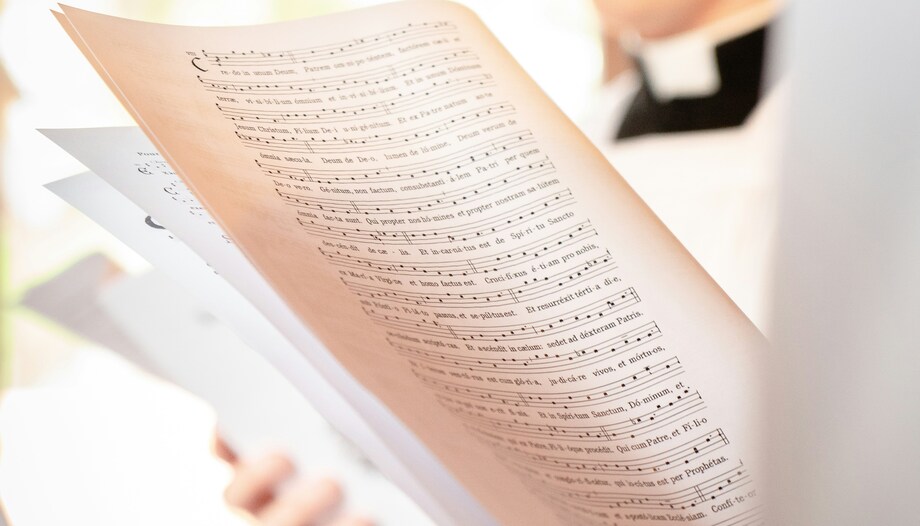Timothy McDonell è direttore di Musica sacra presso Hillsdale Collegedove dirige il Coro della Cappella dell'Università. In precedenza, il Dr. McDonnell ha diretto il programma di laurea in Musica Sacra presso la Catholic University of America. È stato anche direttore del coro del Pontificio Collegio Americano in Vaticano prima di tornare negli Stati Uniti nel 2008.
Attraverso il suo lavoro accademico e professionale, Timothy McDonnell ha approfondito la sua comprensione dello stretto rapporto tra il canto gregoriano e il liturgia Cattolico. In un rapporto tale che l'uno non può essere compreso senza l'altro, il direttore della musica sacra incoraggia i cattolici a restituire al canto gregoriano il suo posto speciale nella liturgia e a riconoscerne l'eredità.
Come definirebbe il canto gregoriano in termini musicali e spirituali e cosa lo rende unico nel contesto liturgico cattolico?
- Questo ci porta al cuore della questione, perché tutta la musica sacra è speciale e riservata a scopi sacri. Ma il canto gregoriano in particolare ha alcune caratteristiche speciali che, a mio avviso, lo rendono particolarmente adatto alla liturgia cattolica e riflettono la spiritualità di questa liturgia.
Tra le caratteristiche che elencherei c'è la schiettezza, perché il canto gregoriano è una forma musicale semplice, con un solo rigo musicale. Quindi ha una certa semplicità, ma allo stesso tempo è una musica molto raffinata. È una musica che ha richiesto secoli per essere creata, ma che conserva quella schiettezza e semplicità nella sua espressività.
L'altra cosa che vorrei menzionare è che proviene da una tradizione, che penso sia molto importante in un contesto religioso, perché la premessa della religione è che c'è una trasmissione, che ci tramandiamo da Cristo e dalla sua missione data agli apostoli.
L'idea di una tradizione musicale nella Chiesa è una sorta di simbolo di questo processo di trasmissione del tesoro. E così la musica stessa è una sorta di metafora della tradizione in termini musicali. Per esempio, i diversi modi o tonalità in cui è composto il canto gregoriano derivano da antiche formule per recitare e cantare i Salmi.
E il terzo punto che vorrei sottolineare è che la liturgia stessa è progettata e coordinata perfettamente con il canto liturgico. Il canto gregoriano si riferisce sempre a qualcosa di esterno a se stesso: alla liturgia da un lato e alla Sacra Scrittura dall'altro. È quindi una musica profondamente biblica. In un certo senso incarna il canto della Scrittura.
Qual è stata l'influenza più profonda del canto gregoriano sull'evoluzione della liturgia cattolica?
- La liturgia è cambiata gradualmente nel tempo. Si tratta di un'intuizione importante perché la liturgia e la sua musica sono cresciute insieme. Per esempio, tra il VII e il IX secolo il canto gregoriano fu composto dal clero responsabile della creazione del nostro calendario liturgico.
Questi musicisti clericali sceglievano testi liturgici che suggerivano essi stessi un contenuto melodico. In altre parole, la melodia emerge dal testo. E così, quando questo cambia il testo, c'è un'influenza sulla liturgia.
Il Concilio Vaticano II ha portato cambiamenti significativi alla liturgia. Come vede il rapporto tra il canto gregoriano e le riforme liturgiche di quel periodo?
- Questo è un punto incredibilmente importante. Anzi, è forse la considerazione più importante in termini di musica e liturgia nel nostro tempo. Perché se la musica è qualcosa che si tramanda di generazione in generazione come un tesoro, dobbiamo comprendere le riforme liturgiche nel contesto della ricezione di quel tesoro. Quindi, se ci allontaniamo troppo da ciò che impariamo dal tesoro musicale della Chiesa nel modo in cui perseguiamo la riforma liturgica, ci sarà un eccessivo scollamento con la nostra tradizione.
Credo sia fondamentale capire che la musica ci fornisce un contesto in cui comprendere tutti gli altri cambiamenti rituali che hanno avuto luogo. E posso fornire un paio di esempi positivi e forse negativi di questo.
C'è stato, ad esempio, un processo di recupero nella liturgia dell'Ufficio divino intorno agli inni dell'Ufficio divino. Perché nel XVII secolo c'è stata una revisione degli inni che ha cambiato gli inni originali, e tutti i testi sono stati ricreati. E a causa di questi cambiamenti abbiamo perso qualcosa di molto importante.
Dopo il Concilio Vaticano II è accaduto qualcosa di meraviglioso: questi inni sono stati ripristinati. E così sono diventati gli inni ufficiali dell'Ufficio divino. Questo è un esempio positivo in cui il recupero ci ha insegnato qualcosa sul nostro passato e abbiamo avuto una sorta di restauro.
Ma queste cose non sono state prese particolarmente sul serio dalla generazione che ha seguito il Concilio Vaticano II e c'è stato un abbassamento degli ideali. E credo che ciò sia dovuto in parte alle circostanze pratiche. C'è stata una perdita di energia e di vigore nel perseguire questi obiettivi.
Ora, la buona notizia è che nelle giovani generazioni sta crescendo l'interesse a trovare l'energia per fare ciò che il Concilio ha chiesto per ripristinare il canto gregoriano e renderlo una modalità di preghiera centrale per tutta la Chiesa.
D'altra parte, va notato che la preghiera della Messa è stata resa più breve nella liturgia riformista, ma la musica è talvolta troppo lunga. Ecco quindi un caso in cui musica e liturgia non sono in un certo senso compatibili. È una sfida che dobbiamo affrontare.
Un'altra sfida a questo proposito è che c'è una sorta di politicizzazione degli obiettivi del Concilio Vaticano II. C'è un lato "progressista" e uno "conservatore". Questo è qualcosa che il Concilio non stava cercando, ma la gente ha deciso di politicizzare la liturgia e di trasformarla in una questione politica, invece di essere il contenitore della verità da cui impariamo la nostra fede. Tuttavia, spero che torneremo all'idea che la musica è una compagna della liturgia e potremo ascoltare questa tradizione ricevuta mentre guardiamo alla preghiera della Chiesa.
Pensa che questo dibattito che abbiamo ora nella Chiesa sul Novus Ordo e sulla Messa tradizionale influenzerà la preghiera nella Chiesa e il canto gregoriano nella liturgia?
-Ci sono molte critiche a questo proposito. Alcuni pensano che coloro che sostengono la Messa tradizionale siano bloccati e irrealistici. Onestamente, non credo che sia questo a motivare le persone che vengono alla Messa tradizionale. Penso che in questo rito sentano la voce della Chiesa in modo speciale e li commuova in un modo che il Novus Ordo non fa.
Tuttavia, penso che la Chiesa sia sempre una voce sola. Non c'è ieri, non c'è domani, c'è solo un adesso in cui la Chiesa prega, è Cristo che prega oggi attraverso la liturgia. Egli è qui ora a pregare con e come la Chiesa, perché ne è il capo. Se teniamo presente questo, forse il dibattito su passato, presente e futuro potrebbe calmarsi un po'.
Per quanto riguarda l'effetto di questa questione sulla preghiera, Papa Benedetto XVI ha avuto un'idea molto buona al riguardo quando ha detto che la vecchia forma deve informare la nuova forma nella liturgia. Queste due cose devono essere viste come compatibili e non in opposizione.
La musica stessa è un legame tra il Novus Ordo e la tradizione. Se decidiamo di avere bisogno di una musica totalmente diversa per una nuova liturgia, avremo perso il legame con l'idea di aver ricevuto la liturgia dalla Chiesa antica.
Ora, il canto gregoriano non è antico come la preghiera degli apostoli, questo è vero. Non si sa bene da dove provenga o quando sia nato. Tuttavia, ci sono diverse teorie che sostengono che le formule di preghiera ebraiche abbiano influenzato il suo sviluppo. Sapendo questo, se poteste sentire come pregavano gli apostoli, che erano ebrei, non vorreste saperne di più?
In qualità di esperto del settore, quali sfide deve affrontare il canto gregoriano nel contesto della Chiesa contemporanea?
- Nell'ultimo secolo e mezzo possiamo osservare una sorta di odio per il passato. Penso addirittura che alcuni cattolici si siano resi conto che non dovremmo essere particolarmente attaccati al passato, perché così non si vive nel presente e non si affrontano le vere sfide del nostro tempo. Questo attaccamento smodato non è sano, ma non lo è nemmeno provare odio verso il passato, perché è essenziale per capire chi si è e da dove si viene.
In termini di liturgia e musica sacra, la cosa più importante per capire la liturgia è la sua storia. E qual è la storia della liturgia? La storia della musica. Bisogna conoscerle insieme perché la musica e la liturgia sono una cosa sola, non si sono sviluppate indipendentemente.
Nel XX secolo si è radicata l'idea che musica e liturgia siano due mondi diversi. Ma gli storici ci dimostrano che questo è falso e che non si può capire la storia della liturgia senza capire la storia della musica.
Per tutto questo, dobbiamo perdere la paura che, se guardiamo al nostro passato, in qualche modo falliremo nel nostro presente. Non è una paura razionale. Se non capisco e non valorizzo il passato, quella storia che abbiamo citato, non ho nulla da portare avanti. Pertanto, sono costretto a inventare costantemente la realtà.
Non possiamo dimenticare che la religione ci lega al passato, non possiamo essere religiosi senza portare con noi il passato.
Tenendo presente questa sfida, dobbiamo sapere che il canto gregoriano non solo è antico, ma si rigenera nel tempo. Non è bloccato, ma in evoluzione. È essenziale che i musicisti comprendano questa idea e ne facciano parte della loro formazione.
Quali passi possono essere fatti per preservare la pratica del canto gregoriano all'interno della liturgia?
- Credo sia importante riconoscere che il canto gregoriano ha diversi livelli. C'è un livello congregazionale e poi c'è un livello più sviluppato, al quale la congregazione può partecipare ma che richiede più pratica. Al di sopra di questo, c'è un livello di canto gregoriano riservato alle persone più esperte.
Per me è una cosa bellissima, perché riflette la liturgia stessa. Nella liturgia ci sono cose che solo gli "esperti", i sacerdoti, possono fare. In altre parole, la liturgia è gerarchica, proprio come la musica.
È successo che al tempo della Riforma questa gerarchia è stata spezzata. Perciò, per andare avanti dobbiamo riconoscere che il canto gregoriano è gerarchico, così come la liturgia, e quindi abbiamo bisogno di musicisti specializzati. Dobbiamo anche promuovere la pratica del canto nella congregazione, in modo che possa cantare cose come il Credo, il Kyrie Eleison o l'Agnus Dei.
Un altro aspetto da considerare su cui ci sono opinioni diverse è l'apertura a cantare in vernacolo. Penso che sia possibile tradurre brani musicali in altre lingue, ma ci vuole molta disciplina per non perdere la bellezza originale.