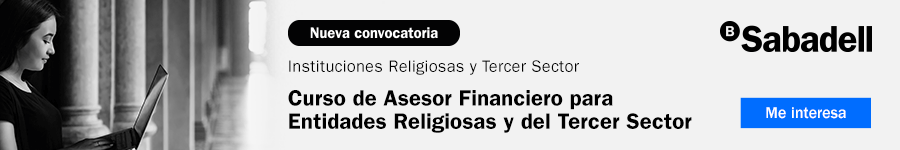Nella liturgia maronita, il canto nella preghiera è un modo di accarezzare Dio nostro Signore; è un modo tenero e dolce di rivolgersi a Lui con melodie che esprimono il sentimento umano della Tradizione e delle Sacre Scritture. Non ha i criteri occidentali di razionalizzazione della musica, ma tende a essere affettiva (del cuore), con un linguaggio poetico e, per molti versi, improvvisato.
Canto siro-antiocheno e canto monastico
Il canto maronita è un canto siro-antiocheno (siriaco di Antiochia) e monastico. Questi sono i due elementi fondamentali che ne definiscono l'identità.
Il fatto che si tratti di un canto siro-antiocheno è dovuto al fatto che la Chiesa maronita - una delle 24 chiese sui iuris della Chiesa cattolica; la Chiesa sui iuris La più diffusa è la Chiesa latina - che appartiene alla tradizione liturgica siriaca di Antiochia - la prima sede petrina - e quindi i suoi canti tradizionali sono in aramaico (siriaco) e semitico.
Va sottolineato che tra i vari repertori dei diversi rami delle Chiese siro-antiochene, l'affinità musicale è diversa tra i gruppi e gli strati che compongono i repertori di ciascuna Chiesa siriaca antiochena. Il canto siriaco antiocheno maronita mantiene la propria originalità e peculiarità rispetto agli altri canti delle altre Chiese siriache (sia siriache cattoliche che siriache ortodosse).
La nascita di tre riti
La Chiesa di Antiochia, a partire dal V secolo - a causa delle discussioni cristologiche dell'epoca - diede gradualmente origine a tre riti indipendenti: il rito siro-antiocheno orientale (seguito dalle Chiese assira, caldea e malabarese); il rito siro-antiocheno occidentale non calcedoniano (seguito dalle Chiese siriaca e malankarese); e il rito siro-antiocheno occidentale calcedoniano (seguito solo dalla Chiesa maronita, tutta cattolica e senza ramo ortodosso). La Chiesa maronita, a causa della sua unità e fedeltà al Papa di Roma, si isolò gradualmente dal resto delle Chiese siriache antiochene fino a formare una propria gerarchia patriarcale a partire dal VII secolo, con San Giovanni Marone come unica Chiesa orientale unita a Roma pur conservando la successione di San Pietro ad Antiochia.
La lingua utilizzata nel canto maronita siro-antiocheno è l'aramaico nel suo dialetto siriaco (lingua sviluppatasi nella regione di Edessa) e, sebbene la sua origine risalga al I secolo, le sue testimonianze manoscritte si trovano a partire dal II-III secolo, ad esempio negli inni di Bardaisan (+222), di Efrem il Siriaco (+373), di Balai (+ ca. 432), di Narsai (+502) o di Giacomo di Serugh (+521). 432), di Narsai (+502) o di Giacomo di Serugh (+521).
Nel XIII secolo, una bolla di Papa Innocenzo III del 1215 chiedeva ai maroniti di adottare alcune usanze romane, il che portò la Chiesa maronita a subire un periodo di latinizzazione della sua liturgia che, paradossalmente, non intaccò il suo canto, poiché il canto, essendo la preghiera del cuore del popolo maronita e parte della sua identità, ha permesso di conservare fino ad oggi sia la sua lingua liturgica (l'aramaico) che le sue melodie originali. Inoltre, a partire da quel secolo, la storia scritta del canto maronita è rimasta muta, poiché solo il manoscritto dell'Ufficio dei Morti (Manoscritto siriaco vaticano 59), e alcuni commenti alla musica siriaca del vescovo giacobita Gregorio Bar Hebræus (+ 1286).
Ciò permette di affermare che il canto maronita è stato mantenuto in vita solo oralmente fino a quasi il XIX secolo, quando padre Jean Parison registrò nel 1899 la prima annotazione musicale in uno studio scientifico della lingua e della musica siriaca dei riti maronita, caldeo e siriaco. Da allora sono stati prodotti spartiti e scritti sulla musica maronita, come quelli di Fratel Marie-André Chaptini (1924), Padre Boulos Ashqar (1939), Yaacoub Fayyad (1947), Padre Youssef Khoury (1992), Padre Louis Hage (1976), Padre Miled Tarabay (1998) e Suor Marana Saad (2010), solo per citarne alcuni.
Il carattere monastico del canto maronita è dovuto alla sua origine. Fu il monastero di Beth-Maron (monastero di San Marone), fondato intorno al 452 ad Apamea sulle rive del fiume Oronte, dove i monaci di Antiochia vivevano e svolgevano la loro vita liturgica e spirituale. L'intera giornata era un canto di lode a Dio nostro Signore; non smettevano di cantare giorno e notte. Si alternavano, e i laici venivano a cantare con loro, secondo le loro occupazioni, per unirsi alla preghiera. La vita spirituale della regione era così fervente che la vita del popolo e la sua unità con i monaci ruotavano intorno al monastero. Ciò ha permesso di conservare la musica come parte integrante della società fin dall'infanzia e nella famiglia. Inoltre, serviva come metodo di catechesi, perché i testi delle canzoni, pieni di dottrina, contenevano l'insegnamento della fede cristiana e l'amore per la Vergine Madre di Dio.
Il canto maronita: un poema in melodia
Le melodie consistono in una base melodica improvvisata, cioè i testi scritti in prosa sono cantati in un processo di improvvisazione senza chiare istruzioni per la loro esecuzione o interpretazione, e in questo modo la prosa diventa, quando viene cantata, una sorta di poesia.
Tuttavia, il resto dei canti non in prosa è poetico, cioè il canto maronita è una poesia scritta in aramaico (siriaco). La poesia è strofica e ogni strofa assume una costruzione uguale o simile, in cui si tiene conto del metro poetico e dello schema strofico, e ogni canto ha un nome proprio.
Il canto maronita è costituito da due modelli metrici poetici: la metrica per quantità e la metrica per numero di sillabe. La metrica poetica per quantità tiene conto del carattere lungo e breve delle sillabe nei versi. La metrica poetica per numero di sillabe si divide in due categorie: l'omotonia, in cui si contano le sillabe sottolineate di un verso senza considerare il numero totale di sillabe; e l'isosillabica, in cui si contano tutte le sillabe del verso, indipendentemente dal loro carattere sottolineato o atono.
Il modello strofico del canto maronita
Il modello strofico di base è chiamato rish qolo -Frase aramaica che in inglese significa "testa dell'inno", ed è considerata il punto di riferimento per suonarla in tutto l'inno. La funzione del rish qolo è sia per indicare la versificazione o la struttura poetica delle strofe, sia per indicare la melodia legata allo schema strofico. I canti maroniti sono organizzati per nomi, cioè i nomi delle strofe. rish qolo dei modelli strofici portano un nome proprio che indica il metro del poema, la funzione liturgica, l'archetipo dell'inno o il modo di esecuzione. A questi nomi si può aggiungere un sottotitolo che indica il luogo dell'ufficio liturgico in cui viene cantato, le prime parole del poema originale o la parola del canto precedente per conoscere la sequenza.
Per spiegare meglio questa organizzazione per nome del rish qoloVengono presentati i seguenti esempi di nomi di modelli strofici di alcuni canti maroniti: la ramremain -significa "esaltiamo" in aramaico-, è un modello strofico di funzione liturgica che serve a introdurre le letture; il bo'uto dmor efremsignifica "Supplica di Sant'Efrem", è un nome che fa riferimento alla metrica di 7+7 sillabe; la sedro -che significa "linea" in aramaico, è un nome che indica la struttura di un tipo di preghiera liturgica, la qole yawnoye -che in aramaico significa "inno greco", è un nome che rimanda all'archetipo dell'inno, il lhudoye -che significa "solitari" in aramaico-, che indica il modo di eseguirlo; ecc.
Esempi di sottotitoli che possono essere forniti sono: il mazmur -che significa "salmo" in aramaico, che indica un tipo di salmodia per l'ufficio liturgico; il tubayk 'idto -che significano "benedetta sei tu, o Chiesa" in aramaico, che sono le prime parole della melodia; il korozuto -che significa "proclamazione" in aramaico, che segna la sequenza all'interno della liturgia.
Categorie poetiche (o melodie)
Le categorie poetiche (o melodie) del canto maronita classificano i tipi di utilizzo del canto. Tuttavia, questa categorizzazione poetica non è sempre facile da distinguere, poiché la differenza non risiede solo nella metrica o in un attributo specifico e ben definito, ma può essere dovuta al significato del testo o al suo uso liturgico o ai modelli strofici o alla combinazione di più caratteristiche.
Tra le categorie poetiche si citano, a titolo esemplificativo e senza essere le uniche, le seguenti: la madrosho -che significa "istruzione" in aramaico-, è un antico genere lirico in stile pedagogico e serve a istruire nella fede. sughito - che significa "ode" in aramaico, è un genere lirico popolare cantato in forma di dialogo con un personaggio drammatico, spesso in strofe acrostiche. bo'uto -che significa "supplica" in aramaico, è un genere lirico che designa un componimento poetico in forma di strofe con una metrica ben definita; il mimro - che in aramaico significa "omelia metrica", è un genere lirico di omelie cantate; ulito -che significa "lamento" in aramaico, è un genere lirico che riguarda specifiche funzioni o circostanze liturgiche, ad esempio quelle cantate durante i funerali; il qolo -che significa "voce" in aramaico-, è un genere lirico di inno cantato; ecc.
È importante notare che quando si cantano le melodie siriache, si usano versioni alternative della stessa melodia con testi diversi. Si tratta cioè della stessa melodia, ma il testo varia. Ad esempio, in un bo'uto dmor yacoub -Significa "supplica di Giacomo" in aramaico, ed è un bo'uto la cui metrica è di 4+4+4 sillabe - si canta nel ciclo liturgico dell'Epifania con testi che riguardano il battesimo del Signore, ma nel ciclo liturgico della Resurrezione si canta con testi che si riferiscono alla Pasqua, ecc.
Tutte le categorie poetiche sono di solito cantate alternativamente in due cori (una strofa è cantata da un gruppo e l'altra dall'altro gruppo).
Caratteristiche del canto maronita
Il canto siriaco maronita, essendo un canto antico, tradizionale, liturgico e comunitario della Chiesa maronita, si trova nei testi liturgici fin dai primi tempi, e ha gradualmente assunto uno stile proprio che lo distingue, come già detto, dai canti delle altre tradizioni liturgiche siriache; È arrivato a noi praticamente per tradizione orale, perché, come già detto, è stato scritto pochissimo, eppure è rimasto in gran parte immutato, e quindi si è conservato con la sua peculiare originalità fino ai giorni nostri.
In termini di espressione, la melodia non ha quasi alcuna relazione con il testo, poiché quest'ultimo ha troppe strofe e la melodia ha troppo poche note.
In termini di metro, la melodia di solito abbraccia la struttura del verso e il suo metro. Ha una forte affinità sia con l'antico canto sacro delle chiese siro-antiochene sia con i canti profani, popolari e tradizionali dei Paesi del Medio Oriente.
Il canto siriaco maronita è sillabico, cioè ogni sillaba porta una nota, ad eccezione dell'ultima e talvolta della penultima sillaba, che portano più note.
Essendo una musica tonale, sia il modo (la diversa disposizione degli intervalli della scala) che la scala stessa (la successione diatonica delle note) possono non essere distinti, ma sono due aspetti molto diversi. Per quanto riguarda la scala del canto maronita, per il modo si può seguire il criterio di una scala diatonica temperata di semitoni uguali, o quello di una scala orientale dei 24 "quarti di tono" uguali, o quello di una compatibilità della scala diatonica e della scala non diatonica. Ma non bisogna dimenticare che la scala del canto maronita era originariamente non temperata.
L'intervallo di seconda maggiore, minore o neutro è di gran lunga l'intervallo più utilizzato nella musica maronita. L'altezza, ascendente o discendente, può essere "perfetta" o diminuita; il semitono può essere diatonico o leggermente aumentato.
La gamma è molto limitata; nella maggior parte dei casi si limita a tre, quattro o cinque note. Più di cinque note sono molto rare. Aggiungendo talvolta una nota all'acuto o al grave, le gamme raggiungono una sesta minore.
Nella musica maronita esistono vari processi di movimento melodico, anche se il più comune inizia con la tonica in Si (B), cioè la prima nota di una scala musicale. Le melodie che terminano in Do (C) possono iniziare ordinariamente con un Do (C), un Mi (E), un Fa (F) o un Sol (G). Quelle che terminano in D (D) iniziano normalmente con un D (D), un F (F) o un G (G), ed eccezionalmente con un E (E), un A (A) o un C (C). Le melodie che terminano in Mi iniziano normalmente con un Mi o un Sol, ed eccezionalmente con un Do, un Re o un Fa.
Il movimento graduale della melodia, così come la frequenza di alcune note principali, soprattutto la tonica, facilitano il canto comunitario. Queste melodie, così composte, sottolineano che non sono destinate a essere eseguite da un solista o addirittura da un coro, ma devono essere cantate dall'assemblea dei fedeli. In effetti, tutti possono partecipare al canto dell'Ufficio divino, perché le melodie sono semplici e facili.
La centonizzazione è la tecnica più utilizzata nel canto siro-maronita, cioè la composizione di melodie a partire da materiale melodico esistente; quindi, la composizione di un brano maronita è una centonizzazione organizzata di formule melodiche esistenti e conosciute. Queste formule sono spesso ripetute, a volte in modo ordinato e a volte in modo casuale, ma non appaiono mai da sole o allo stato puro.
L'altra tecnica di composizione del canto siriaco maronita è stata quella dell'adattamento, che consiste nell'adattare un nuovo testo a una melodia già esistente. A volte l'adattamento è identico all'originale, altre volte è adattato per adattarlo meglio.
Il canto è monodico, cioè privo di armonia.
Il repertorio siro-maronita non lascia spazio al oktoíjos (sistema di scrittura musicale composto da otto modi) e i suoi equivalenti.
L'esecuzione e l'interpretazione del canto siriaco maronita presuppone e richiede - e questo è assolutamente fondamentale e molto importante - che l'assemblea preghi mentre canta, perché si tratta di una preghiera cantata per parlare a Dio. L'interpretazione si basa sulla memoria e sul suo sapore storico e non sulla teoria o notazione musicale, quindi viene più dal cuore che dalla ragione. Il canto maronita è un canto popolare (per essere cantato dal popolo: monaci e laici), semplice, ripetitivo, con circa 150 melodie e, sempre e ovunque, una forma di preghiera.
Parroco della parrocchia maronita di San Chárbel, in Messico.