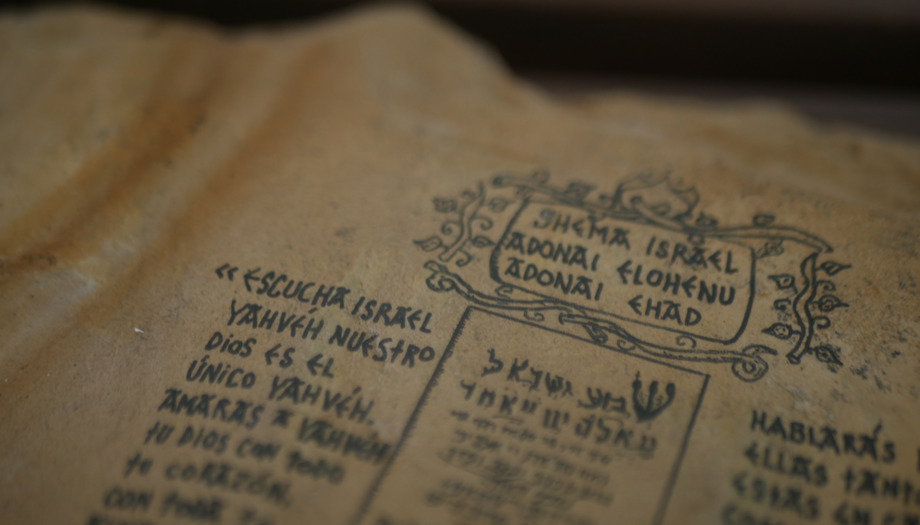Spesso si pensa che a parlare di Gesù di Nazareth siano solamente le Sacre Scritture cristiane e che non ci siano altri indizi o riferimenti a lui al di fuori di queste. Non è così!
Se, infatti, da un lato abbiamo le fonti cosiddette “canoniche” (cioè quei testi accettati e riconosciuti dalla Chiesa cattolica come ispirati da Dio e dunque sacri: i quattro Vangeli canonici, gli Atti degli Apostoli, le Lettere paoline) dall’altro abbiamo quelle non canoniche, che possiamo suddividere in non cristiane e cristiane (in quest’ultimo gruppo troviamo quelle chiamate “apocrife”, cioè i Vangeli apocrifi, gli Àgrafa e i Lògia). Vi sono poi le fonti archeologiche, che sono una categoria a parte.
In questo articolo tratteremo brevemente le fonti non cristiane e quelle cristiane non canoniche.
Fonti non evangeliche: documenti storici non cristiani
Tra queste fonti si trovano accenni a Gesù o soprattutto ai suoi seguaci. Sono opera di antichi autori non cristiani, come Tacito, Svetonio, Plinio il Giovane, Luciano di Samosata, Marco Aurelio, Minucio Felice. Allusioni a Gesù di Nazareth si leggono pure nel Talmud babilonese. Le informazioni fornite da tali fonti, però, non si rivelano particolarmente utili, perché non forniscono notizie dettagliate su Gesù.
Talora, anzi, volendo sminuire la sua importanza o la legittimità del culto da lui nato, vi si riferiscono in modo impreciso e calunnioso, parlandone, ad esempio, come figlio di una pettinatrice, o di un mago, oppure ancora di un certo Pantera, nome che è una trascrizione e un’interpretazione erronea del termine greco parthenos (vergine), utilizzato già dai primi cristiani in riferimento alla persona di Cristo, figlio della Vergine.
I documenti storici non cristiani, tuttavia, permettono già di avere delle conferme circa l’esistenza di Gesù di Nazareth, sebbene attraverso notizie frammentarie.
Il Testimonium Flavianum
Tra tutti i documenti storici non cristiani su Gesù di Nazareth, il più celebre è senza dubbio il Testimonium Flavianum, dell’autore ebreo Giuseppe Flavio (37 circa-100 circa).
Il brano in questione si trova all’interno dell’opera Antichità giudaiche (XVIII, 63-64). Fino al 1971, ne circolava una versione che si riferiva a Gesù di Nazareth con termini considerati eccessivamente sensazionalistici e devoti per un ebreo osservante qual era appunto Giuseppe Flavio. Si sospettava, infatti che la traduzione greca sino ad allora conosciuta fosse stata rimaneggiata dai cristiani.
Nel 1971, il professor Shlomo Pinés (1908-1990), dell’università ebraica di Gerusalemme, ne pubblicò poi una traduzione diversa, conforme a una versione da lui rinvenuta in un manoscritto arabo del X secolo, la Storia universale di Agapio di Gerapoli (morto nel 941). È un testo considerato maggiormente attendibile, dato che non vi si individuano possibili interpolazioni, e oggi è universalmente considerato la più antica testimonianza su Gesù di Nazareth in una fonte non cristiana (l’opera Antichità giudaiche risale al 94 d.C.).
Ecco il passo: “Ci fu verso quel tempo un uomo saggio che era chiamato Gesù, che dimostrava una buona condotta di vita ed era considerato virtuoso, e aveva come allievi molta gente dei Giudei e degli altri popoli. Pilato lo condannò alla crocifissione e alla morte, ma coloro che erano stati suoi discepoli non rinunciarono alla sua dottrina e raccontarono che egli era loro apparso tre giorni dopo la crocifissione ed era vivo, ed era probabilmente il Cristo del quale i profeti hanno detto meraviglie”.
Lo stesso Giuseppe Flavio descrive, sempre in Antichità giudaiche (XX, 200), la lapidazione dell’apostolo Giacomo (a capo della comunità cristiana di Gerusalemme): «Anano (il sommo sacerdote Anna) [...] convocò il sinedrio a giudizio e vi condusse il fratello di Gesù, detto il Cristo, di nome Giacomo, e alcuni altri, accusandoli di trasgressione della legge e condannandoli alla lapidazione». Questa descrizione combacia con quella riportata dall’apostolo Paolo nella lettera ai Galati (1,19). In un altro passo (XCIII, 116-119) lo storico indica la figura di Giovanni il Battista.
Altra importante testimonianza è quella del pagano Tacito, il quale, nei suoi Annali (intorno all’anno 117 d.C.), trattando di Nerone e dell’incendio di Roma del 64 d.C., riferisce (XV, 44) che l’imperatore, per sviare le voci che lo volevano colpevole del disastro che aveva quasi totalmente distrutto la capitale dell’Impero, ne avesse dato la colpa ai cristiani, conosciuti allora dal popolo come crestiani: “L’autore di questa denominazione, Cristo, sotto l’impero di Tiberio era stato condannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato; ma, repressa per il momento, l’esiziale superstizione erompeva di nuovo, non solo per la Giudea, origine di quel male, ma anche per l’Urbe, ove da ogni parte confluiscono e sono esaltate tutte le cose atroci e vergognose”.
Fonti non evangeliche: documenti cristiani non canonici
Àgrafa e Lògia
Gli Ágrafa, cioè “non scritti”, sono brevi detti o aforismi attribuiti a Gesù e che, tuttavia, sono stati tramandati al di fuori della Sacra Scrittura (Grafè) in generale o dei Vangeli in particolare (per es. la frase «Si è più beati nel dare che nel ricevere», che Paolo riporta in Atti 20, 35 ma che non si trova in alcuno dei Vangeli).
Analogo discorso può essere fatto per i Lògia (detti), anch’essi brevi sentenze attribuite al Nazareno, in ciò del tutto simili agli Àgrafa, salvo per il fatto che questi ultimi sono rinvenuti più tipicamente in opere dei Padri della Chiesa (autori della letteratura patristica, per es. Atanasio, Basilio Magno, Gregorio Nazianzeno, Giovanni Crisostomo, Girolamo, Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno, Giovanni Damasceno) o riportati in antichi documenti come i papiri, quali quelli di Ossirinco (tra il I e il VI secolo d.C., ritrovati in Egitto tra il XIX e il XX sec. e contenenti frammenti di autori come Omero, Euclide, Livio, ecc).
Sono fonti non considerate del tutto autorevoli, da un punto di vista storico.
Vangeli apocrifi
Eccoci finalmente a parlare dei Vangeli apocrifi. Con questo termine, che deriva dal greco ἀπόκρυϕος (apocryphos, cioè “occulto”, “segreto” e per estensione, di autore ignoto) s’intendono quei numerosi (una quindicina) ed eterogenei scritti su Gesù di Nazareth che non rientrano nel canone biblico cristiano per svariati motivi:
- tardività rispetto ai Vangeli canonici (in media un secolo di differenza: per i Vangeli canonici si parla di redazione risalente alla seconda metà del I secolo d.C., per gli apocrifi metà del sec. II);
- forma testuale distinta da quella canonica (i Vangeli canonici si riconoscono per l’organicità espressiva e linguistica e lo stile semplice e scevro di sensazionalismi, mentre gli apocrifi per l’alone leggendario e fiabesco);
- trasmettono dottrine in contrasto con quelle ufficiali (sono spesso documenti gnostici costruiti “ad arte” per diffondere nuove dottrine e giustificare posizioni politiche e religiose di singoli o di gruppi).
I Vangeli apocrifi non sono però del tutto inattendibili (per es. il Protovangelo di Giacomo contiene racconti e tradizioni dell’infanzia di Gesù, della vita di Maria o di apostoli che sono entrati nell’immaginario popolare cristiano). Infatti, ci offrono una panoramica religiosa e culturale dell’ambiente del II secolo d.C. Tuttavia, le contraddizioni contenute, la non conformità con i testi considerati ufficiali, nonché le evidenti deficienze in materia di dottrina, veridicità e indipendenza delle fonti non permettono di attribuire loro autorevolezza da un punto di vista storico.