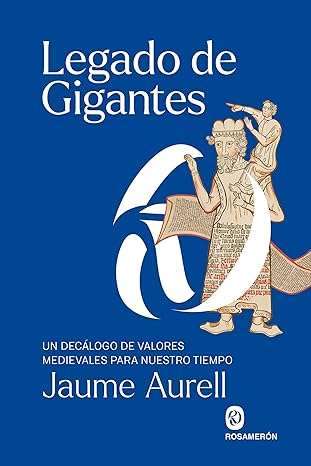Jaume Aurell (Barcellona, 1964), professore di Storia medievale all'Università di Navarra, ha appena pubblicato ".L'eredità dei giganti"Una magnifica opera sull'eredità del Medioevo che contrasta in larga misura la leggenda oscurantista di certe correnti storiografiche che, da Petrarca ai giorni nostri, hanno denigrato una parte importante della nostra storia, sotto il terribile nome di "Medioevo oscuro".
È infatti sulle "spalle dei giganti" (p. 15), come si diceva allora, che camminiamo e prevediamo, in ogni periodo della storia, guardando dall'alto, i passi e i percorsi da fare per andare avanti, perché ogni tappa della vita umana porta alla grande tradizione della Chiesa e della società un insieme di valori e di contributi che contribuiscono allo sviluppo della dignità della persona umana.
Indubbiamente, la prima grande lezione del Medioevo è stata quella di ripercorrere l'invasione dei popoli germanici dal V secolo al XV secolo (cfr. 28), quando è iniziato il Rinascimento e poi è arrivato l'umanesimo cristiano della Scuola di Salamanca, che è durato fin quasi ai giorni nostri.
Sulle spalle dei giganti
In quei dieci secoli in cui si sono fusi il cristianesimo, il diritto romano e la filosofia greca; Roma, il Golgota e Atene, per dare origine a una nuova civiltà ben diversa dall'Impero romano, piena di più luci che ombre, anche se logicamente molto ricca di contrasti (cfr. 39).
Il nostro autore svilupperà con grande abilità, anche se a grandi linee, i punti salienti del Medioevo: l'atmosfera cosmopolita (cfr. 51), l'intenso rapporto tra fede e ragione (cfr. 53) e i chiostri e i monasteri in cui si conservavano fede e cultura (cfr. 58).
Senza dubbio ci sono voluti molti secoli per sradicare il paganesimo e per recuperare il livello di dignità della persona umana che Sant'Agostino ha sviluppato nel suo indimenticabile "De civitate Dei", dove spiegava che la caduta dell'Impero romano era dovuta a tre motivi: in primo luogo, alle debolezze e alla decadenza dell'uomo, in secondo luogo, per far capire che la Chiesa non era legata a un unico modello di civiltà e, infine, per provocare i cristiani con i loro concittadini a costruire nuove culture e nuove civiltà.
Università
Si soffermerà poi sui tanti momenti salienti del Medioevo, in particolare sull'origine delle Università, quelle corporazioni di studenti e professori uniti nella ricerca della verità sempre nuova e sempre bella. Spiegherà anche brevemente l'intersezione tra clero regolare e clero secolare, tra teologi e canonisti, tra filosofi e teologi, cioè le scuole teologiche e le relazioni tra i vari campi del sapere.
Il rapporto tra coloro che cercano la verità è un insegnamento vivo che la verità richiede contemplazione, studio e dialogo, perché, come si affermerà secoli dopo, il cuore ha ragioni che la ragione non comprende. O più semplicemente: la verità è poliedrica.
Il professor Aurell commenterà alcuni dipinti e sculture di diverse epoche e diversi luoghi d'Europa e lo farà con grande maestria per spiegare che la storia del pensiero si esprime attraverso argomenti, libri e pensiero orale, ma anche attraverso l'arte.
L'ampia esposizione dell'arte romanica e gotica ci offrirà il miglior Aurell, cioè un professore che è diventato un maestro di storia e non un professore mediocre che sa cosa deve spiegare per sapere.
Cattedrali
È proprio nel capitolo su "l'Europa delle cattedrali" (p. 81) che l'opera diventa più magistrale, così come nella scomposizione del passaggio della cosiddetta innovazione teologica dai conventi alle scuole cattedrali e palatine.
Infatti, l'accesso all'istruzione per i figli della nobiltà, della borghesia e dei figli della nobiltà portò alla diffusione delle università in tutta Europa. Poiché la lingua era il latino e i libri dovevano essere copiati a mano, il sapere si globalizzò e fu anche ingenuamente copiato l'uno dall'altro.
La nascita delle Università parla di persone dedite al mondo della conoscenza e dell'insegnamento: "Gli eroi fondatori delle Università" (p. 72), ma parla anche di pace, di benessere, di mercato e delle leggi del mercato, di lavoro onesto e di trasporto delle merci.
In realtà, perché la ricerca della verità apra la strada, è necessario aver recuperato la dignità della persona umana e quindi il concetto di figli di Dio nella vita spirituale e nel concerto dei popoli e delle nazioni, e soprattutto nell'apertura della ricerca della verità nella scienza e della "prospettiva nell'arte". In altre parole, andare oltre (cfr. 111).
Punti salienti
La seconda parte del libro è un saggio nel saggio e richiama i dieci punti salienti del Medioevo o le linee di forza da seguire per caratterizzare un nuovo racconto del Medioevo.
Il riassunto telegrafico sarebbe il seguente: spirito contemplativo; pratica di non essere pratici; moderazione; "Noblesse oblige"; aspirazione all'eroismo; riforma più che rivoluzione; apprezzamento della tradizione; capacità di sorridere; permanenza dei classici e cortesia.
Insomma, con questi valori e l'ampia esposizione che ha fatto, il professor Aurell ha preparato l'ampio indice di un nuovo libro che potrebbe consistere in un nuovo racconto del Medioevo.
L'eredità dei giganti: Un decalogo di valori medievali per il nostro tempo