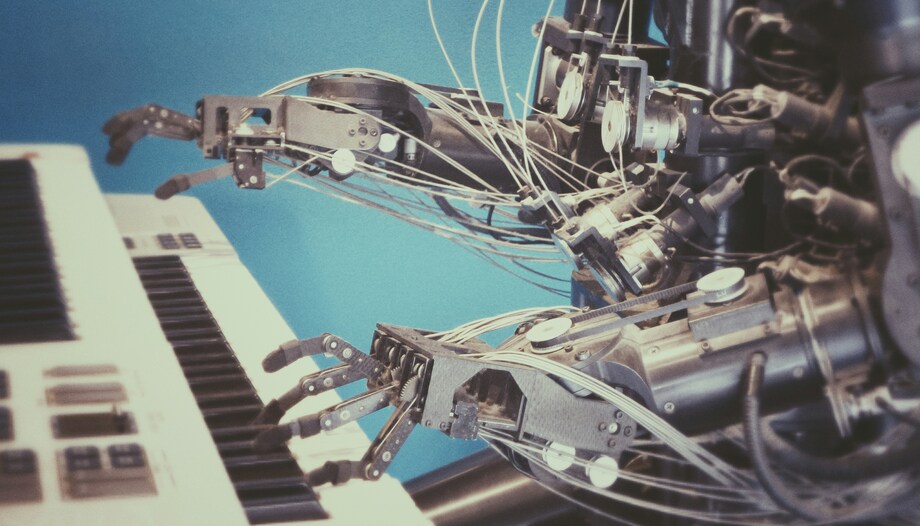Il titolo di questo contributo può sorprendere. Gli enormi progressi compiuti negli ultimi anni nel campo dell'Intelligenza Artificiale (IA) l'hanno resa una realtà in quasi tutti i settori dell'attività umana. Dal riconoscimento delle immagini alla generazione di testi, fino alla capacità di identificare modelli nascosti in una moltitudine di dati, l'IA è oggi uno strumento indispensabile per la società. La sua capacità di trovare nuove strategie di risoluzione dei problemi attraverso l'apprendimento profondo e la sua crescente velocità di elaborazione delle informazioni la rendono un compagno di viaggio sicuro per gli esseri umani di oggi e di domani.
Tuttavia, nonostante i suoi occasionali successi, non sembra che l'Intelligenza Artificiale possa mai sviluppare un'intelligenza generale simile a quella naturale di cui godiamo noi umani. Attualmente, l'Intelligenza Artificiale è piuttosto un insieme di "Intelligenze Artificiali" al plurale: vari algoritmi supportati da diverse reti neurali artificiali, ognuna specializzata nella risoluzione di problemi simili ma specifici.
Umanizzare l'intelligenza artificiale
Quindi, al di là di trovare soluzioni ingegnose a determinati compiti, l'intelligenza artificiale ha qualcosa da dire su ciò che significa essere umani? Può essere una maestra di umanità? A questo punto, verranno sicuramente in mente i problemi generati da un uso immorale di questa tecnologia. Non dovremmo piuttosto concentrarci su quei valori umani che dovrebbero essere inclusi, per quanto possibile, nelle diverse intelligenze artificiali?
Certamente l'uso dell'Intelligenza Artificiale deve essere umanizzato. Ben vengano le direttive e le iniziative che, a livello personale, sociale e politico, possono essere messe in atto per limitare le conseguenze di un uso improprio di questo potente strumento. Proteggiamo i nostri dati personali, combattiamo la pirateria e mettiamo dei filtri su Internet per evitare che i più vulnerabili accedano a contenuti dannosi. C'è una crescente consapevolezza di questo aspetto in quasi tutti i settori e si stanno compiendo passi nella giusta direzione. Allo stesso tempo, la definizione di quadri giuridici per i potenziali rischi dell'intelligenza artificiale, pur essendo necessaria ed essenziale, non deve farci perdere di vista la posta in gioco. Per quanto ben intenzionata, la legalità da sola non può impedire l'uso improprio dell'Intelligenza Artificiale ad ogni costo.
Tuttavia, questo non è direttamente l'obiettivo delle riflessioni. Affermando che l'Intelligenza Artificiale è una maestra dell'umanità, le considerazioni si spingono a un livello più profondo: cosa ci insegna l'Intelligenza Artificiale sul nostro nucleo umano più profondo? La contemplazione dei progressi tecnologici può aiutarci a ripensare e rivalutare ciò che significa essere umani? Credo di sì, anche se le conseguenze pratiche non sono immediatamente visibili.
Artificiale e naturale
L'intelligenza artificiale è un prodotto dell'intelligenza umana. Esiste un'opposizione frontale tra naturale e artificiale che ci permette di capire meglio noi stessi rispetto alle macchine? È dubbio, perché in un certo senso è naturale per gli esseri umani produrre artefatti. L'artificiale è in molti casi uno sviluppo e un completamento del naturale. Inoltre, il confine tra le due aree non è sempre chiaro: un essere vivente concepito artificialmente, modificato geneticamente, curato o migliorato da protesi o prodotti artificiali è artificiale? I confini possono essere sfumati. Tuttavia, il mito del mostro di Frankenstein dovrebbe ricordarci che la biologia negli esseri umani non sembra essere casuale.
Inoltre, e in modo più radicale, il fatto che l'uomo derivi da un'evoluzione naturale che dura da milioni di anni può suggerire perché non sia così facile "produrre" persone. La necessità dell'evoluzione per la comparsa di esseri intelligenti sulla Terra (e non sappiamo se su altri pianeti) è un segno evidente che il carattere biologico degli esseri umani non è un mero oggetto di scena, come vorrebbero pensare alcuni transumanisti radicali, ma una condizione necessaria e determinante.
Per vedere se un'Intelligenza Artificiale prodotta può aspirare ad avvicinarsi agli esseri umani, sarebbe necessario "lasciarla evolvere" senza ostacoli o restrizioni di alcun tipo. Ma questo non sembra essere ciò che vogliamo con l'Intelligenza Artificiale. L'intelligenza artificiale è sempre qualcosa che viene sottratto al flusso evolutivo della natura per raggiungere fini specifici. Le chiediamo al nostro tostapane e al nostro smartphone, ognuno al proprio livello. In questo senso, l'artificiale non è mai naturale.
La questione dei fini
Le considerazioni precedenti ci portano a un secondo punto, spesso dimenticato dagli strenui sostenitori di un'IA in grado di superare l'essere umano: la questione dei fini. Che cos'è un fine? Cosa significa avere dei fini? Sebbene la scienza moderna abbia accantonato la questione dello scopo in natura, paradossalmente gli scopi riappaiono quando cerchiamo di comprendere il comportamento degli esseri viventi, che agiscono quasi sempre in vista di qualcosa.
Negli esseri viventi, gli scopi nascono naturalmente: sono inscritti nella loro natura, si potrebbe dire. L'intelligenza artificiale, invece, opera sempre sulla base di uno scopo esterno imposto dai programmatori. A prescindere dal fatto che, attraverso l'apprendimento profondo, possano apparentemente emergere nuovi "fini" nelle varie Intelligenze Artificiali, nessun prodotto porta in sé l'inclinazione verso uno scopo.
Nel caso dell'essere umano, la questione dei fini appare più chiaramente in relazione alla capacità di canalizzare il proprio desiderio di completamento. La persona ha desideri naturali che mirano a fini che la completano e la completano. Ora, qual è il fine ultimo dell'uomo? La risposta generica a questa domanda è la felicità (prospettiva etica classica), la santità o la comunione con Dio (prospettiva credente) o l'aiuto generico agli altri (prospettiva filantropica). Il punto chiave è che tale fine non è predeterminato in modo concreto. Piuttosto, a seconda delle fasi della vita e dei contesti in cui una persona vive, il modo di concepire il fine generale viene interpretato e sviluppato in modi diversi. Non esiste quindi un determinismo teleologico.
Intelligenza artificiale, determinismo e libertà
Qualcuno potrebbe obiettare che, in futuro, se avremo una versione quantistica dell'IA, anche questa potrebbe non avere questo determinismo. Ma ciò significherebbe non cogliere il punto dell'argomento, che non riguarda tanto i processi deterministici quanto la vita. Vivere significa essere in grado di stabilire nuovi fini in nuovi contesti, dati dall'ambiente, e di concatenare i nuovi fini con quelli precedenti, nella storia singolare e irripetibile di ogni essere vivente.
Questo processo è particolarmente vero per gli esseri umani, perché implica l'uso della libertà come autodeterminazione: la capacità di volere in modo coerente con la propria storia personale ciò che l'intelligenza presenta come bene.
Il processo teleologico nell'uomo è massimamente creativo, perché ogni persona è in grado di riconoscere e volere come bene umano ciò che è sotteso e nascosto in ogni situazione di vita. È la libertà creativa di un essere spirituale che, vivendo nel "qui e ora", è in grado di trascenderlo: è in grado di mettere il "qui e ora" in relazione con l'intera vita, anche se in modo imperfetto. Questo è vivere umanamente e questo, in ultima analisi, è crescere come individuo della specie umana. Non sembra che l'IA, indipendentemente dal suo supporto fisico, funzioni in questo modo. Nessuna IA vive, perché risolvere problemi concreti, imposti dall'esterno, non è la stessa cosa che vivere e porsi problemi.
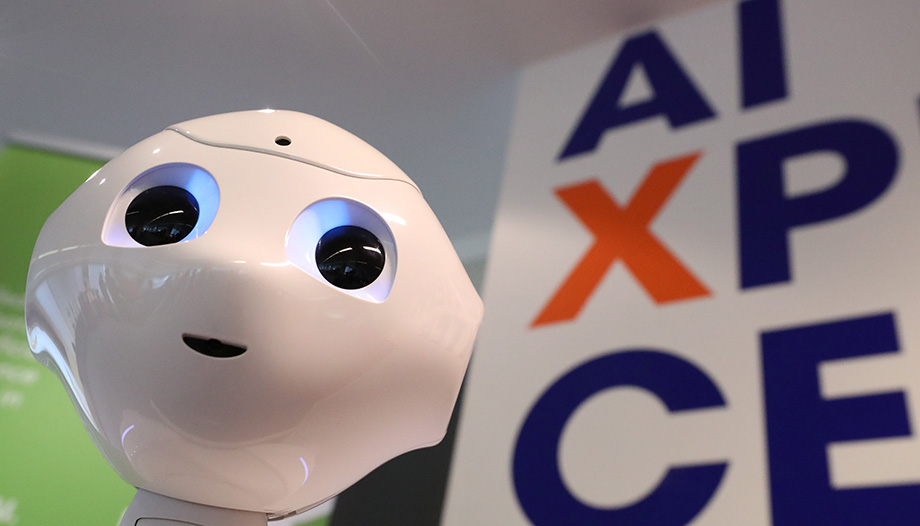
I limiti della conoscenza
La questione dei fini e della vita è strettamente legata alla conoscenza. Infatti, molti autori hanno difeso una continuità di fondo nella natura, una proporzionalità diretta tra vita e conoscenza. Il modo di percepire il mondo è specifico e particolare per ogni essere vivente, in quanto parte essenziale del suo modo di vivere, di essere nel mondo.
Nel caso degli esseri umani, il loro essere nel mondo raggiunge un'estensione praticamente illimitata. Sebbene i sensi esterni funzionino entro una certa gamma di stimoli, gli esseri umani sono in grado di andare oltre, grazie alla loro intelligenza, e sanno che ci sono più cose di quelle immediatamente percepite. Ad esempio, siamo in grado di "vedere" oltre lo spettro visibile delle radiazioni elettromagnetiche o di "sentire" oltre lo spettro delle frequenze udibili da un essere umano. Inoltre, senza possedere alcun senso di gravità, possiamo rilevare le increspature nello spazio prodotte dalle interazioni tra buchi neri nella notte dei tempi.
Mentre ogni esperimento deve finire per offrire qualcosa di sensato allo sperimentatore, gli esseri umani sono in grado di rintracciare correlazioni fisiche in natura fino a limiti insospettabili. Gran parte di questa capacità si manifesta nei progressi della scienza, una delle conquiste più spirituali della nostra specie.
Tuttavia, una componente essenziale della conoscenza umana è la consapevolezza di essere limitata. Quella che può sembrare una contraddizione non lo è affatto. Il nostro desiderio di conoscere è potenzialmente illimitato, ma ne siamo consapevoli perché di solito sperimentiamo la conoscenza come limitata. Una conseguenza decisiva di ciò è ciò che comporta essere una persona integra: qualcuno che non confonde la propria conoscenza della realtà con la realtà stessa.
Intelligenza artificiale e malattia mentale
La conoscenza si riferisce alla realtà, ma non la esaurisce. Insieme ad altre capacità, la conoscenza umana è destinata ad estendersi in modo illimitato, ma non è mai illimitata nel presente. Ciò che si conosce, si sente o si sperimenta non è la realtà, dicono molti psicologi ai loro interlocutori. Non solo per riconoscere la loro finitudine, ma per ricordare loro che non sono i creatori della verità, nemmeno della verità sulla propria vita. Questo è il cuore di molte malattie mentali.
Può un'intelligenza artificiale ammalarsi in questo modo? No. Per la semplice ragione che nessuna Intelligenza Artificiale distingue tra la sua "conoscenza" e la realtà stessa. Qualcuno potrebbe obiettare che esistono Intelligenze Artificiali che "sentono": hanno sensori che ricevono informazioni sulla realtà e addirittura "scelgono" quali informazioni elaborare e quali no. Ma non è questo il problema. Il problema è che lo schema "input-processing-output" di un'IA è sempre chiuso in se stesso. Anche se si rende flessibile il contenuto di tale schema in modo che possa cambiare nelle iterazioni successive, in ogni momento esiste solo una triade di questo tipo per l'IA (o per l'hardware che esegue l'algoritmo, se si preferisce vederla in questo modo).
Rappresentazione e realtà
Non può esistere una differenziazione specifica per l'uomo tra conoscenza e realtà, per la semplice ragione che ogni essere umano nasce con un interesse per l'intera realtà, mentre l'IA viene prodotta con uno scopo particolare, anche se si tratta di simulare un certo "interesse" per i dati non elaborati, che finiscono per diventare un nuovo input nelle iterazioni degli algoritmi.
In larga misura, il successo dell'Intelligenza Artificiale contemporanea deriva dal superamento dei limiti di una prima IA che identificava rigidamente simboli e regole logiche con processi hardware fisici. È stato necessario un allentamento di questa identificazione perché l'Intelligenza Artificiale migliorasse drasticamente. Ma le Intelligenze Artificiali non saranno mai in grado di essere "sane di mente", di avere quello che Brian Cantwell Smith chiama "buon giudizio" ("...").La promessa dell'intelligenza artificiale: la resa dei conti e il giudizio"L'obiettivo è conoscere i suoi limiti e stabilire il corretto rapporto tra la conoscenza, in quanto rappresentazione, e la realtà. I sistemi che non sono in grado di comprendere il significato delle loro rappresentazioni non si relazionano autenticamente con il mondo nel modo in cui le loro rappresentazioni lo rappresentano. Quest'ultima è una cosa che può avvenire solo a livello personale.

La dimensione religiosa
Infine, è interessante considerare la questione dei limiti della conoscenza potenzialmente illimitata nella sfera religiosa. I pensatori classici ritenevano che esistesse un desiderio umano naturale di vedere Dio, un paradosso che ha causato non pochi problemi alla teologia dei due ordini: naturale e soprannaturale. Questo paradosso ha causato non pochi problemi alla teologia dei due ordini: naturale e soprannaturale. Come combinare i due ordini? Come può esistere un desiderio naturale per una realtà soprannaturale?
Una teologia più incentrata sulle dinamiche delle relazioni personali che sulla concettualizzazione degli ordini sta facendo luce su questo problema classico. Questo problema rivela la curiosa combinazione di finitudine e infinito nella persona creata e, incidentalmente, ci ricorda che la dimensione religiosa è una componente intrinseca della natura umana. Il desiderio di infinito non sembra essere completamente spento nell'uomo, di dignità infinita, nonostante i tentativi delle filosofie nichiliste.
L'intelligenza artificiale ci insegna qualcosa sulla religiosità umana? Oggi le intelligenze artificiali specializzate nell'elaborazione del linguaggio sono in grado di fare grandi riassunti dei contenuti delle religioni, di costruire magnifiche omelie o di ricercare quasi istantaneamente i passi della Bibbia. Bibbia che meglio si adattano al nostro stato d'animo. Ma non hanno alcuna risposta sulla loro "propria" religiosità al di là di ciò che è permesso, direttamente o indirettamente, dai loro programmatori.
Alla ricerca di una vita piena
Anche se le Intelligenze Artificiali non ci istruiscono direttamente sul rapporto con Dio, le proiezioni umane che cercano di percorrere la strada che porterebbe all'umanizzazione delle macchine passano spesso attraverso la religione. Come dimenticare qui le scene finali del primo Blade Runner, quando il replicante Roy Batty inizia a prendere coscienza di sé e cerca il suo creatore per chiedere più vita? Roy è comprensibilmente deluso quando interroga il suo programmatore e si rende conto che il creatore umano non è così potente, non arriva a tanto. Decide quindi di metterlo a morte.
Perché Roy cerca l'immortalità? Perché ha vissuto e visto "cose che non potremmo nemmeno credere": una vita, la sua storia personale, piena di ricordi che restano con lui. Ma se ha una data di scadenza, tutti quei ricordi non solo "si perderanno come lacrime nella pioggia", ma diventeranno indistinguibili da qualsiasi altro processo naturale. Roy cerca quella vita piena e abbondante, in cui tutto ciò che ha vissuto non va perso, non è indifferente, e può acquisire il suo significato ultimo. Non è un insegnamento da poco su cosa significhi vivere umanamente.
Ricercatore del gruppo "Mente-Cervello" presso l'Istituto di Cultura e Società dell'Università di Navarra.