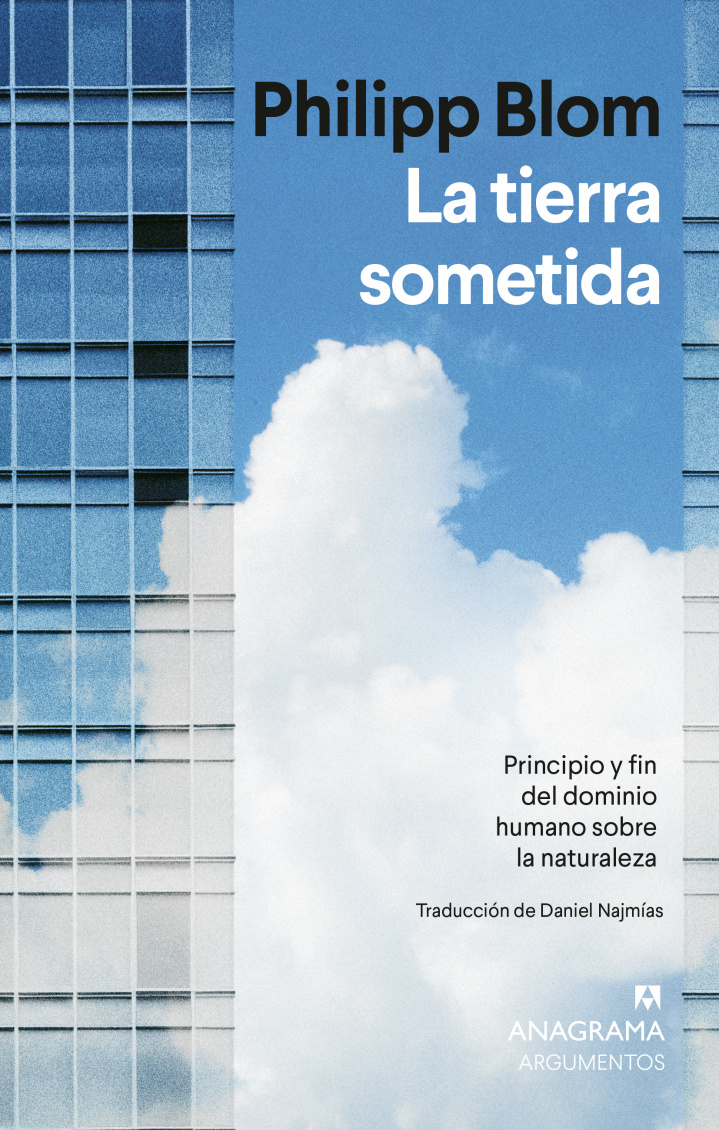Il rapporto dell'uomo con il mondo è stato interpretato in modi diversi nel corso della storia e, soprattutto, oggi abbiamo la netta sensazione di essere arrivati troppo tardi nel dominio dispotico della natura, come se fosse irrecuperabile e avessimo causato un deterioramento quasi irrimediabile. È in questo contesto che si muove questo straordinario lavoro dello storico Philipp Blom, sempre intelligente e con idee da apportare al dibattito intellettuale e alla scienza storica.
Tuttavia, egli parlerà sempre dalla storia delle idee, con profondità e rigore, nonostante i temi diversi e dispersi. La visita di Blom alla Sacra Scrittura e all'antichità classica è molto importante per verificare il peccato di idolatria del popolo ebraico (p. 63) insieme al comando di “sottomettere la terra” (p. 93).
La ragione al servizio della padronanza della natura
Per quanto riguarda Sant'Agostino e il suo famoso contributo nel trattato “de bono matrimonii” sulla concupiscenza, Blom ci ricorda la sua origine nel manicheismo e nel neoplatonismo, che spiegherebbe “l'ossessione per la sistematica greca, l'opposizione platonica ai piaceri carnali e la paranoia manichea” (p. 112).
Particolarmente interessante è lo studio di Blom su uno dei padri della scienza moderna, Francis Bacon (1561-1626), contemporaneo di Montaigne (1533-1592), ma molto più incisivo di lui nel sottomettere la terra con la ragione strumentale (p. 186). Ad esempio, nel suo “Novum Organum” ci dirà: “L'uomo, servo e interprete della natura, non opera né comprende se non in proporzione alle sue scoperte sperimentali e razionali delle leggi di quella natura: al di là di questo, non sa e non può sapere nulla” (p. 187).
Il Bacone parlamentare finì male, ma il “giurista e politico Bacone era un pensatore produttivo nelle sue conversazioni o nella corrispondenza con altri studiosi” (p. 188). Per questo Blom affermerà: “L'ambizione di Bacone andava oltre: non voleva solo essere un servitore della natura: aspirava anche, come Telesio, a dominarla imparando, a conoscerla dall'interno” (p. 192).
Blom concluderà questa breve sintesi del pensiero di Bacone con una citazione di Cartesio per chiudere un capitolo iniziato con la visione razionalista dell'anima animale (p. 178): “Cartesio riconosceva che la sua immagine della natura era basata anche sull'opinione e sugli interessi di massa, ma nei suoi libri la difese fino a esaurire l'inchiostro: solo l'uomo ha un'anima; il resto è basato sull'opinione e sugli interessi di massa. 178): ”Cartesio riconosceva che anche la sua immagine della natura era basata sull'opinione e sugli interessi di massa, ma nei suoi libri la difese fino a esaurire l'inchiostro: solo l'uomo ha un'anima; il resto della natura è composto da automi non senzienti che devono servire all'uomo, con l'aiuto della ragione, per compiere - padroneggiandola - la sua missione divina" (p. 193).
Si rivolge quindi a Baruch Spinoza (1632-1677), un autore talmente vituperato ai suoi tempi che difficilmente poteva essere citato nei dibattiti intellettuali perché considerato “sovversivo e scandaloso” (p. 194), in quanto sosteneva che “Dio è la materia e le leggi della natura, e il mondo, nella leggendaria formulazione di Spinoza, è deus sive natura, Dio o natura, due termini intercambiabili” (p. 196).
E ancora: “Da attento lettore di Montaigne e di Bacone, di Telesio e di Cartesio, Spinoza conosceva i modelli dei suoi predecessori e sviluppò la sua argomentazione con insuperabile eleganza, come se Montaigne avesse mosso la penna di Cartesio. La natura è un sistema infinitamente complesso, le cui leggi vengono aggirate e travisate per ignoranza o avidità” (p. 198). Alla fine Spinoza fu sepolto nell'indice dei libri proibiti, “tuttavia la sua opera affondò sotto il movimento generale verso il nuovo vangelo del dominio scientifico e razionale della natura, motore di nuovi profeti...” (p. 199).
L'Illuminismo non è mai stato una scuola di pensiero con dogmi vincolanti, a parte l'enfasi sulla ragione, un ottimismo di fondo e una certa tendenza elitaria che, tuttavia, aveva già molte facce diverse“ (p. 208). Inoltre, le diverse tendenze cominciarono a differenziarsi: ”L'illuminismo razionalista e moderato di un Immanuel Kant o di un Voltaire, di un Thomas Hobbes o di un Leibniz era, per i suoi non pochi oppositori, un attacco all'ordine del mondo tradizionale, anche se in realtà svolgeva anche la funzione opposta, perché in un mondo secolare infondeva nuova vita a molte idee centrali della tradizione teologica cristiana“ (p. 209).
Blom ricorda poi: “La maggior parte degli illuminati aveva ricevuto un'educazione cristiana e queste idee erano così familiari a loro e alle loro società che sembravano loro l'unica struttura di pensiero possibile. Sebbene gli autori illuministi attaccassero i dogmi cristiani, utilizzavano anche argomenti e immagini concettuali della tradizione cristiana per riscriverli a modo loro” (p. 211).
Logicamente, Philipp Blom doveva dedicare un capitolo al terremoto di Lisbona del 1° novembre 1755, che fece migliaia di vittime a Lisbona e nelle città vicine, allo tsunami che ne fece altre migliaia e, soprattutto, a un ampio e acceso dibattito filosofico, scientifico e teologico sul male fisico e morale (p. 219). La conclusione, per Blom, dopo aver esposto gli argomenti kantiani, voltairiani o herderiani, è la seguente: “Lisbona divenne sinonimo della debolezza analitica della religione razionale. Almeno per l'élite colta, il terremoto del 1755 fu una scossa intellettuale” (p. 223).
E aggiunge: “Dopotutto, sia l'aristocrazia che la Chiesa traevano la loro legittimità da un mandato divino e dalla grazia di Dio (anche i ricchi calvinisti avevano imparato a considerare la loro prosperità come una prova del favore di Dio, che allo stesso tempo permetteva loro di non sentirsi responsabili per i poveri). Pertanto, qualsiasi ragionamento che mettesse in discussione l'ordine divino e togliesse al trono e alla Chiesa l'autorità della conoscenza e della morale era di per sé un atto rivoluzionario” (p. 224).
Da un lato, Kant portò i suoi contemporanei alla disperazione, in quanto la sua filosofia affermava che con l'esperienza sensoriale dell'essenza del mondo era impossibile percepire alcunché, e quindi anche nulla di una sperata verità spirituale, cioè di Dio, ma dall'altro lato, come Cartesio con il suo res cogitans, Ha creato uno spazio che lasciava spazio al mistero e al Creatore, un luogo che non sarebbe mai stato toccato dalla scienza” (p. 226).
Terra sommessa